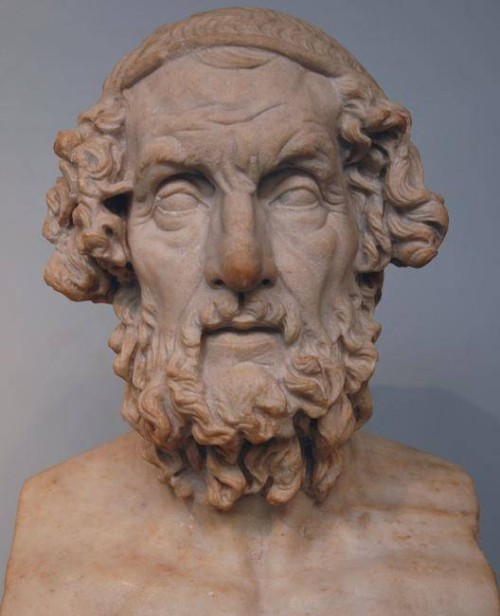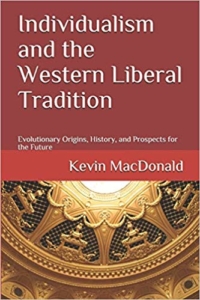Se… trattassimo Coming of Age in Samoa di Margaret Mead come utopia, non come etnografia, lo capiremmo meglio ed eviteremmo molte discussioni inutili. (Robin Fox 1989, 3)
Alcuni scrittori hanno commentato sui “cambiamenti radicali” verificatisi negli obiettivi e nei metodi delle scienze sociali in seguito all’ingresso degli ebrei in questi campi (Liebman 1973, 213; si veda anche Degler 1991; Hollinger 1996; Horowitz 1993, 75; Rothman & Lichter 1982). Degler (1991, 188 ss.) osserva che l’abbandono del darwinismo come paradigma fondamentale delle scienze sociali fu la conseguenza di uno spostamento ideologico anziché dell’emergere di nuovi dati empirici. Egli fa notare inoltre che gli intellettuali ebrei hanno avuto un ruolo determinante nel declino del darwinismo e di altre prospettive biologiche nell’ambito delle scienze sociali americane dagli anni ’30 in poi (p. 200). L’opposizione degli intellettuali ebrei al darwinismo è stata rilevata da tempo (Lenz 1931, 674; si vedano anche i commenti di John Maynard Smith in Lewin [1992, 43]).58
Nell’ambito della sociologia, l’arrivo degli intellettuali ebrei nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale ebbe come conseguenza “un livello di politicizzazione sconosciuta ai padri fondatori della sociologia. Non solo i nomi di Marx, Weber, e Durkheim sostituirono quelli di Charles Darwin e Herbert Spencer, ma quel senso dell’America come un’esperienza consensuale cedette il passo a un senso dell’America come una serie di definizioni contrastanti” (Horowitz 1993, 75). Nel secondo dopoguerra, la sociologia “si è popolata di ebrei a tal punto che abbondavano le barzellette: non c’era bisogno della sinagoga, il minyan [ossia il numero minimo di ebrei necessario per celebrare un servizio religioso collettivo] si poteva trovare nei dipartimenti di sociologia; né c’era alcun bisogno di una sociologia della vita ebraica, dal momento che le due erano diventate sinonime” (Horowitz 1993, 77). Effettivamente il conflitto etnico nella sociologia americana rispecchia in larga misura il conflitto etnico nell’antropologia americana, uno dei temi di questo capitolo. In questo caso, il conflitto era tra scienziati sociali ebrei di sinistra e un establishment protestante, di vecchia scuola e di orientamento empirico, il quale alla fine venne eclissato:
20
La sociologia americana è stata contesa dalle contrastanti asserzioni di coloro che erano afflitti dall’invidia per la fisica e quei ricercatori più interessati ai dilemmi della società. In questa lotta, i mandarini protestanti positivisti del Midwest si trovavano spesso in contrasto con gli ebrei dell’East Coast, a loro volto alle prese con i propri impegni marxisti; dall’estero, grandi ricercatori dediti alle analisi quantitative, come Paul Lazarfeld alla Columbia, cercavano di scuotere la condiscendenza dei ragionierucoli nativi. (Sennett 1995, 43)
Questo capitolo evidenzierà i fini etnopolitici di Franz Boas, ma merita menzione il lavoro dell’antropologo strutturalista franco-ebreo Claude Lévi-Strauss poiché questi sembra condividere le stesse motivazioni, sebbene il movimento strutturalista francese nella sua totalità non possa essere considerato un movimento intellettuale ebreo. Lévi-Strauss interagiva frequentemente con Boas e riconosceva la sua influenza (Dosse 1997 I, 15, 16). A sua volta, Lévi-Strauss era molto influente in Francia, tanto da essere descritto da Dosse (1997 I, xxi) come “il padre comune” di Michel Foucault, Louis Althusser, Roland Barthes, e Jacques Lacan. Aveva una forte identità ebraica e una profonda preoccupazione per l’antisemitismo (Cuddihy 1974, 151 ss.). In risposta all’affermazione che era “il ritratto perfetto dell’intellettuale ebreo”, Lévi-Strauss replicò:
Certe attitudini mentali sono forse più prevalenti tra gli ebrei che altrove… Attitudini che derivano da un profondo senso di appartenenza a una comunità nazionale, pur nella consapevolezza che in mezzo a questa comunità ci sono persone – sempre meno numerose, va riconosciuto – che ti respingono. Si rimane vigili, accompagnati dall’irrazionale sensazione che in ogni circostanza ci si debba adoperare più degli altri per disarmare potenziali critici. (Lévi-Strauss & Eribon 1991, 155-156).
Come molti intellettuali ebrei discussi in questa sede, gli scritti di Lévi-Strauss erano mirati a consacrare le differenze culturali e a sovvertire l’universalismo dell’Occidente, posizione che convalida la visione del giudaismo come gruppo non assimilante. Come Boas, Lévi-Strauss respingeva le teorie biologiche ed evoluzionistiche. Egli teorizzava che le culture, come le lingue, erano arbitrari insiemi di simboli senza alcuna relazione naturale con i loro referenti. Lévi-Strauss respingeva la teoria della modernizzazione occidentale in favore dell’idea secondo cui non esistevano società superiori. Il ruolo dell’antropologo era quello di essere “un sovversivo per natura o un convinto oppositore delle usanze tradizionali” (in Cuddihy 1974, 155) nelle società occidentali, rispettando e perfino idealizzando le virtù delle società non occidentali (si veda
21
Dosse 1997 II, 30). L’universalismo dell’Occidente e le idee sui diritti umani erano visti come maschere dell’etnocentrismo, del colonialismo, e del genocidio:
Le opere più importanti di Lévi-Strauss furono tutte pubblicate durante il disfacimento dell’impero coloniale francese e contribuirono enormemente al modo in cui esso veniva interpretato dagli intellettuali… I suoi eleganti scritti operavano una trasformazione estetica sui suoi lettori, i quali venivano scaltramente indotti a vergognarsi di essere europei… Egli evocava la bellezza, la dignità, e l’irriducibile stranezza delle culture del Terzo mondo che cercavano semplicemente di preservare le loro differenze… I suoi scritti avrebbero presto alimentato tra la nuova sinistra il sospetto … che tutte le idee universali alle quali l’Europa professava fedeltà – la ragione, la scienza, il progresso, la democrazia liberale – costituissero armi culturalmente specifiche studiate per sottrarre all’Altro non-europeo la propria differenza. (Lilla 1998, 37)
Degler (1991, 61) sottolinea il ruolo di Franz Boas nella trasformazione anti-darwiniana delle scienze sociali americane: “È molto difficile esagerare l’influenza di Boas sugli scienziati sociali americani nelle questioni di razza.” Boas si impegnò “per tutta la vita in un attacco contro l’idea della razza come fonte essenziale delle differenze riscontrabili nelle capacità mentali o sociali dei gruppi umani. Egli riuscì nel suo intento principalmente grazie alla sua incessante, quasi implacabile espressione del concetto di cultura” (p. 61). “Boas, quasi esclusivamente da solo, sviluppò in America quel concetto di cultura che, come un potente solvente, col tempo avrebbe espunto la razza dalla letteratura delle scienze sociali” (p. 71).
Boas non arrivò a questa posizione attraverso una disinteressata ricerca scientifica su una questione spinosa e controversa… Senza dubbio era fortemente interessato a raccogliere prove ed elaborare argomenti che confutassero o contestassero una visione ideologica – il razzismo – da lui giudicata restrittiva per gli individui e indesiderabile per la società… sussiste un persistente interesse ad imporre i suoi valori sociali alla professione e al pubblico. (Degler 1991, 82-83)
Come fa notare Frank (1997, 731), “La preponderanza di intellettuali ebrei nei primi anni dell’antropologia boasiana e l’identità ebraica degli antropologi nelle generazioni successive sono state minimizzate ad arte nella storia convenzionale della disciplina.” Le identificazioni ebraiche e il perseguimento di interessi percepiti come ebraici, particolarmente nel promuovere un’ideologia di pluralismo culturale come modello per le società occidentali, sono stati “l’argomento invisibile” dell’antropologia americana – invisibile perché le identificazioni etniche e gli interessi etnici dei
22
suoi sostenitori sono stati mascherati da un linguaggio della scienza nell’ambito della quale tali identificazioni e interessi erano pubblicamente illegittimi.
Boas crebbe in una famiglia “ebraico-progressista” in cui gli ideali rivoluzionari del 1948 rimasero influenti.59 Assunse una “posizione progressista… scientifica e nel contempo politica” (Stocking 1968, 149). Boas si sposò all’interno del suo gruppo etnico (Frank 1997, 733) e fin da giovane era fortemente preoccupato dall’antisemitismo (White 1966, 16). Alfred Kroeber (1943, 8) descrive un episodio “apparentemente rivelato da [Boas] in confidenza, tuttavia non attestabile… secondo cui, sentendo un insulto antisemitico in un caffè, cacciò fuori chi lo aveva pronunciato e venne sfidato a duello. Il mattino successivo il suo avversario si volle scusare ma Boas insistette perché il duello si facesse. Apocrifo o meno, il racconto calza a pennello il carattere del personaggio come lo conosciamo noi in America.” In un commento che la dice lunga sull’identificazione ebraica di Boas, come pure sulla sua opinione dei gentili, alla domanda su come potesse intrattenere rapporti professionali con antisemiti come Charles Davenport, Boas replicò “Se noi ebrei dovessimo decidere di lavorare esclusivamente con gentili che siano certificati al cento percento come non-antisemiti, con chi potremmo mai lavorare?” (in Sorin 1997, 632 n 9). Per di più, come accadeva sovente tra gli intellettuali ebrei di diverse epoche storiche, Boas era profondamente estraniato dalla cultura gentile e vi era ostile, in particolare verso l’ideale culturale dell’aristocrazia prussiana (Degler 1991, 200; Stocking 1968, 150). Volendo persuadere Boas a permetterle di fare le sue ricerche nelle isole del Pacifico meridionale, Margaret Mead “escogitò un modo sicuro per fargli cambiare idea. ‘Sapevo che c’era qualcosa che aveva a cuore più della direzione presa dalla ricerca antropologica: era il suo innato bisogno di comportarsi da uomo moderno, progressista, democratico, non da autocrate prussiano.’ Lo stratagemma funzionò, perché era riuscita a scoprire l’essenza dei suoi valori personali” (Degler 1991, 73).
Si può concludere che Boas aveva una forte identificazione ebraica e nutriva una profonda preoccupazione per l’antisemitismo. In base a quanto segue, è lecito supporre che tale preoccupazione abbia avuto un’influenza significativa sullo sviluppo dell’antropologia americana.
In effetti, è difficile non constatare che il conflitto etnico abbia svolto un ruolo importante nello sviluppo dell’antropologia americana. Le opinioni di Boas erano in conflitto con l’idea allora prevalente che le culture si fossero evolute in una serie di stadi etichettati come inciviltà, barbarie e civiltà. Questi stadi erano associati alle differenze razziali, e la moderna cultura europea (e in modo particolare, si suppone, l’odiata aristocrazia prussiana) si collocava al vertice di questa graduatoria. Secondo la descrizione offerta da Wolf (1990, 168) l’attacco dei boasiani metteva in discussione “il monopolio politico e morale di un’élite [gentile] che aveva giustificato il proprio regno affermando che la loro virtù superiore era l’esito del processo evolutivo.” Le teorie di Boas miravano inoltre a confutare le teorie razziali
23
di Houston Stewart Chamberlain (si veda SAID [Separation and Its Discontents. La separazione e i suoi scontenti, N.d.T.], cap. 5) e gli eugenisti americani come Madison Grant, il cui libro The Passing of the Great Race (1921, 17) [La scomparsa della grande razza, N.d.T.], criticava aspramente la ricerca di Boas in merito alle influenze ambientali sulle dimensioni craniali. Il risultato emerso era che “in termini di messaggio e scopo, [l’antropologia di Boas] era una scienza esplicitamente antirazzista” (Frank 1997, 741).
Grant caratterizzava gli immigrati ebrei come spietatamente egoistici, mentre i nordici americani stavano commettendo un suicidio razziale, lasciandosi cacciare “a gomitate” dalle loro terre (1921, 16, 91). Grant credeva inoltre che gli ebrei fossero impegnati in una campagna per screditare la ricerca razziale:
È pressoché impossibile pubblicare sui giornali americani qualsiasi riflessione su certe religioni o razze, le quali sono istericamente sensibili persino quando vengono citate per nome… All’estero, le condizioni sono altrettanto cattive, e abbiamo l’autorevolezza di uno dei più eminenti antropologi della Francia che la raccolta di misure e dati antropologici tra le reclute francesi allo scoppio della Grande guerra fu impedita dall’influenza degli ebrei, con l’obiettivo di sopprimere qualsiasi accenno al differenziamento razziale in Francia. (1921, xxxi-xxxii)
Un’importante tattica della scuola boasiana era quella di sollevare dubbi sulle teorie generali dell’evoluzione umana, come quelle che implicavano sequenze di sviluppo, enfatizzando la vasta diversità e le caotiche minuzie del comportamento umano, nonché il relativismo degli standard di valutazione culturale. I boasiani sostenevano che le teorie generali dell’evoluzione culturale dovevano attendere una dettagliata catalogazione della diversità culturale, ma in realtà da questo corpus di ricerche, nel successivo cinquantennio del suo dominio della professione, non sono emerse teorie generali (Stocking 1968, 210). Dato il suo rifiuto di attività scientifiche fondamentali quali la generalizzazione e la classificazione, l’antropologia boasiana può essere meglio descritta come un’anti-teoria piuttosto che come una teoria della cultura umana (White 1966, 15). Inoltre Boas si opponeva alla ricerca sulla genetica umana – ciò che Derek Freeman (1991, 198) definisce la sua “antipatia oscurantista nei confronti della genetica.”
Boas e i suoi studenti erano fortemente motivati a promuovere un programma ideologico all’interno della professione dell’antropologia americana (Degler 1991; Freeman: Torrey 1992). Boas e i suoi colleghi condividevano un senso di identità di gruppo, un impegno verso una prospettiva comune, e un programma mirato a dominare la struttura istituzionale dell’antropologia (Stocking 1968, 279-280). Erano un gruppo compatto con un preciso programma intellettuale e politico piuttosto che cercatori individualisti della verità disinteressata. La sconfitta dei darwiniani “non era arrivata senza la considerevole esortazione di ‘ogni Pinco Pallino’ che lottava per ‘la cosa giusta.’ Né era stata conseguita senza esercitare una pressione piuttosto forte sia
24
sugli amici fedeli sia sui ‘fratelli più deboli’ – spesso attraverso la sola forza della personalità di Boas” (Stocking 1968, 286).
Già nel 1915 i boasiani controllavano l’American Anthropological Association e detenevano una maggioranza di due terzi del suo consiglio di amministrazione (Stocking 1968, 285). Nel 1919 Boas poté dichiarare che “la maggior parte del lavoro antropologico attualmente svolto negli Stati Uniti” proveniva dai suoi studenti della Columbia (in Stocking 1968, 296). Nel 1926 tutti i più importanti dipartimenti di antropologia erano capeggiati dagli studenti di Boas, in maggioranza ebrei. Il suo protetto Melville Herskovits (1953, 23) osservò che i quaranta anni di cattedra [di Boas] alla Columbia garantirono continuità al suo insegnamento, permettendogli di formare studenti che sarebbero poi andati a costituire una parte sostanziale dell’importante nucleo professionale degli antropologi americani e che avrebbero presidiato e diretto la maggior parte dei più prestigiosi dipartimenti di antropologia degli Stati Uniti. A loro volta, essi formarono poi gli studenti che… portano avanti la tradizione nella quale i loro professori furono formati.
Secondo Leslie White (1966, 26), gli studenti più influenti di Boas erano Ruth Benedict, Alexander Goldenweiser, Melville Herskovits, Alfred Kroeber, Robert Lowie, Margaret Mead, Paul Radin, Edward Sapir, e Leslie Spier. Tutti i membri di questo “gruppo piccolo e compatto di accademici… radunati intorno al loro leader” (White 1966, 26) erano ebrei, fatta eccezione per Kroeber, Benedict e Mead. Frank (1997, 732) fa inoltre menzione di diversi altri illustri studenti ebrei di Boas appartenenti alla prima generazione (Alexander Lesser, Ruth Bunzel, Gene [Regina] Weltfish, Esther Schiff Goldfrank, e Ruth Landes). La famiglia di Sapir era fuggita dai pogrom in Russia per trasferirsi a New York, città il cui lo yiddish era la sua madrelingua. Benché non religioso, mostrò un crescente interesse per le questioni ebraiche sin dall’inizio della sua carriera, impegnandosi successivamente nell’attivismo ebraico, in particolare nella fondazione di un importante centro d’istruzione ebraica in Lituania (Frank 1997, 735). Anche il background di Ruth Landes mostra il nesso etnico del movimento boasiano. La sua era una famiglia di spicco nella subcultura di sinistra di Brooklyn, e fu presentata a Boas da Alexander Goldenweiser, amico intimo di suo padre nonché preminente allievo di Boas.
In contrasto con la motivazione ideologica e politica di Boas, l’ambientalismo militante di Kroeber e la sua difesa del concetto di cultura erano “esclusivamente teorici e professionali’ (Degler 1991, 90). Né i suoi scritti privati né quelli pubblici riflettono l’attenzione per le politiche pubbliche riguardanti i neri o la questione generale della razza nella vita americana che sono così evidenti nella corrispondenza professionale di Boas e nelle sue pubblicazioni. Kroeber respingeva la razza come categoria analitica con tanta convinzione e decisione quanto Boas, ma giunse a questa posizione attraverso la teoria e non l’ideologia. Kroeber sosteneva che “il nostro obiettivo è quello di promuovere l’antropologia anziché lottare per la tolleranza in altri campi” (in Stocking 1968, 286).60
25
Un altro influente allievo di Boas era Ashley Montagu (si veda Shipman 1994, 159 ss.). Nato Israel Ehrenberg, Montagu era un ben noto paladino della lotta contro l’idea dell’esistenza di differenze razziali nelle capacità mentali. Era anche molto cosciente di essere ebreo, dichiarando in un’occasione che “se si è cresciuti come ebrei, si sa che tutti i gentili sono antisemiti… Credo che questa sia una buona ipotesi di partenza” (in Shipman, 1994, 166). Montagu sosteneva che la razza fosse un mito di costruzione sociale. Gli esseri umani sarebbero congenitamente collaborativi (ma non congenitamente aggressivi) ed esisterebbe tra loro una fratellanza universale – un’idea per molti estremamente problematica all’indomani della seconda guerra mondiale. Degno di nota è anche Otto Klineberg, professore di psicologia alla Columbia. Klineberg era “instancabile” e “geniale” nel confutare la realtà delle differenze razziali. Alla Columbia subì l’influenza di Boas, al quale dedicò il suo libro Race Differences, pubblicato nel 1935. Klineberg “si assunse l’obiettivo di fare per la psicologia ciò che il suo amico e collega alla Columbia [Boas] aveva fatto per l’antropologia: espungere dalla sua disciplina le spiegazioni razziali delle disparità sociali tra gli uomini” (Degler 1991, 179).
A questo riguardo, è interessante notare come i membri della scuola boasiana che acquisirono maggiore notorietà pubblica fossero due gentili, Benedict e Mead.61 Così come in diversi altri celebri casi storici (si veda capp. 3, 4; SAID, cap. 6), erano i gentili a diventare il volto pubblico di un movimento dominato da ebrei. Difatti Boas, come Freud, reclutava i gentili nel suo movimento perché era preoccupato “che la sua ebraicità potesse far apparire la sua scienza parziale e, pertanto, compromessa” (Efron 1994, 180).
Fu Boas a ideare la classica ricerca di Margaret Mead sull’adolescenza a Samoa tenendo in mira la sua utilità nell’ambito del dibattito sulla distinzione tra i fattori innati e appresi che infuriava in quel periodo (Freeman 1983, 60-61, 75). Da questa ricerca emerse Coming of Age in Samoa [Adolescenza in Samoa, N.d.T.] – saggio che rivoluzionò l’antropologia americana orientandola verso l’ambientalismo radicale. Il suo successo era essenzialmente da attribuire alla sua promozione da parte degli studenti di Boas nei dipartimenti di antropologia delle università americane più prestigiose (Freeman 1991). Quest’opera e Patterns of Culture [Modelli di cultura, N.d.T.] di Ruth Benedict esercitarono una notevole influenza anche su altri scienziati sociali, psichiatri, e il grande pubblico, tanto che “già dalla metà del ventesimo secolo, era luogo comune per gli americani colti fare riferimento alle differenze umane in termini culturali e sostenere che ‘la scienza moderna ha dimostrato che tutte le razze umane sono uguali’” (Stocking 1968, 306).
Boas raramente citava opere di studiosi esterni al suo gruppo se non per denigrarle mentre, come nel caso di Mead e Benedict, promuoveva strenuamente e citava il lavoro degli appartenenti alla sua cerchia. La scuola boasiana arrivò pertanto a riflettere in un microcosmo gli elementi chiave dell’ebraismo come strategia evolutiva di gruppo altamente collettivista: un alto grado di identificazione intragruppo, politiche di esclusione, e coesione nel perseguimento di interessi comuni.
26
L’antropologia boasiana, perlomeno durante la vita di Boas, presentava analogie con l’ebraismo tradizionale anche sotto un altro aspetto critico: era fortemente autoritaria e intollerante verso il dissenso. Come nel caso di Freud (si veda cap. 4), Boas era una figura patriarcale che sosteneva energicamente chi la pensava come lui ed escludeva gli altri: Alfred Kroeber considerava Boas “un vero patriarca” che “agiva da forte figura paterna, apprezzando e sostenendo coloro con i quali si identificava nella stessa misura in cui riteneva che si identificassero genuinamente con lui ma che, nei confronti degli altri, era distante e probabilmente del tutto indifferente, gelido e ostile laddove richiesto dalle circostanze” (in Stocking 1968, 305-306). “Boas possiede tutti gli attributi del capo di un culto, un insegnante e maestro carismatico e venerato, ‘letteralmente adorato’ dai discepoli la cui ‘costante fedeltà’ è stata ‘effettivamente accertata’” (White 1966, 25-26).
Come nel caso di Freud, agli occhi dei suoi discepoli praticamente tutto ciò che faceva Boas aveva un’importanza monumentale e giustificava la sua consacrazione tra i giganti intellettuali di tutti i tempi. Come Freud, Boas non tollerava divergenze teoriche o ideologiche con i suoi allievi. Quanti non concordavano con il leader o avevano conflitti personali con lui, come Clark Wissler e Ralph Linton, venivano semplicemente estromessi dal movimento. White (1966, 26-27) descrive l’estromissione di Wissler e Linton come etnicamente connotata. Entrambi erano gentili. White (1966, 26-27) suggerisce altresì che l’essere ‘non ebreo’ aveva influito sull’esclusione di George A. Dorsey dal gruppo di Boas, nonostante i suoi vigorosi sforzi di diventarne membro. Kroeber (1956, 26) racconta come George A. Dorsey, “gentile nato in America nonché dottore di ricerca della Harvard, cercava invano di farsi ammettere nel gruppo.” Un aspetto di questo autoritarismo di Boas era il suo ruolo determinante nell’eliminare completamente la teoria dell’evoluzione dall’antropologia (Freeman 1990, 197).
Boas era scettico per eccellenza e ardente sostenitore del rigore metodologico quando si trattava di teorie di evoluzione culturale e di influenze genetiche sulle differenze individuali, eppure “l’onere della prova pesava poco sulle sue spalle” (White 1966, 12). Sebbene Boas facesse le sue congetture in modo molto dogmatico (come Freud; si veda cap. 4), “le sue ricostruzioni storiche consistono in inferenze, supposizioni e asserzioni non provate [che spaziano] dal possibile all’assurdo. Quasi nessuna è verificabile” (White 1966, 13). Benché fosse un nemico implacabile della generalizzazione e della costruzione teorica, Boas accettava pienamente “l’assoluta generalizzazione alla quale era giunta [Margaret] Mead dopo qualche mese di ricerca sul comportamento adolescenziale a Samoa”, nonostante i risultati di Mead fossero in contraddizione con le precedenti ricerche nel campo (Freeman 1983, 291). Inoltre, Boas lasciava che Ruth Benedict distorcesse i propri dati sui Kwakiutl senza muovere alcuna critica (si veda Torrey 1992, 83).
L’intera iniziativa pertanto può essere considerata un movimento politico fortemente autoritario incentrato su un leader carismatico. I risultati riscossero
27
un successo straordinario: “La professione nel suo complesso era unita entro una singola organizzazione nazionale di antropologi di orientamento accademico. Prevalentemente, questi condividevano una visione comune dell’importanza fondamentale rivestita dalla varietà delle culture umane storicamente condizionate nella determinazione del comportamento umano” (Stocking 1968, 296). La ricerca sulle differenze razziali si arrestò, ed eugenisti e teorici quali Madison Grant e Charles Davenport furono esclusi completamente dalla professione.
Già dalla metà degli anni ’30, la posizione boasiana sulla determinazione culturale del comportamento umano esercitava una forte influenza sugli scienziati sociali in generale (Stocking 1968, 300). I seguaci di Boas sarebbero poi diventati tra i più influenti sostenitori accademici della psicoanalisi (Harris 1968, 431). Marvin Harris (1968, 431) osserva che la psicoanalisi veniva abbracciata dalla scuola boasiana per la sua utilità come strumento di critica della cultura euroamericana e, in effetti, come si vedrà nei capitoli successivi, essa costituisce un veicolo ideale per la critica culturale. Nelle mani della scuola boasiana, la psicoanalisi fu completamente depurata dai suoi legami evoluzionistici e ci fu una maggiore accettazione dell’importanza delle variabili culturali (Harris 1968, 433).62
La critica culturale costituiva anch’essa un aspetto importante della scuola boasiana. Stocking (1989, 215-216) mostra che numerosi boasiani di rilievo, tra cui Robert Lowie e Edward Sapir, erano attivi nella critica culturale degli anni ’20, incentrata sulla percezione della cultura americana come eccessivamente omogenea, ipocritica, nonché repressiva sia sul piano emotivo che su quello estetico (particolarmente per quanto attiene alla sessualità). Una parte cardinale di questo programma consisteva nel creare etnografie di culture idilliache prive di quelle presunte caratteristiche negative attribuibili alla cultura occidentale. Tra questi boasiani, la critica culturale si cristallizzava in un’ideologia di “primitivismo romantico” secondo la quale certe culture non occidentali incarnavano le caratteristiche desiderabili che le società occidentali avrebbero dovuto emulare.
La critica culturale era una componente fondamentale delle due etnografie boasiane più note, Coming of Age in Samoa e Patterns of Culture. Queste opere non solo sono incorrette, ma distorcono in modo sistematico questioni cruciali legate agli approcci evoluzionistici al comportamento umano. Ad esempio, gli Zuni erano descritti da Benedict come immuni dalla guerra, dall’omicidio, e dalla brama di accumulare ricchezze. I figli non venivano disciplinati. Il sesso era praticato in modo disinvolto, con ben poca preoccupazione per la verginità, la possessività sessuale, o la certezza della paternità. Le società occidentali contemporanee sono naturalmente l’opposto di questi paradisi idilliaci, e Benedict raccomanda di studiare queste culture al fine di “esprimere giudizi in merito ai tratti salienti della nostra civiltà” (Benedict 1934, 249). L’analoga descrizione dei samoani offerta da Mead ignorò i dati palesemente contrari alla sua tesi che la stessa aveva raccolto (Orans 1996, 155). I comportamenti dei samoani considerati negativi, come lo stupro
28
e l’attenzione per la verginità, erano attribuiti all’influenza occidentale (Stocking 1989, 245).
Entrambi questi resoconti etnografici sono stati oggetto di critiche feroci. L’immagine delle società che ne emerge è decisamente più compatibile con le aspettative evoluzionistiche rispetto a quella delle società descritte da Benedict e Mead (si veda Caton 1990; Freeman 1983; Orans 1996; Stocking 1989). Nella polemica scoppiata sul lavoro di Mead, alcuni suoi difensori hanno sottolineato le possibili implicazioni politiche negative della demistificazione della sua opera (si veda, p. es. il sommario in Caton 1990, 226-227). Il contesto estremamente politicizzato delle questioni sollevate da queste ricerche resta pertanto invariato.
Una delle conseguenze del trionfo dei boasiani, infatti, è stata la quasi totale assenza di ricerche sulla guerra e sulla violenza tra i popoli studiati dagli antropologi (Keegan 1993, 90-94). La guerra e i guerrieri venivano ignorati, e le culture venivano concepite come costituite da fabbricanti di miti ed elargitori di doni. (Orans [1996, 120] mostra come Mead ha sistematicamente ignorato i casi di stupro, aggressione, rivoluzione e rivalità nel suo resoconto di Samoa.) Durante gli anni ’50, uscirono soltanto cinque articoli sull’antropologia della guerra. Significativamente, quando nel 1949 fu pubblicato Primitive Warfare [La guerra primitiva, N.d.T.], il volume di Harry Turney-High che documentava l’universalità della guerra e la sua ferocia spesso impressionante, il libro venne totalmente ignorato dalle facoltà di antropologia – ulteriore esempio delle tattiche di esclusione adottate contro i dissidenti della cerchia boasiana e tipico anche degli altri movimenti intellettuali esaminati in questo volume. I numerosi dati raccolti da Turney-High sui popoli non occidentali erano in contrasto con l’immagine degli stessi popoli prediletta da una professione altamente politicizzata i cui membri esclusero completamente questi dati dal discorso intellettuale. Ne risultò un “passato pacificato” (Keeley 1996, 163 ss.) e un “atteggiamento di autorimprovero” (p. 179) in cui il comportamento dei popoli primitivi veniva depurato, mentre il comportamento dei popoli europei veniva aspramente criticato non solo come eccezionalmente malvagio ma anche in quanto responsabile per gli esempi esistenti delle guerre tra i popoli primitivi. Da questa ottica, è soltanto la fondamentale inadeguatezza della cultura europea a impedire la realizzazione di un mondo idilliaco libero dal conflitto intergruppi.
La realtà, naturalmente, è ben diversa. La guerra era e continua ad essere un fenomeno ricorrente nelle società pre-statali. Gli studi rivelano che oltre il 90 percento delle società sono coinvolte in attività belliche, la grande maggioranza delle quali intraprendono operazioni militari almeno una volta all’anno (Keeley 1996, 27-32). Per di più, “ogni qual volta gli esseri umani moderni appaiono sulla scena, le prove definitive di violenza omicida diventano più comuni, dato un campione sufficiente di sepolture” (Keeley 1996, 37). A causa della sua frequenza e della gravità delle sue conseguenze, la guerra primitiva era più letale della guerra civilizzata. La maggior parte degli uomini adulti nelle società primitive e preistoriche partecipava alla guerra e “doveva combattere ripetutamente nel corso della vita” (Keeley, 1996, 174).
29
OLTRE BOAS: ESEMPI RECENTI DI RICERCA NELLE SCIENZE SOCIALI INFLUENZATA DAI PROGRAMMI POLITICI EBRAICI.
L’influenza ebraica sulle scienze sociali si estende ben oltre Boas e l’American Anthropological Association. Hollinger (1996, 4) nota “la trasformazione della demografia etnoreligiosa della vita accademica americana ad opera degli ebrei” nel periodo dagli anni ’30 agli anni ’60, nonché il condizionamento ebraico delle tendenze verso la laicizzazione della società americana e nel promuovere un’ideale di cosmopolitismo (p. 11). Fin dai primi anni ’40 questa trasformazione risultò in “un’intellighenzia secolare, sinistroide e crescentemente ebraica localizzata principalmente ma non esclusivamente nelle comunità disciplinari della filosofia e delle scienze sociali” (Hollinger 1996, 160). Già nel 1968, gli ebrei costituivano il 20 percento delle facoltà delle università e dei college americani di élite, e nella facoltà “più progressista” questa percentuale saliva al 30 percento. Al tempo, pur rappresentando meno del 3 percento della popolazione, gli ebrei costituivano il 25 percento delle facoltà di scienze sociali delle università più prestigiose e il 40 percento degli accademici progressisti con il maggior numero di pubblicazioni (si veda Rothman & Lichter 1982, 103). Gli accademici ebrei erano inoltre molto più propensi ad appoggiare i partiti “progressisti” o comunisti dagli anni ’30 agli anni ’50. Nel 1948, il 30 percento degli accademici ebrei votò per il Progressive Party, rispetto a meno del 5 percento degli accademici non ebrei (Rothman & Lichter 1982, 103).
Boas, che era socialista, è un buon esempio delle tendenze sinistroidi degli scienziati sociali ebrei, e molti suoi seguaci erano politicamente radicali (Torrey 1992, 57).63 Simili legami sono evidenti anche nel movimento psicoanalitico e nella Scuola di Francoforte per la Ricerca Sociale (si veda capp. 4, 5), come pure tra diversi critici della sociobiologia citati in questo capitolo (p.es. Jerry Hirsch, R. C. Lewontin e Steven Rose). Il fascino esercitato dalla sinistra sugli intellettuali ebrei è un fenomeno generale ed è tipicamente accompagnato da una forte identità ebraica e dallo scopo di perseguire interessi specificamente ebraici (si veda cap. 3).
Stephen Jay Gould e Leon Kamin sono ottimi esempi di queste tendenze. La prospettiva di Gould (1992) in relazione alle influenze sociali sulla teoria dell’evoluzione è stata menzionata in SAID (cap. 5), e Gould parrebbe un esempio perfetto di questa fusione tra interessi personali ed etnopolitici nella costruzione della scienza. Gould è stato un ardente e ben noto oppositore degli approcci evoluzionistici al comportamento umano. Come molti altri dei maggiori critici della sociobiologia (p. es. J. Hirsch, L. Kamin, R. C. Lewontin, e S. Rose; si veda Myers 1990), Gould è ebreo, e Michael Ruse (1989, 203) nota che uno dei temi più rilevanti dell’opera di Gould The Mismeasure of Man [Intelligenza e pregiudizio, N.d.T.] era il modo in cui le opinioni ereditarie sull’intelligenza erano state usate dai “fautori della supremazia teutonica” al fine di discriminare contro gli ebrei nella prima parte del secolo. Le opinioni di Gould
30
in merito ai dibattiti degli anni ’20 sul Q.I. e il loro legame con la questione dell’immigrazione e infine dell’Olocausto meriterebbero un esame approfondito. Esse illustrano come il talento da propagandista e attivista etnico possa essere unito a una posizione accademica molto eminente e prestigiosa al fine di esercitare una forte influenza sull’opinione pubblica in un campo di ricerca con importanti implicazioni per le politiche pubbliche.
Ruse fa notare che il libro di Gould fu scritto con passione e venne “ampiamente criticato” dagli storici di psicologia, suggerendo che Gould avesse permesso ai suoi sentimenti sull’antisemitismo di condizionare i suoi scritti scientifici relativi alle influenze genetiche sulle differenze individuali di intelligenza.
Ruse prosegue:
Non mi sembra completamente inverosimile suggerire che il fervore di Gould contro la sociobiologia umana fosse legato al timore che si trattasse di un ulteriore strumento potenzialmente utilizzabile per scopi antisemitici. Una volta lo interpellai a questo riguardo… Non scartava del tutto l’idea, ma era incline a pensare che l’opposizione derivasse dal marxismo, e come vuole il caso, la maggior parte dei marxisti americani proveniva da famiglie ebree dell’Europa dell’Est. Forse entravano in gioco entrambi i fattori. (Ruse 1989, 203).
I commenti di Gould evidenziano il fatto che il ruolo svolto dagli accademici ebrei nell’opposizione agli approcci darwiniani al comportamento umano era spesso accompagnato da un forte impegno per un programma politico di sinistra. Difatti, Gould ha riconosciuto che la sua teoria dell’evoluzione come equilibri punteggiati era per lui allettante in quanto marxista, perché presupponeva periodici sussulti rivoluzionari nell’evoluzione piuttosto che cambiamenti conservatori e gradualisti. Gould apprese il marxismo “sulle ginocchia del papà” (si veda Gould 1996a, 39), il che sembra indicare che fosse cresciuto come facente parte della subcultura marxista discussa nel capitolo 3. In un recente articolo, Gould nomina con nostalgia il Forward, un giornale yiddish politicamente radicale ma anche etnicamente cosciente (si veda cap. 3), dichiarando di ricordare che molti suoi parenti lo compravano ogni giorno. Come osserva Arthur Hertzberg (1989, 211-212), “chi leggeva il Forward sapeva che la risolutezza degli ebrei a rimanere ebrei era indubbia e indiscutibile.”
Sebbene non osservasse i rituali religiosi ebraici, la famiglia di Gould “abbracciava la cultura ebraica” (Mahler 1996). Un elemento comune della cultura ebraica era il senso di prevalenza storica dell’antisemitismo (si veda SAID, cap. 6), e la consapevolezza di Gould dell’oppressione storica degli ebrei emerge dalla sua recente recensione di The Bell Curve [La Curva a campana, N.d.T.] (Gould, 1994b), in cui egli respinge la visione di Herrnstein e Murray (1994) di una società socialmente coesa entro la quale tutti hanno un ruolo prezioso: “[Herrnstein e Murray] hanno dimenticato
31
l’ebreo di paese e gli abitanti dei quartieri poveri in molti di questi villaggi idilliaci.” Chiaramente Gould biasima le società storiche occidentali per non aver incluso gli ebrei nelle loro strutture sociali di armonia gerarchica e coesione sociale. Nel capitolo 8, si tornerà sulla questione dell’incompatibilità dell’ebraismo con questa forma peculiarmente occidentale di struttura sociale.
Kamin e Gould hanno un background culturale abbastanza simile, immerso nella subcultura ebraica di sinistra descritta più approfonditamente nel capitolo 3, e condividono con molti ebrei americani una forte avversione personale nei confronti della legislazione degli anni ’20 sull’immigrazione (si veda cap. 7). Kamin, figlio di un rabbino immigrato dalla Polonia, riconosce che “l’esperienza di crescere come ebreo in un piccolo paese prevalentemente cristiano lo aveva sensibilizzato in merito al potere dell’ambiente sociale nel formare la personalità” (Fancher 1985, 201) – commento che fa pensare anche che Kamin fosse cresciuto con una forte identità ebraica. Ad Harvard, Kamin si iscrisse al partito comunista e diventò l’editore del giornale di partito per il New England. Dopo le sue dimissioni dal partito, nel 1953 divenne un bersaglio delle udienze del sottocomitato del Senato condotte da Joseph McCarthy. Kamin fu accusato di oltraggio al Congresso per non aver risposto a tutte le domande del sottocomitato ma fu prosciolto per motivi tecnici. Fancher accenna alle “poche pretese di ‘obiettività’” dell’opera di Kamin sul Q.I. (p. 212), e ipotizza un legame tra il background di Kamin e la sua posizione sul Q.I.: “Senza dubbio ritenendo che la sua famiglia dell’Europa centrale [e, suppongo, altri ebrei] avrebbe potuto trovarsi esclusa dalle leggi restrittive sull’immigrazione, Kamin ha concluso che un’arrogante e infondata supposizione sull’ereditabilità del Q.I. avesse contribuito a produrre una politica sociale ingiusta negli anni ’20” (p. 208).
Kamin (1974a,b) e Gould (1981/1996a) erano in prima linea nella disseminazione di errate formazioni sul ruolo dei test del Q.I. nei dibattiti sull’immigrazione degli anni ’20. Snyderman e Herrnstein (1983; si veda anche Samelson 1982) dimostrano che Kamin e Gould falsarono lo studio di H. H. Goddard (1917) sul Q.I. degli immigrati ebrei cosicché indicasse che “l’83 percento degli ebrei, l’80 percento degli ungheresi, il 79 percento degli italiani e l’87 percento dei russi erano ‘deboli di mente’” (Kamin 1974, 16). Come osservano Snyderman e Herrnstein (1983, 987), “Il ‘fatto’ più spesso citato come prova del pregiudizio nativistico del Q.I. non era basato sui punteggi del Q.I., nemmeno il suo inventore lo considerava una rappresentazione precisa degli immigrati o una misura limpida delle capacità ereditate, e si avvaleva di un test già noto al tempo per la sua tendenza ad amplificare la debolezza mentale nella popolazione adulta di ogni sorta.” In realtà, Goddard (1917, 270) fece notare che “su questo punto non abbiamo dati, ma possiamo dedurre indirettamente che con maggiore probabilità la loro condizione sia attribuibile più all’ambiente che non all’eredità,” e citò il proprio lavoro che indicava che gli immigrati rappresentavano solo il 4,5 percento dei degenti degli istituti di cura per la salute mentale.
32
Degler (1991, 39) ritiene che Gould si fosse lanciato in un “ostinato inseguimento” di Goddard (p. 40), presentandone una falsa immagine come “rigido sostenitore dell’ereditarietà o elitista.” Gould tralasciò i dubbi e le riserve di Goddard, nonché le sue dichiarazioni sull’importanza dell’ambiente. È pressoché indubbio che in questo sforzo Gould stesse perpetuando una frode accademica: Degler (1991, 354 n16) fa notare che Gould citò Goddard poco prima del passo seguente e, pertanto, sapeva che le opinioni di Goddard sulla natura della debolezza mentale erano tutt’altro che rigide: “Siamo tuttora lontani dal credere che il caso [sul se la debolezza mentale sia un carattere unitario] sia chiuso. Il problema è troppo profondo per essere sbrigato con tanta leggerezza.” Ciononostante, Gould scelse di ignorare tale passo. Gould tralasciò anche i commenti di Degler nella sua revisione del 1996 di The Mismeasure of Man, discussa più dettagliatamente qui di seguito.
Inoltre, Kamin e Gould presentano un quadro assai esagerato e in larga misura falso dell’atteggiamento generale dei ricercatori responsabili dei test in relazione alla questione delle differenze intellettive tra diversi gruppi etnici nonché al ruolo dei test del Q.I. nei dibattiti nel Congresso di quell’epoca (Degler 1991, 52; Samelson 1975, 473; Snyderman & Herrnstein 1983) – quest’ultimo punto è confermato dalla mia lettura dei dibattiti. Difatti, la misurazione del Q.I. non fu mai menzionata né nel House Majority Report né nel Minority Report [Relazione di maggioranza e Relazione di minoranza del Congresso, N.d.T.]. (Il Minority Report fu redatto e sottoscritto da due congressisti ebrei, i deputati Dickstein e Sabath, i quali capeggiarono la battaglia contro il restrizionismo.) Contrariamente all’affermazione di Gould (1981, 232) secondo la quale “i dibattiti congressuali che portarono all’approvazione dell’Immigration Restriction Act del 1924 chiamavano ripetutamente in causa i dati empirici dei test [sul Q.I.] dell’esercito”, Snyderman e Herrnstein (1983, 994) fanno notare che “il decreto di legge non contiene alcun accenno alla misurazione dell’intelligenza; i risultati dei test sugli immigrati sono stati menzionati solo brevemente nelle udienze del comitato e poi ampiamente ignorati o criticati, e sono stati menzionati una sola volta in più di 600 pagine dei dibattiti congressuali, nel corso dei quali sono oggetto di ulteriori critiche senza repliche. Nessuno dei principali esperti contemporanei in materia di test… fu chiamato a testimoniare, né i loro scritti furono inseriti negli atti legislativi” (Snyderman & Herrnstein 1983, 994). Inoltre, come rileva Samelson (1975), l’impulso teso a limitare l’immigrazione insorse molto prima della nascita dei test del Q.I., e la limitazione dell’immigrazione era promossa da svariati gruppi, inclusi i sindacati, per ragioni diverse da quelle legate alla razza e al Q.I., tra cui in particolare la giustezza del mantenimento dello status quo etnico negli Stati Uniti (si veda cap. 7).
Samelson (1975) descrive numerosi altri esempi della scorrettezza accademica di Kamin, in particolare le sue discussioni diffamatorie nei confronti di Goddard,64 Lewis M. Terman, e Robert M. Yerkes, in cui questi pionieri dei test cognitivi vengono accusati di aver lasciato che le loro idee politiche compromettessero i loro dati. Terman, per esempio, constatò che gli asiatici non erano inferiori ai caucasici, risultati ragionevolmente interpretati dallo stesso come indice dell’inadeguatezza delle spiegazioni culturali; questi esiti sono compatibili con i dati contemporanei (Lynn 1987; Rushton 1995).
33
Gli ebrei erano sovrarappresentati anche nello studio di Terman sui bambini prodigio, risultato sbandierato dalla stampa ebraica dell’epoca (p. es. The American Hebrew, luglio 13, 1923, p. 177) e compatibile con i dati contemporanei (PTSDA, cap. 7). Entrambi i risultati sono in contrasto con la teoria della superiorità nordica.
Kamin (1974a, 27) concluse inoltre che “l’utilizzo del censimento del 1890 aveva un unico obiettivo, riconosciuto dai sostenitori del disegno di legge. La ‘nuova immigrazione’ ebbe inizio dopo il 1890, e la legge aveva come obiettivo quello di escludere i popoli biologicamente inferiori dell’Europa sudorientale.” Questa è un’interpretazione molto tendenziosa delle motivazioni dei restrizionisti. Come discusso nel capitolo 7, si fece uso del censimento del 1890 dei nati all’estero perché le percentuali dei gruppi etnici nati all’estero nel 1890 si avvicinavano alle proporzioni di questi gruppi nella popolazione generale del 1920. L’argomentazione principale dei restrizionisti era che l’uso del censimento del 1890 fosse equo per tutti i gruppi etnici.
Questa falsa rappresentazione dei dibattiti degli anni 20 fu poi utilizzata da Gould, Kamin e altri per sostenere che “la legge, palesemente razzista, sull’immigrazione” del 1924 (Kamin 1982, 98) fu approvata a causa dei pregiudizi razziali diffusi dalla comunità di ricerca sul Q.I. e che questa legge fu una causa fondamentale della morte degli ebrei nell’Olocausto. Kamin concluse pertanto che “la legge, per la quale la scienza della misurazione del quoziente intellettivo può essenzialmente rivendicare il merito, risultò nella morte di letteralmente centinaia di migliaia di vittime della teoria biologica nazista. Alle vittime fu negato l’ingresso negli Stati Uniti poiché ‘la quota tedesca’ era già stata raggiunta.” La descrizione di Kamin dei test del quoziente intellettivo del primo Novecento divenne opinione diffusa, ripetutamente presente su giornali, riviste popolari, sentenze giudiziarie, e di tanto in tanto perfino nelle pubblicazioni accademiche. La mia prima introduzione alle idee di Kamin arrivò attraverso la lettura di un popolare libro di testo sulla psicologia evolutiva che usavo nei miei corsi.
In modo analogo, Gould ipotizza un legame tra le opinioni sull’ereditarietà del Q.I. e la legge statunitense del 1924 che limitava l’immigrazione dall’Europa orientale e meridionale e prediligeva invece quella dei popoli dell’Europa nordoccidentale. La legge sull’immigrazione del 1924 è poi correlata all’Olocausto:
Le quote limitative… rallentarono il flusso migratorio dall’Europa meridionale e orientale fino a ridurlo a un rivolo. Durante gli anni ’30, i rifugiati ebrei, prevedendo l’Olocausto, cercarono di emigrare, ma non furono ammessi. Le quote stabilite dalla legge e la continua propaganda eugenetica li interdissero persino negli anni in cui le quote gonfiate riservate alle nazioni dell’Europa settentrionale e occidentale non furono raggiunte. Chase (1977) ha stimato che dal 1924 fino allo scoppio della seconda guerra mondiale le quote limitative esclusero fino a 6 milioni di europei meridionali, centrali e orientali (presumendo che l’immigrazione fosse continuata al livello precedente al 1924). Sappiamo bene cosa è successo a
34
molti di coloro che volevano emigrare ma non avevano dove andare. Le vie che portano alla distruzione sono spesso indirette, ma le idee possono essere mezzi tanto infallibili quanto i fucili e le bombe. (Gould 1981, 233; si veda anche Gould 1998)
In realtà, per quanto non esistano prove che i test del Q.I. o le teorie eugenetiche avessero la benché minima influenza sulla legge del 1924 sull’immigrazione, è stato dimostrato che la legge veniva percepita dagli ebrei come diretta contro di loro (si veda cap. 7). Per di più, è molto probabile che le apprensioni circa gli ebrei e infine il loro effetto sulla società americana abbiano motivato alcuni dei gentili a favore delle restrizioni sull’immigrazione, inclusi, tra gli intellettuali, Madison Grant e Charles Davenport.
Spinto dal desiderio di neutralizzare la pubblicità che circondava The Bell Curve (si veda Gould 1996a, 31), nel 1996 Gould fece ristampare The Mismeasure of Man con una nuova introduzione in cui afferma: “Che io finisca accanto a Giuda Iscariota, Bruto, e Cassio nella bocca del diavolo al centro dell’inferno se mai mancherò di presentare la mia più onesta valutazione e il mio migliore giudizio delle prove della verità empirica” (p. 39). Nonostante questa promessa (peraltro consciamente difensiva) di obiettività accademica, Gould non fece niente per affrontare le obiezioni dei suoi critici – precisamente il tipo di comportamento che ci si aspetta da un propagandista piuttosto che da un accademico (si veda Rushton 1997). Non appare alcuna menzione dell’articolo di Snyderman e Herrnstein, dell’opera di Samelson, e del libro di Degler (1991), e Gould non ritratta la sua affermazione secondo la quale i test del Q.I. sarebbero stati un elemento saliente dei dibattiti congressuali sull’immigrazione degli anni ’20.
Fatto forse più scandaloso in assoluto, Gould avanza un’incredibile argomentazione affermando che continuerà a ignorare tutta la recente ricerca sul Q.I. a preferenza degli studi più “classici” a causa della natura “transitoria ed effimera” della ricerca contemporanea (1996a, 22). Il suo ragionamento è che non sussistono progressi nella ricerca sul Q.I., bensì una mera ripetizione delle stesse ordinarie argomentazioni – un commento che Gould difficilmente farebbe in merito a qualsiasi altro campo della scienza. Pertanto, a dispetto delle numerose ricerche inerenti al legame tra le dimensioni del cervello e il Q.I., pubblicate sia prima sia soprattutto dopo la sua edizione del 1981 (si veda il sunto che segue), Gould continua a denigrare tali studi. Avvalendosi della risonanza magnetica tomografica per ottenere una misurazione più accurata delle dimensioni del cervello, la ricerca moderna convalida quindi le scoperte dei pionieri del diciannovesimo secolo quali Paul Broca, Francis Galton, e Samuel George Morton, sistematicamente diffamati da Gould. Tuttavia, come fa notare Rushton (1997), l’edizione riveduta di Gould ometteva la sua discussione del 1981 in merito alla ricerca di Arthur Jensen sulla correlazione tra le dimensioni del cervello e il Q.I. perché si era reso conto del fatto che i dati contemporanei sostenevano inequivocabilmente una moderata associazione (r>0,40]. Invece, nell’edizione del 1996, Gould sceglie di ripubblicare la sua approvazione di una rassegna della letteratura del 1971 in cui si conclude che non esiste alcuna correlazione. La revisione di Gould, pertanto, ignora 25 anni di ricerche, compreso il saggio di Van Valen (1974) su cui poggiavano le idee di Jensen.
35
Inoltre, nella sua revisione Gould non menziona un articolo di J. S. Michael (1988) in cui si dimostra che, contrariamente a quanto sostenuto da Gould, Samuel George Morton non falsò – intenzionalmente o meno – i suoi dati sulle differenze razziali delle dimensioni craniche. Per di più, sebbene la ricerca di Morton fosse stata “condotta con integrità” (Michael 1988, 253), essa conteneva un errore che in realtà favoriva un gruppo non caucasico – errore non menzionato da Gould, il quale allo stesso tempo commise errori sistematici e scelse in modo arbitrario le procedure adottate nei suoi calcoli. E Gould inoltre si comportò così per favorire la sua ipotesi secondo cui non esistevano differenze razziali di capacità cranica.
Per giunta, Gould non rettificò la sua diffamazione di H. H. Goddard in cui sostenne che quest’ultimo avesse ritoccato delle fotografie dei membri della famosa famiglia Kallikak per farli sembrare mentalmente ritardati e minacciosi. (Nella sua ricerca, Goddard aveva paragonato i Kallikak, che discendevano dall’unione di una cameriera da taverna e di un cittadino integerrimo, con i discendenti dello stesso uomo e di sua moglie.) Un successivo studio di Glenn e Ellis (1998), apparso molto prima dell’edizione riveduta, ha tuttavia concluso che queste fotografie sono considerate “lusinghiere.” Per essere benevoli, le presupposizioni di Gould sulle intenzioni maligne degli studiosi del Q.I. lo portarono ad attribuire eccessiva parzialità agli altri.
Infine, nell’edizione riveduta del 1996, Gould mancò di confutare le contestazioni della sua ipotesi secondo la quale g (ovvero l’intelligenza generale) non era altro che un artefatto statistico (si vedano, p. es., Carroll 1995; Hunt 1995; Jensen & Weng 1994). Questo è significativo perché, nella sua introduzione all’edizione del 1996, Gould chiaramente si scusa per le sue mancate competenze come storico della scienza o psicologo, ma si dichiara invece un esperto di analisi fattoriale. La sua mancata difesa contro l’attacco dei critici accademici costituisce pertanto un altro esempio della sua disonestà intellettuale volta a promuovere i suoi obiettivi etnopolitici. Come mostra la recensione di Rushton dell’edizione del 1996, Mismeasure of Man abbonda di altri errori di commissione e di omissione, tutti inerenti a questioni politicamente sensibili circa le differenze razziali e le differenze delle capacità cognitive tra i sessi.
Gould era inoltre fortemente contrario all’idea della presenza del progresso nell’evoluzione, possibilmente perché riteneva che tali idee tra gli evoluzionisti tedeschi contribuirono all’ascesa del nazionalsocialismo (si vedano i commenti di Robert Richard in Lewin 1992, 143). Secondo quanto raccontato dal Lewin (1992, 144), Gould riconosce un condizionamento ideologico delle sue idee, ma reitera la sua convinzione che la tendenza verso una maggiore intelligenza e le aumentate dimensioni del cervello non sia importante nel quadro generale dell’evoluzione. (L’idea che l’accresciuta complessità sia importante per l’evoluzione continua a raccogliere ampio sostegno [Bonner 1988; Russell 1983, 1989; E. O. Wilson {si veda Miele 1998, 83}]). Tuttavia, Gould riconosce che la questione in ballo è ben più profonda del se tutti i gruppi animali esibiscano o meno questa tendenza. Questa prospettiva poggia sull’asserzione di Gould secondo cui lo sviluppo della coscienza umana e dell’intelligenza, e la generale tendenza verso le accresciute dimensioni del cervello nell’evoluzione umana
36
siano meramente accidentali e non abbiano contribuito né alla fitness darwiniana né alla risoluzione di problemi di adattamento negli ambienti ancestrali (si veda Lewin 1992, 145-146).65 La sua prospettiva pertanto era intesa come una schermaglia nel dibattito sul carattere innato o appreso dell’intelligenza.66
In più, la devastante analisi di Dennett degli espedienti retorici adottati da Gould nella sua battaglia contro l’adattazionismo lascia poco spazio ai dubbi sulla fondamentale disonestà intellettuale degli scritti di Gould. Dennett lascia intendere che Gould fosse motivato da obiettivi non scientifici, ma si astiene dall’analizzare le ragioni di siffatti obiettivi. Lo stesso Gould (1993, 317) racconta un episodio in cui il biologo britannico Arthur Cain, facendo riferimento al famoso saggio anti-adattazionista di Gould e Lewontin (1979) “The Spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: A critique of the adaptationist programme” [I Pennacchi di San Marco e il paradigma panglossiano: una critica del programma adattazionista, N.d.T.], lo accusò di aver “tradito le norme della scienza e della decenza intellettuale negando qualcosa che si sapeva essere vera (l’adattazionismo), tanta era la sua avversione alle implicazioni politiche di un argomento (la sociobiologia) basato su quel qualcosa.”
La conclusione da trarre deve essere che Gould ha perso davvero il suo diritto di appartenere a “l’antica e universale compagnia degli studiosi” e, nell’aldilà, finirà nella bocca del diavolo al centro dell’inferno. Tuttavia, è notevole che nonostante la diffusa opinione che Gould avesse a cuore un programma molto politicizzato e che fosse un accademico disonesto e interessato esclusivamente al proprio tornaconto, il noto biologo evoluzionista John Maynard Smith (1995, 46) rileva che “egli è riuscito a farsi considerare dai non biologi come il massimo teorico dell’evoluzione. Per contrasto, i biologi evoluzionisti con cui ho discusso del suo lavoro tendono a giudicarlo un uomo le cui idee sono talmente confuse che quasi non vale la pena occuparsene… Tutto ciò non avrebbe importanza se non fosse per il fatto che egli presenta un’immagine sostanzialmente falsa dello stato della teoria dell’evoluzione ai non biologi.” In modo analogo, Steven Pinker (1997), noto linguista nonché personaggio di spicco nel movimento della psicologia evoluzionista, etichetta le idee di Gould sull’adattazionismo come “erronee” e “disinformate.” Egli rimprovera inoltre Gould per non aver citato correttamente il lavoro ampiamente noto di G. C. Williams e Donald Symons, in cui i due autori offrivano spiegazioni non adattive per alcuni comportamenti umani, assumendo ciononostante una prospettiva adattazionista sul comportamento umano in generale. Gould, quindi, si è assunto slealmente il merito per le idee altrui, allo stesso tempo utilizzandole in modo totalmente inappropriato al fine di screditare il programma adattazionista in generale.
In un articolo intitolato “Homo deceptus: Never trust Stephen Jay Gould” [Homo deceptus: mai fidarsi di Stephen Jay Gould, N.d.T.], il giornalista Robert Wright (1996), autore di The Moral Animal [L’Animale morale, N.d.T.] (Basic Books, 1994), gli muove la stessa accusa in una polemica sull’interpretazione palesemente disonesta di Gould (1996b) sulla psicologia evoluzionista delle differenze sessuali. Wright fa notare che Gould “è riuscito a convincere il pubblico di essere non solo un grande scrittore, ma anche un grande teorico dell’evoluzione. Tuttavia, tra i biologi evoluzionisti di primo rango,
37
Gould è considerato una rogna – non solo una nullità ma piuttosto un uomo intensamente confuso che è riuscito a distorcere la comprensione del darwinismo da parte del pubblico.” Un’immagine falsa, forse, ma che ha una sua utilità per conseguire obiettivi politici e, si suppone, etnici.
Un altro biologo di rilievo, John Alcock (1997), offre un’analisi approfondita e, a mio avviso, precisa di diversi aspetti dello stile retorico di Gould: l’ostentata erudizione – frasi in lingua straniera, poesia – irrilevante per gli argomenti intellettuali ma ampiamente apprezzata persino dai suoi critici; le etichette denigratorie affibbiate all’opposizione, quali “scienza pop”, “psicologia pop”, “darwinismo di cartapesta”, o “darwiniani integralisti” (analogamente, Pinker [1997, 55] scredita la retorica iperbolica di Gould, inclusa la sua descrizione dei concetti della psicologia evoluzionista come ‘“frivoli,’ ‘patetici,’ e ‘scandalosamente semplicistici’ nonché l’uso di circa venticinque sinonimi per ‘fanatici’’’); il semplificare esageratamente le posizioni dei suoi oppositori al fine di costruire argomenti capziosi e pretestuosi, di cui un esempio classico è l’etichettare gli oppositori come “deterministi genetici”; il proteggere la sua posizione attraverso concessioni illusorie per dare un’apparenza di imparzialità nel tentativo di circoscrivere il dibattito; il rivendicare la propria superiorità morale; l’ignorare dati pertinenti ben risaputi nell’ambito della comunità scientifica; il proporre alternative non adattazioniste senza testarle e ignorando i dati a sostegno delle interpretazioni adattazioniste; il sostenere che le spiegazioni prossime (p. es. le spiegazioni sul funzionamento di un tratto al livello neurofisico) rendono superflue le spiegazioni remote (p. es. la funzione adattiva del tratto).
I commenti di Maynard Smith, Wright, e Alcock sottolineano l’importante questione che, nonostante la disonestà intellettuale di Gould fosse ampiamente riconosciuta dalla comunità accademica, egli è stato energicamente promosso come pubblico portavoce su argomenti attinenti all’evoluzione e all’intelligenza. Come osserva Alcock (1997), Gould, in quanto noto professore di Harvard, rende l’essere anti-adattazionista rispettabile, e questo effetto si nota non solo tra il pubblico colto ma persino tra molti accademici esterni alle scienze biologiche. Ha avuto accesso a forum intellettuali altamente prestigiosi, compresa una rubrica su Natural History, e insieme a Richard C. Lewontin (altro accademico attivista le cui opere sono qui discusse), figura spesso come recensore di libri sul New York Review of Books (NYRB). Da tempo il NYRB è un baluardo della sinistra intellettuale. Nel capitolo 4 viene discusso il ruolo rivestito dal NYRB nella divulgazione della psicoanalisi, e nel capitolo 6 il NYRB è elencato tra le riviste dei New York Intellettuals, un cenacolo prevalentemente ebraico che ha dominato il discorso intellettuale nel secondo dopoguerra. Il punto è che la carriera di disonestà intellettuale di Gould non esisteva nel vuoto, bensì era parte integrante di un movimento di ampio respiro che ha dominato le arene intellettuali più prestigiose degli Stati Uniti e dell’Occidente – un movimento che viene qui concettualizzato come un aspetto dell’ebraismo in quanto strategia evolutiva di gruppo.
38
Su un piano più personale, ricordo con chiarezza che una delle mie prime esperienze importanti nel corso di specializzazione postlaurea in scienze del comportamento è stato l’aver assistito al noto dibattito sull’“istinto” tra gli etnologi tedeschi Konrad Lorenz e Iranäus Eibl-Eibesfeldt e diversi psicobiologi dello sviluppo, prevalentemente americani ebrei (D. S. Lehrman, J. S. Rosenblatt, T. C. Schneirla, H. Moltz, G. Gottleib ed E. Tobach). I legami tra Lorenz e il nazionalsocialismo (si veda Lerner 1992, 59 ss.) erano un aspetto a malapena celato di questo dibattito, e ricordo di aver avuto l’impressione di assistere a una sorta di conflitto etnico piuttosto che a uno spassionato dibattito scientifico di dati esistenti. Infatti, le passioni intense e non scientifiche che tali questioni suscitavano in alcuni partecipanti sono state apertamente riconosciute verso la fine di questo rimarchevole conflitto. Nel suo contributo del 1970, Lehrman affermò:
Non dovrei sottolineare gli elementi irrazionali ed emotivamente carichi nella reazione di Lorenz alle critiche senza riconoscere che, quando riguardo la mia critica del 1953 della sua teoria, percepisco elementi di ostilità a cui il mio bersaglio avrebbe sicuramente reagito. Ora che la rileggo, la mia critica non mi pare un’analisi di un problema scientifico, con una valutazione del contributo di un particolare punto di vista, ma piuttosto un attacco contro un punto di vista teorico, in cui l’autore dell’attacco non era interessato a segnalare i contributi positivi apportati dal quel punto di vista.
Più recentemente, man mano che il dibattito si spostava dall’opposizione all’etologia umana verso l’attacco contro la sociobiologia umana, diversi tra questi psicobiologi sono divenuti anche importanti critici della sociobiologia (si veda Myers 1990, 225).
Con ciò, naturalmente, non si intende negare i contributi molto importanti di questi psicobiologi dello sviluppo e la loro enfasi sul ruolo dell’ambiente nell’evoluzione comportamentale – una tradizione che rimane influente nell’ambito della psicologia dello sviluppo negli scritti di vari teorici, compresi Alan Fogel, Richard Lerner, Arnold Sameroff, e Esther Thelen. Inoltre, va riconosciuto che diversi ebrei – inclusi Daniel G. Freedman, Richard Herrnstein, Seymour Itzkoff, Irwin Silverman, Nancy Segal, Lionel Tiger e Glenn Weisfeld – hanno apportato importanti contributi al pensiero evoluzionistico per quanto attiene agli esseri umani nonché alla genetica comportamentale umana. Naturalmente, tra i critici del pensiero biologico-evoluzionista figurano anche non ebrei. Malgrado ciò, nel complesso l’episodio indica chiaramente il fatto che spesso ci sono importanti interessi umani che riguardano l’identità ebraica e che incidono sul dibattito scientifico. Ciò che si vuole suggerire qui è che una delle conseguenze dell’ebraismo come
39
strategia evolutiva di gruppo sia stata quella di distorcere questi dibattiti in modo tale da ostacolare il progresso nelle scienze biologiche e sociali.
Richard Lerner (1992), con il suo Final Solutions: Biology, Prejudice, and Genocide [Soluzioni finali: biologia, pregiudizio e genocidio, N.d.T.], è forse l’esempio più scandaloso di uno scienziato motivato dal desiderio di screditare il pensiero biologico-evoluzionista a causa di presunti legami con l’antisemitismo. (Anche Barry Mehler, uno dei protetti di Jerry Hirsch, è stato esplicito nel segnalare questi legami, ma è molto meno noto nel mondo accademico e pertanto funge principalmente da propagatore di questi punti di vista nei media intellettuali di sinistra. Si veda Mehler [1984a,b]. Mehler, laureatosi alla Yeshiva University, organizzò un programma chiamato “L’esperienza ebraica in America dal 1880 al 1975” alla Washington University di St. Louis, il che suggerirebbe una forte identificazione ebraica.) Lerner è un noto psicologo dello sviluppo, e il suo volume indica un intenso coinvolgimento personale mirato a combattere l’antisemitismo attraverso il tentativo di influenzare la teoria alla base delle scienze comportamentali. Prima di esaminare i legami espliciti tra la prospettiva teorica di Lerner e il suo tentativo di combattere l’antisemitismo, occorrerà descrivere la sua teoria ed illustrare il tipo di logica forzata da lui adottata per cercare di screditare l’applicazione del pensiero evoluzionista al comportamento umano.
Un elemento cardinale di questo programma è il rifiuto del determinismo biologico da parte di Lerner a favore di un approccio dinamico e contestualista allo sviluppo umano. Lerner respinge anche il determinismo ambientale, ma riserva ben poco spazio alla discussione di quest’ultima posizione dato che il determinismo ambientale è “forse meno spesso socialmente dannoso” (p. xx). A questo riguardo, Lerner ha certamente torto. Una teoria che postuli che la natura umana non esista implica che gli esseri umani potrebbero facilmente essere programmati ad accettare ogni tipo di sfruttamento, schiavitù compresa. Da una prospettiva ambientalista radicale, non dovrebbe importare il modo in cui si formano le società, giacché le persone dovrebbero essere in grado di imparare ad accettare qualsiasi tipo di struttura sociale. Le donne potrebbero facilmente essere programmate ad accettare lo stupro, e certi gruppi etnici potrebbero essere programmati ad accettare il proprio soggiogamento da parte di altri gruppi etnici. L’idea che l’ambientalismo radicale non sia socialmente dannoso ignora anche il fatto che il governo comunista dell’Unione Sovietica uccise milioni dei suoi cittadini per poi perseguire una politica ufficiale di antisemitismo, rimanendo allo stesso tempo fedele a un’ideologia di ambientalismo radicale.67
Il contestualismo dinamico di Lerner sostiene a parole le influenze biologiche, ma in realtà le rende insignificanti e impossibili da analizzare. Questa teoria è profondamente radicata nella tradizione della psicobiologia dello sviluppo sopra discussa, e sono numerosi i riferimenti a questi scrittori. La prospettiva del contestualismo dinamico concettualizza l’evoluzione come interazione dialettica tra l’organismo e l’ambiente. Le influenze biologiche sono considerate una realtà, tuttavia risultano essenzialmente non analizzabili, essendo concepite come inestricabilmente fuse con quelle ambientali. La conclusione più saliente è il rifiuto di qualsiasi tentativo di studiare la variazione genetica come fattore indipendentemente analizzabile che incide sulle differenze individuali
40
(il che rispecchia il programma della scienza della genetica comportamentale quantitativa). Molti tra i critici della sociobiologia sono stati anche aspri oppositori alla ricerca sulla genetica comportamentale (p. es. S. J. Gould, J. Hirsch, L. Kamin, R. C. Lewontin e S. Rose). Per un esempio particolarmente cospicuo che illustra praticamente tutte le possibili misinterpretazioni dei concetti basilari della genetica comportamentale, si veda Gould (1998).
Va osservato che il contestualismo dinamico e la sua enfasi sull’interazione dialettica tra l’organismo e l’ambiente denotano più di una vaga somiglianza al marxismo. La prefazione al libro di Lerner fu scritta da R. C. Lewontin, biologo della popolazione ad Harvard che ha portato avanti un’iniziativa di gran rilievo volta ad amalgamare scienza, politica di sinistra, e opposizione alla teorizzazione evoluzionistica e biologica del comportamento umano (p. es., Levins & Lewontin 1985; si veda Wilson 1994). Lewontin è coautore (con Steven Rose e Leon Kamin) di Not in Our Genes [Il Gene e la sua mente] (1984) – un libro che esordisce con una dichiarazione dell’esplicito impegno degli autori a sostegno del socialismo (p. ix) e, tra i tanti altri ‘peccati’ intellettuali, perpetua la disinformazione circa il ruolo dei testi del Q.I. nei dibattiti sull’immigrazione degli anni ’20 e i suoi presunti legami con l’Olocausto (p. 27). Infatti, E. O. Wilson (1994, 344) il cui volume sinottico Sociobiology: The New Synthesis [Sociobiologia: La nuova sintesi, N.d.T.] (Wilson 1975) inaugurò il campo della sociobiologia, osserva che “senza Lewontin, la controversia [in merito alla sociobiologia] non sarebbe stata così intensa né avrebbe attirato così tanta attenzione.”
Nella prefazione al libro di Lerner, Lewontin afferma che il contestualismo evolutivo è “l’alternativa al determinismo biologico e culturale. È proprio l’enunciazione dell’approccio contestualistico-evolutivo ad essere l’elemento fondamentale di Final Solutions, e la piena elaborazione di questa prospettiva si presenta come un programma cruciale per la teoria sociale. Questa visione del mondo non è mai stata descritta in modo più succinto che nella terza Tesi su Feuerbach di Marx” (p. ix). Lewontin cita quindi un passo di Marx che effettivamente esprime qualcosa di analogo all’idea fondamentale del contestualismo evolutivo. Anche Gould (1987, 153) ha appoggiato una prospettiva dialettica marxista nelle scienze sociali.
Lerner dedica gran parte del suo libro al tentativo di dimostrare che il contestualismo dinamico, per via della sua enfasi sulla plasticità, offre una prospettiva politicamente accettabile sulle differenze razziali e sessuali, nonché la speranza di poter eliminare l’antisemitismo. Questa sorta di tentativo messianico e redenzionista volto a sviluppare un quadro teorico universalista in cui le differenze di gruppo ebreo-gentile sono relegate in secondo piano è un elemento comune di altri movimenti prevalentemente ebraici del ventesimo secolo, comprese le teorie politiche radicali e la psicoanalisi (si vedano capp. 3, 4). Il tema comune a tutte queste ideologie è che sono state promosse sistematicamente da individui che, come Lerner, consciamente perseguono determinati obiettivi etnici e politici ebraici. (Si tenga a mente anche la predilezione di Gould di arrogarsi una superiorità morale.) Tuttavia, le ideologie vengono sostenute per via delle loro promesse universaliste di condurre l’umanità a un livello di moralità più alto – un livello
41
di moralità in cui sussiste una continuità dell’identità ebraica di gruppo ma l’antisemitismo viene sradicato. Come tale, il contestualismo dinamico può essere visto come uno dei tanti tentativi post-illuministici di conciliare l’ebraismo con il mondo moderno.
Non v’è alcun dubbio sul fatto che Lerner crede fermamente nell’imperativo morale della sua posizione, ma la sua crociata morale lo ha portato ben oltre la scienza nei suoi tentativi di screditare le teorie biologiche per combattere l’antisemitismo.68 Lerner è stato coautore di un articolo pubblicato nella rivista accademica Human Development (Lerner & von Eye 1992) mirato a combattere l’influenza del pensiero biologico nella ricerca sull’evoluzione umana. Il mio volume Sociobiological Perspectives on Human Development, [Prospettive sociobiologiche sullo sviluppo umano, N.d.T.] (MacDonald 1988b) è citato enfaticamente come esempio dell’approccio evoluzionista derivante dalla ricerca di E. O. Wilson e come punto di vista “che ha riscontrato sostegno e applicazione” (p. 13). Per esemplificare come questo punto di vista è stato sostenuto e applicato, Lerner e von Eye citano l’opera di J. Philippe Rushton sulle differenze razziali negli stili di riproduzione r/K. L’implicazione parrebbe essere che la mia pubblicazione sia servita da base per il lavoro di Rushton. Questo è errato, dal momento che (1) il volume non ha mai menzionato le differenze intellettive negroidi-caucasiche né qualsiasi altro fenotipo, e (2) il libro fu pubblicato a seguito della pubblicazione della ricerca di Rushton sulla teoria r/K delle differenze razziali. Tuttavia, l’associazione tra questo libro e Rushton si è rivelata efficace nel produrre una valutazione negativa del libro a causa dell’attuale status di Rushton come persona non grata in quanto teorico delle differenze razziali (si veda Gross 1990).
La sezione successiva dell’articolo di Lerner e von Eye si intitola “Il determinismo genetico come chiave della sociobiologia per l’integrazione interdisciplinare.” Implicita in questa giustapposizione è l’insinuazione che gli autori pubblicati nel mio volume accettino la tesi del determinismo genetico, e infatti, alla fine della sezione Lerner e von Eye raggruppano la mia pubblicazione insieme ad altre opere di vari altri autori di sociobiologia che, presumibilmente, credono che l’anatomia sia destino, che le influenze ambientali siano fittizie e che “il mondo sociale non interagisca con i geni umani” (p. 18).
Nell’ambito di questa letteratura altamente politicizzata, gli studiosi associati alle prospettive evoluzionistiche sul comportamento umano o alla genetica comportamentale sono stati spesso etichettati come deterministi genetici. Tali accuse sono un elemento ricorrente della retorica gouldiana, e costituiscono un tema importante del libro apertamente politico di Lewontin et al. Not in Our Genes (1984). Dubito fortemente che gli autori discussi in questa sezione del saggio di Lerner e von Eye possano essere propriamente descritti come deterministi genetici (si veda la replica di Burgess & Molenaar [1993] all’articolo di Lerner & von Eye). Infatti, Degler (1991, 310) riassume correttamente il recente pensiero evoluzionistico nelle scienze sociali come caratterizzato da “un pieno riconoscimento del potere e dell’influenza dell’ambiente sulla cultura.” Tuttavia, desidero qui sottolineare che questa è
42
una caratterizzazione completamente inesatta dei miei scritti ed è difficile supporre che Lerner non lo sapesse. Due dei miei contributi nel volume trattano ampiamente delle influenze culturali e ambientali sul comportamento e della sottodeterminazione del comportamento da parte dei geni. In particolare, la mia prospettiva teorica, così come descritta nel Capitolo 1 del volume edito (MacDonald 1988b), sostiene fortemente l’importanza della plasticità nello sviluppo e afferma l’importanza delle influenze contestuali sullo sviluppo umano. In entrambe le sezioni del mio saggio, inoltre, cito il lavoro di Richard Lerner. Tuttavia, Lerner e von Eye si guardano bene dal descrivere realmente ciò che ho effettivamente scritto. La loro strategia, invece, è quella di ricorrere all’insinuazione e alla colpa per associazione. Inserendo la mia pubblicazione alla fine di una sezione dedicata ad autori che sono presunti deterministi genetici, riescono a insinuare che tutti gli autori nel volume siano deterministi genetici. Purtroppo, tali insinuazioni sono tipiche degli attacchi alle prospettive evoluzionistiche sul comportamento umano.
A questo punto è più che ragionevole supporre che a fare da importante impulso per questi attacchi sia il tentativo di combattere l’antisemitismo. Lerner comincia la sua prefazione a Final Solutions: Biology, Prejudice, and Genocide con un’immagine straziante della sua infanzia, pervasa da storie delle atrocità naziste. “Come ragazzo ebreo cresciuto a Brooklyn tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50, non potevo fuggire da Hitler. Hitler, i nazisti, la Gestapo, Auschwitz erano ovunque” (p. xv). Lerner rievoca una conversazione con la nonna sul destino di alcuni suoi parenti per mano dei nazisti. Egli chiese perché i nazisti odiassero gli ebrei, e la nonna gli rispose: “Così.” Lerner afferma che “nel periodo trascorso da quel pomeriggio a casa di mia nonna in poi mi sono reso conto – e continuo a rendermi conto ancora di più con il passare degli anni – di quanto profondamente fossi rimasto impressionato da queste prime lezioni sul genocidio nazista. Ora capisco che gran parte della mia vita è stata condizionata dai miei tentativi di andare oltre la risposta ‘Così”’ (p. xvii).
Lerner afferma di aver deciso di studiare psicologia dello sviluppo perché la questione ‘innato-appreso’ è fondamentale in questo campo e pertanto fondamentale per il suo tentativo di combattere l’antisemitismo. Sembra dunque che Lerner abbia scelto la sua carriera in un tentativo di far avanzare gli interessi ebraici nelle scienze sociali. Nella prefazione, Lerner cita come influenze intellettuali praticamente tutti gli psicobiologi e gli antisociobiologi prevalentemente ebrei sopramenzionati, compresi Gottleib, Gould, Kamin, Lewontin, Rose, Schneirla (che non era ebreo), e Tobach. Come consueto tra storici ebraici, Lerner dedica il libro alla sua famiglia: “A tutti i miei parenti… Le vostre vite non saranno dimenticate” (p. xxii). È chiaro che questo libro non avanza pretese di essere una spassionata impresa scientifica volta a elaborare una teoria dello sviluppo comportamentale o a comprendere il conflitto socio-etnico.
43
Il punto focale del libro di Lerner è quello dell’esistenza di un possibile nesso di causalità che collegherebbe il darwinismo a un’ideologia di determinismo genetico, alla legittimazione dello status quo come imperativo biologico, alla valutazione negativa di individui con genotipi “inferiori”, all’eugenetica, e infine all’eliminazione di coloro che possiedono geni inferiori. Questa trama si sarebbe concretizzata in diverse circostanze storiche, compresi i massacri dei nativi americani e il genocidio ottomano degli armeni, e in modo particolare l’Olocausto. Non si accenna in alcun modo al fatto che il determinismo genetico possa difficilmente configurarsi come condizione necessaria per il genocidio, dato che esistono molti esempi storici di genocidio in società in cui Darwin era sconosciuto, tra cui lo sterminio degli amorrei dei midianiti per mano degli israeliti descritto nel Tanakh (si veda PTSDA, cap. 3) – esempi omessi da Lerner. Né esistono prove, ad esempio, che i turchi ottomani conoscessero Darwin o avessero delle opinioni, scientifiche o meno, in merito alla determinazione genetica del comportamento.
L’obiettivo di Lerner è quello di screditare il pensiero evoluzionistico a causa della sua associazione con il nazismo. La logica è la seguente (Lerner 1992, 17-19): Sebbene Lerner riconosca che i deterministi genetici non siano necessariamente “razzisti” e che possano persino avere opinioni politiche “illuminate”, egli sostiene che il determinismo genetico è un’ideologia che può essere utilizzata per dare credibilità scientifica al loro punto di vista: “La dottrina del determinismo biologico è suscettibile di essere adottata dagli esponenti di un tale movimento politico” (p. 17). La sociobiologia, in quanto incarnazione più recente della giustificazione scientifica del determinismo genetico, andrebbe screditata: “I sociobiologi contemporanei di certo non sono neonazisti. Non promuovono in alcun modo il genocidio e probabilmente non abbracciano opinioni politiche conservatrici. Nondimeno, la corrispondenza tra le loro idee (in particolare riguardo alle donne) e quelle dei teorici nazisti è impressionante” (p. 20).
Lerner descrive correttamente l’ideologia nazista come un’ideologia basata sostanzialmente sull’impermeabilità di gruppo, “la convinzione che il mondo… possa essere diviso inequivocabilmente in due gruppi principali: un ingroup composto da coloro che possiedono i migliori elementi dell’esistenza umana, e un outgroup composto dai peggiori elementi dell’esistenza umana. Non c’è possibilità di passare da un gruppo all’altro, poiché i due gruppi sono separati dal sangue, o dai geni” (p. 17). Analogamente, Lewontin, nella sua prefazione al libro di Lerner, afferma che “indipendentemente dalle forze generatrici che tengono in vita il nazionalismo… esse devono, in fin dei conti, asserire la natura costante e immutabile dell’identità sociale… Gli sfruttatori e gli sfruttati condividono la coscienza di un patrimonio culturale e biologico che traccia gli indelebili confini di gruppo che trascendono lo sviluppo storico umano” (p. viii).
Lerner e Lewontin condannano la sociobiologia perché suppongono che potrebbe essere usata per giustificare un tale risultato. Tuttavia, la teoria evoluzionistica dei processi di identità sociale elaborata in SAID (cap. 1) come base della
44
teoria dell’antisemitismo implica l’esatto contrario. Sebbene gli esseri umani sembrino predisposti al conflitto tra ingroup e outgroup, non c’è motivo di supporre che la partecipazione al gruppo o la permeabilità del gruppo sia geneticamente determinata; ovvero, non c’è alcun motivo di supporre che sussista un imperativo genetico in base al quale le società devono organizzarsi intorno a gruppi impermeabili, tant’è vero che le società occidentali prototipiche non sono state organizzate in questa maniera. La ricerca sull’identità sociale indica che l’ostilità nei confronti degli outgroup esiste anche in gruppi composti in modo casuale e perfino in assenza di concorrenza tra i gruppi. La caratteristica più saliente dell’ebraismo risiede nella risolutezza con cui ha costantemente innalzato barriere tra gli ebrei (come ingroup) e la società esterna (come outgroup). Tuttavia, sebbene sia ragionevole supporre che gli ebrei siano geneticamente più inclini all’etnocentrismo rispetto ai popoli occidentali (si vedano PTSDA, cap. 8; SAID, cap. 1), l’innalzamento di barriere tra ebrei e gentili costituisce un aspetto cruciale dell’ebraismo come cultura.
Per di più, un punto saliente è che né Lerner né Lewontin si rendono conto di quanto effettivamente gli stessi ebrei abbiano creato gruppi impermeabili in cui le linee genetiche erano di cruciale importanza, in cui esistevano delle gerarchie di purezza razziale, e in cui l’assimilazione genetica e culturale era vista come un anatema (si veda PTSDA, passim). L’ebraismo come strategia evolutiva di gruppo ha portato a società squarciate dal conflitto interno tra gruppi etnici impermeabili concorrenti tra loro (si veda SAID, capp. 2-5). Ciò nonostante, le pratiche culturali ebraiche costituiscono almeno una condizione necessaria per l’impermeabilità di gruppo che è stata fondamentale per l’ebraismo come strategia evolutiva di gruppo. È pertanto il massimo dell’ironia che Lewontin e Lerner cerchino di combattere l’antisemitismo dichiarando che l’identificazione etnica e la permeabilità di gruppo non sono geneticamente determinate.
Esistono validi motivi per supporre che la permeabilità di gruppo non sia geneticamente determinata, e le prove prese in esame in PTSDA indicherebbero che gli ebrei ne erano perfettamente consapevoli fin dalle origini dell’ebraismo come strategia evolutiva di gruppo. In diverse occasioni i gruppi ebraici hanno tentato di coltivare l’illusione di permeabilità di gruppo per minimizzare l’antisemitismo (si veda SAID, cap. 6). Sebbene sia possibile che gli ebrei siano geneticamente predisposti a formare gruppi etnici impermeabili e ad opporre resistenza all’assimilazione genetica e culturale, è improbabile che ciò abbia una determinazione genetica. Infatti, le prove esaminate in PTSDA (capp. 7, 8) indicano l’importanza fondamentale di alcuni fattori culturali e ambientali per il successo dell’ebraismo come strategia evolutiva di gruppo relativamente impermeabile: l’intensiva socializzazione volta ad alimentare un’identità ingroup e una lealtà di gruppo ebraiche, l’ampia varietà di meccanismi di separazione (abbigliamento, lingua, acconciature, ecc.), e l’invenzione culturale delle classi sacerdotali e levitiche ereditarie. Inoltre, l’eliminazione dell’intensivo separatismo culturale che caratterizza l’ebraismo nelle società tradizionali ha avuto come conseguenza un protratto declino dell’ebraismo diasporico.
45
Di conseguenza, nel mondo contemporaneo occidentale i gruppi ebraici si adoperano strenuamente per scoraggiare il matrimonio misto e per accrescere la coscienza ebraica e la solidarietà tra ebrei. Questo tentativo di ripristinare i supporti culturali per l’identificazione e la non assimilazione ebraiche spesso comporta il suggerimento di un ritorno alle credenze e ai riti ebraici come unico mezzo per resistere a lungo termine alle pressioni assimilative esercitate dalle società occidentali contemporanee (si veda SAID, cap. 9).
CONCLUSIONE
Un filo conduttore di questo capitolo è l’efficace uso strumentale dello scetticismo scientifico e di quanto si potrebbe definire “oscurantismo scientifico” nel contrastare le teorie scientifiche per le quali si nutre avversione a causa di ragioni più profonde. Pertanto, l’insistenza dei boasiani sulla necessità di prove più rigorose per le generalizzazioni sulla cultura e per assegnare un ruolo alla variazione genetica nello sviluppo delle differenze individuali ha coinciso con l’accettazione di una “anti-teoria” culturale fondamentalmente in opposizione ai tentativi di sviluppare delle classificazioni e delle generalizzazioni nel campo.69 In modo analogo, la prospettiva teorica dinamico-contestualista, pur respingendo la genetica comportamentale e la teorizzazione evoluzionista dello sviluppo umano sull’evoluzione umana per insufficienza di prove in grado di soddisfare gli standard scientifici, ha proposto una teoria dello sviluppo in cui la relazione tra geni e ambiente costituisce una combinazione estremamente complessa e in definitiva non analizzabile. Inoltre, un importante tema del capitolo 5 è la consapevolezza con cui lo scetticismo radicale della Scuola di Francoforte per la Ricerca Sociale veniva utilizzato al fine di decostruire le teorie assimilatorie e universaliste della società come unità omogenea e armoniosa.
Lo scetticismo scientifico riguardante le questioni politicamente sensibili ha altresì costituito una marcata tendenza negli scritti di S. J. Gould (si vedano, p. es., Gould 1987, passim; Gould 1991, 13). In merito a Gould, Carl Degler (1991, 322) dice che “un oppositore della sociobiologia come Gould pone enfasi proprio su quell’interazione [tra la biologia e l’ambiente] ma, allo stesso tempo, respinge tenacemente le ricerche sui ruoli dei singoli elementi interattivi.” Riguardo al lavoro di Gould sulla misurazione dell’intelligenza, Jensen (1982, 124) afferma: “Credo che sia riuscito egregiamente a offuscare tutte le importanti questioni aperte che effettivamente interessano gli scienziati di oggi.” Questo tipo di lavoro intellettuale ha come obiettivo quello di bloccare lo sviluppo di teorie generali sul comportamento umano in cui la variazione genetica svolge un ruolo causativo e indipendentemente analizzabile nella formazione di comportamenti adattivi.
Abbiamo visto come R. C. Lewontin ha collegato le teorie di sviluppo comportamentale con l’ideologia politica marxista. Così come Lerner e Gould, Lewontin
46
promuove teorie secondo le quali la natura consiste in complicatissime interazioni dialettiche tra l’organismo e l’ambiente. Lewontin respinge i metodi scientifici riduzionisti come la genetica comportamentale quantitativa o l’uso di procedure di analisi della variabilità, perché questi inevitabilmente semplificano eccessivamente i processi reali a causa dell’uso di medie (Segersträle 1986). Ne risulta un iperpurismo che non si accontenta di niente che non sia certezza assoluta e assoluta correttezza metodologica, epistemologica, e ontologica. Nella psicologia dello sviluppo un tale programma porterebbe essenzialmente al rifiuto di qualsiasi generalizzazione, comprese quelle relative agli effetti medi dell’ambiente. Dal momento che ogni individuo possiede una serie unica di geni e il suo continuo sviluppo si svolge in un ambiente unico e in costante cambiamento, Dio stesso probabilmente avrebbe difficoltà a fornire un resoconto deterministico dello sviluppo individuale e ad ogni modo un tale resoconto, così come una teoria boasiana della cultura, dovrebbe essere necessariamente rinviato ad un futuro remoto.
Adottando questa filosofia della scienza, Lewontin è in grado di screditare i tentativi degli scienziati di elaborare teorie e generalizzazioni, evitando pertanto, in nome del rigore scientifico, la possibilità di qualsiasi esito scientifico politicamente inaccettabile. Segersträle fa notare che mentre Lewontin utilizza questa teoria come arma contro le prospettive biologiche nelle scienze sociali, la sua ricerca empirica sulla biologia delle popolazioni rimane saldamente ancorata alla tradizione riduzionista.
La critica di Gould e Lewontin (1979) relativa all’adattazionismo può essere vista inoltre come esempio dell’impulso scettico delle attività intellettuali ebraiche. Riconoscendo l’esistenza degli adattamenti, l’argomentazione effettivamente rende problematico lo status di qualsiasi presunto adattamento. Gould (p. es., 1994a) passa dalla possibilità che qualsiasi presunto adattamento possa essere semplicemente un “pennacchio” che, come la forma architettonica da cui prende il nome, è il risultato delle limitazioni strutturali imposte dagli adattamenti veri, alla straordinaria affermazione che la mente umana può essere vista come un insieme di simili ‘pennacchi’ non funzionali. Come osservato in precedenza, l’obiettivo più ampio di Gould è quello di convincere il pubblico che il cervello umano non si sia evoluto per risolvere problemi adattivi – visione definita dall’antropologo Vincent Sarich (1995) come “creazionismo comportamentale.” (Per tradizionali punti di vista sull’adattazionismo, si vedano Boyd & Richerson 1985, 282; Dennett 1995; Hull 1988, 424-426; Williams 1985.) Difatti, il fascino sollevato dalla precaria retorica dell’articolo di Gould e Lewontin sui “pennacchi” ha portato alla pubblicazione di un intero volume di saggi dedicati all’analisi dello stile letterario di questo articolo (Selzer 1993; si veda in particolare Fahnestock 1993; e si vedano anche i commenti di Joseph Carroll [1995, 449 pagg.] sull’ingannevole stile retorico di Lewontin).
Lo scetticismo scientifico è un approccio potente, dato che una caratteristica fondamentale della scienza è l’apertura alla critica e il requisito che le argomentazioni siano corroborate da prove. Come fa notare E.O. Wilson (1994, 345), “Adottando
47
rigidi criteri per l’idoneità alla pubblicazione delle ricerche, Lewontin si è reso libero di perseguire un programma politico non ostacolato dalla scienza. Ha adottato la prospettiva relativista secondo cui la verità accettata, a meno che non sia basata su fatti ineluttabili, non è altro che un riflesso dell’ideologia e del potere dominanti.”70 Temi analoghi con motivazioni simili caratterizzano le ideologie della Scuola di Francoforte e il postmodernismo, come discusso nel capitolo 5.
Tuttavia, Lewontin (1994a, 34) descrive i suoi sforzi di ispirazione ideologica come scaturenti dalla sua attenzione al rigore scientifico: “Esigiamo determinati canoni di prove e argomentazioni che siano formali e senza riferimento al contenuto empirico… la logica dell’inferenza statistica; la facoltà di replicare sperimenti; la distinzione tra osservazioni e asserzioni causali.” Il risultato di ciò è uno scetticismo dilagante; per esempio, tutte le teorie sulle origini della divisione sessuale del lavoro sarebbero definite “speculative” (Lewontin 1994a, 34). In modo simile, Gould respinge tutte le analisi dei dati empirici nel campo della misurazione dell’intelligenza, senza fornirne alternative. Come fa notare Jensen (1982, 131), “Gould non offre idee alternative per spiegare tutte queste osservazioni ben consolidate. La sua missione in questo campo sembra completamente nichilista.” Analogamente, Buss et al. (1998) osservano che mentre la prospettiva adattazionista nella psicologia ha dato vita a un ricco corpus di previsioni teoriche e a numerosi studi empirici corroboranti, i concetti gouldiani di pennacchio e exaptation [esattamento, N.d.T.] (termine usato da Gould in vari modi, ma forse più frequentemente in relazione a meccanismi aventi nuove funzioni biologiche diverse da quelle che hanno causato la selezione originaria del meccanismo) non hanno generato né previsioni teoriche né studi empirici. Di nuovo, l’obiettivo prefissato sembra essere quella che si potrebbe definire come anti-scienza nichilista.
Come Boas, Lewontin insiste su standard rigorosissimi per quanto concerne la ricerca a orientamento biologico sugli esseri umani, ma è straordinariamente indulgente per quanto riguarda gli standard necessari per provare la scarsa rilevanza della biologia. Lewontin sostiene, per esempio, che “quasi tutta la biologia di genere è cattiva scienza” (Lewontin 1994a, 34), ma alla pagina seguente afferma come palese verità che “l’essere umano è il nesso di un gran numero di cause scarsamente incisive.” E Lewontin, senza argomentazioni o citazioni, asserisce che “nessuno ha mai rilevato una correlazione tra le capacità cognitive e le dimensioni del cervello” (p. 34). Ad oggi sono stati pubblicati più di 26 studi su 39 campioni indipendenti che dimostrano una correlazione di circa 0,20 tra circonferenza craniale e Q.I. (si veda Wickett et al. 1994); sono stati pubblicati almeno 6 studi che, avvalendosi della più precisa tecnica della risonanza magnetica per visualizzare il cervello tramite la scansione, dimostrano una correlazione di circa 0,40 tra dimensioni del cervello e Q.I. (Andreasen et al. 1993; Egan et al. 1994; Harvey et al. 1994; Raz et al. 1993; Wickett et al. 1994; Willerman et al. 1991). Alla luce di tale corpus di risultati, avanzare una simile affermazione è a dir poco fuorviante, sebbene Lewontin (1994b) probabilmente risponderebbe
48
che questi studi non raggiungono livelli di prova scientifica accettabili. Franz Boas ne sarebbe fiero.
49