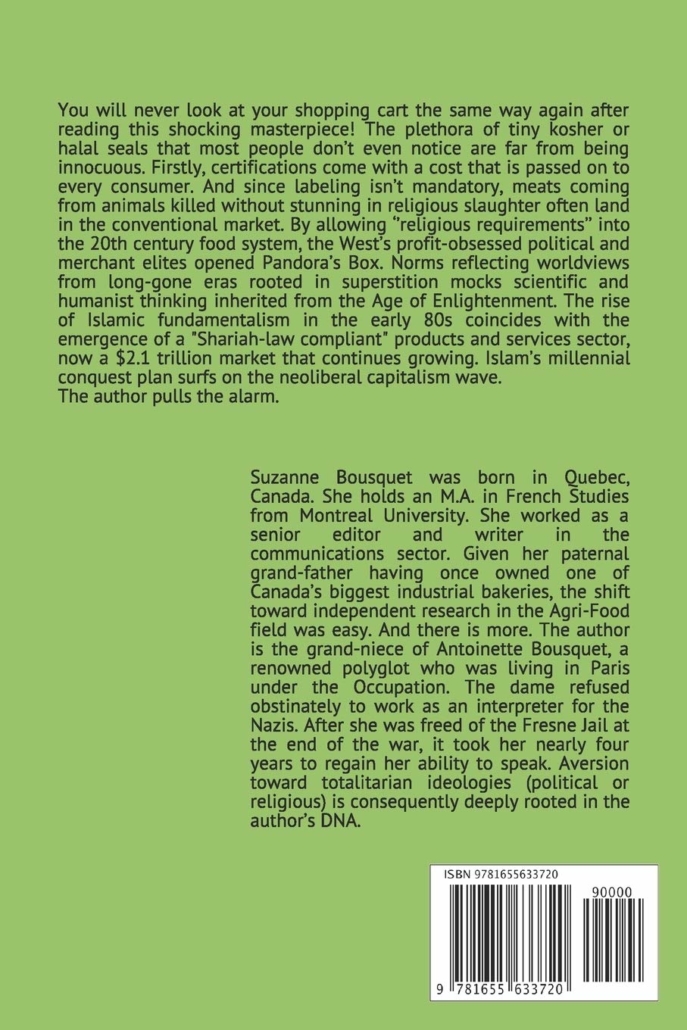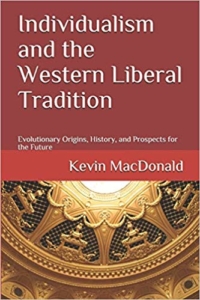Capitolo 3 di La cultura della critica: Gli ebrei e la sinistra
3
Gli ebrei e la sinistra
Non sono mai riuscito a comprendere cosa avesse a che fare il giudaismo con il marxismo, e perché mettere in dubbio quest’ultimo equivalesse ad essere sleale al Dio di Abramo, Isacco, e Giacobbe. (Ralph de Toledano [1996, 50] discute delle sue esperienze con gli intellettuali ebrei dell’Europa dell’Est)
Il socialismo, per molti immigrati ebrei, non significava meramente la politica o un’idea, era una cultura onnicomprensiva, un modo di percepire e di valutare attraverso cui costruire la loro vita. (Irving Howe 1982, 9)
L’associazione tra gli ebrei e la sinistra è stata ampiamente notata e commentata a partire dal XIX secolo. “Qualunque fosse la loro situazione… in quasi ogni Paese su cui abbiamo informazioni, una parte della comunità ebraica giocava un ruolo cruciale nell’ambito dei movimenti mirati a sovvertire l’ordine esistente” (Rothman & Lichter 1982, 110).
Quantomeno in apparenza, il coinvolgimento ebraico nell’attività politica radicale può destare sorpresa. Il marxismo, almeno nella visione di Marx, è l’esatta antitesi del giudaismo. Il marxismo è un esemplare di un’ideologia universalista in cui le barriere etniche e nazionaliste all’interno della società, e addirittura tra le società, vengono infine abbattute nell’interesse dell’armonia sociale e di una percepita utilità comune. Lo stesso Marx, inoltre, sebbene nato da genitori di etnia ebraica, è stato considerato da molti un antisemita.71 La sua critica (Sulla questione ebraica [Marx 1843/1975]) concettualizzava il giudaismo essenzialmente come un’egoistica brama di arricchimento: era arrivato a dominare il mondo trasformando l’uomo e la natura in oggetti smerciabili. Marx vedeva il giudaismo come un astratto principio dell’avidità umana che avrebbe portato alla società comunista del futuro. Tuttavia, Marx respingeva l’idea che gli ebrei dovessero rinunciare alla loro ebraicità per essere cittadini tedeschi, e immaginava che il giudaismo, liberato dal principio dell’avidità, avrebbe continuato a esistere nella società trasformata dopo la rivoluzione (Katz 1986, 113).
A prescindere dalle idee di Marx a riguardo, una domanda cruciale da porsi qui di seguito è se l’accettazione di ideologie radicali e universaliste e la partecipazione a movimenti radicali e universalisti siano compatibili con l’identificazione ebraica.
50
L’adozione di una tale ideologia comporta necessariamente l’esclusione dalla comunità ebraica e dal tradizionale impegno a favore del separatismo e dell’autonomia del popolo ebraico? Oppure, riformulando la domanda dal mio punto di vista, la promozione di ideologie e azioni radicali e universaliste sarebbe compatibile con una partecipazione continuativa al giudaismo come strategia evolutiva di gruppo?
Si noti bene che ciò si differenzia dalla domanda sul se gli ebrei come gruppo possano essere opportunamente caratterizzati come promotori di soluzioni politiche radicali per le società gentili. Non significa che il giudaismo costituisca un movimento unificato o che tutti i segmenti della comunità ebraica abbiano le stesse idee o gli stessi atteggiamenti verso la comunità gentile (si veda cap. 1). È possibile che gli ebrei costituiscano un elemento predominante o necessario nei movimenti politici radicali, e che l’identificazione ebraica sia fortemente compatibile con o persino faciliti il coinvolgimento ebraico in movimenti politici radicali senza una partecipazione maggioritaria degli ebrei, e perfino nel caso in cui gli ebrei costituiscano una minoranza numerica all’interno di tali movimenti.
RADICALISMO E IDENTIFICAZIONE EBRAICA
L’ipotesi che il radicalismo ebraico sia compatibile con il giudaismo come strategia evolutiva di gruppo implica che gli ebrei radicali continuino a identificarsi come ebrei. Ci sono ben pochi dubbi sul fatto che la stragrande maggioranza degli ebrei che promuoveva le cause di sinistra a partire dal tardo XIX secolo si identificava fortemente come ebraica e non vedesse alcun conflitto tra il giudaismo e il radicalismo (Marcus 1983, 280 segg.; Levin 1977, 65, 1988, I, 4-5; Mishkinsky 1968, 290, 291; Rothman & Lichter 1982, 92-93; Sorin 1985, passim). Infatti, i maggiori movimenti radicali ebraici sia in Russia che in Polonia erano i Bund ebraici, caratterizzati da una composizione esclusivamente ebraica e da un programma ben definito teso a perseguire obiettivi specificamente ebraici. Il proletarismo del Bund polacco in realtà era parte del tentativo di preservare la loro l’identità nazionale come ebrei (Marcus 1983, 282). La fratellanza con la classe operaia non ebraica era intesa a facilitare i loro obiettivi specificamente ebraici, e lo stesso si può dire per il Bund russo ebraico (Liebman 1979, 111 segg.). Giacché i Bund comprendevano la maggior parte del movimento radicale ebraico in queste zone, la stragrande maggioranza degli ebrei che militava nei movimenti radicali in questo periodo aveva una forte identità ebraica.
Per di più, molti membri ebrei del partito comunista dell’Unione Sovietica sembravano intenti a creare una forma di giudaismo laico piuttosto che a porre fine alla continuità di gruppo ebraica. Il governo sovietico postrivoluzionario e i movimenti socialisti ebraici si arrovellavano sulla questione della conservazione dell’identità nazionale (Levin 1988; Pinkus 1988). Malgrado un’ideologia ufficiale in cui il nazionalismo e il separatismo etnico venivano considerati reazionari, il governo sovietico
51
era costretto ad affrontare la realtà di fortissime identificazioni etniche e nazionali all’interno dell’Unione Sovietica. Di conseguenza, venne creata una sezione ebraica (Evsektsiya) del partito comunista. Questa sezione “lottava duramente contro i partiti sionisti socialisti, le comunità ebraiche democratiche, la fede e la cultura ebraiche. Riuscì, tuttavia, a formare uno stile di vita laico basato sullo yiddish come lingua nazionale riconosciuta della nazionalità ebraica; a lottare per la sopravvivenza nazionale ebraica negli anni ’20; a lavorare durante gli anni ’30 per rallentare il processo assimilativo della sovietizzazione della lingua e cultura ebraiche” (Pinkus 1988, 62).72
Il risultato di questi sforzi fu la creazione di una subcultura separatista yiddish, di sponsorizzazione statale, che comprendeva scuole e perfino soviet yiddish. Questa cultura separatista era sostenuta in maniera molto aggressiva dall’Evsektsiya. I genitori ebrei ricalcitranti venivano costretti “con il terrore” a mandare i figli a queste scuole separatiste anziché a scuole in cui i bambini non sarebbero stati costretti a studiare nuovamente le materie in russo per superare gli esami di ammissione (Gitelman 1991, 12). I temi trattati dagli scrittori sovietici ebrei prominenti e ufficialmente riconosciuti negli anni ’30 evidenziano ulteriormente l’importanza dell’identità etnica: “L’essenza della loro prosa, poesia e opera teatrale si riduceva a una sola idea – le limitazioni ai loro diritti sotto lo zarismo e il fiorire degli ebrei, un tempo oppressi, sotto il sole della costituzione Lenin-Stalin” (Vaksberg 1994, 115).
Per di più, dal 1942 fino al secondo dopoguerra il Jewish Anti-Fascist Committee [Comitato ebraico antifascista, N.d.T.] (JAC) serviva a promuovere gli interessi culturali e politici ebraici (compreso il tentativo di fondare una repubblica ebraica in Crimea) fino al suo scioglimento da parte del governo nel 1948 tra accuse di nazionalismo ebraico, resistenza all’assimilazione e simpatie sioniste (Kostyrchenko 1995, 30 segg.; Vaksberg 1994, 112 segg.). I leader del JAC si identificavano fortemente come ebrei. I seguenti commenti di Itsik Fefer, leader del JAC, circa le sue opinioni durante la guerra indicano un forte senso di appartenenza al popolo ebraico, popolo risalente a tempi antichi:
Ho dichiarato che amo il mio popolo. Ma chi non ama il proprio popolo?… Il mio interesse relativo alla Crimea e a Birobidzhan [zona dell’Unione Sovietica designata per l’insediamento ebraico] è stato dettato da ciò. Ero del parere che solo Stalin potesse riparare l’ingiustizia storica creata dagli imperatori romani. Mi sembrava che solo il governo sovietico potesse riparare questa ingiustizia, attraverso la creazione di una nazione ebraica. (In Kostyrchenko 1995, 39)
52
Nonostante la loro totale mancanza di identificazione con il giudaismo come religione e le loro battaglie contro alcuni dei segni più salienti del separatismo ebraico di gruppo, l’iscrizione al partito comunista di questi attivisti ebrei non era incompatibile con l’elaborazione di meccanismi ideati per garantire la continuità di gruppo ebraica come entità laica. Di fatto, a parte la prole di matrimoni interetnici, ben pochi ebrei persero l’identità ebraica nel corso dell’intera epoca sovietica (Gitelman 1991, 5),73 e gli anni del secondo dopoguerra videro un forte rafforzamento della cultura ebraica e del sionismo nell’Unione Sovietica. A cominciare dallo scioglimento del JAC, il governo sovietico diede inizio a una campagna di repressione contro qualsiasi manifestazione di nazionalismo ebraico e di cultura ebraica, inclusi la chiusura dei teatri e musei ebraici e lo scioglimento dei sindacati degli scrittori ebrei.
La questione dell’identificazione ebraica dei bolscevichi ebrei di nascita è complessa. Pipes (1993, 102-104) asserisce che durante il periodo zarista i bolscevichi di discendenza ebraica non si identificavano come ebrei, nonostante fossero percepiti dai gentili come impegnati a favore degli interessi ebraici e nonostante fossero vittime dell’antisemitismo. Per esempio, Leon Trotsky, il secondo bolscevico più importante dopo Lenin, faceva di tutto per evitare l’impressione di avere la pur minima identità ebraica o qualsiasi interesse nelle questioni ebraiche.74
È difficile credere che questi radicali fossero totalmente privi di un’identità ebraica, visto che erano considerati ebrei dagli altri e presi di mira dagli antisemiti. In generale, l’antisemitismo aumenta l’identificazione ebraica (SAID, cap.6). Tuttavia, è possibile che in questi casi l’identità ebraica fosse principalmente imposta dall’esterno. Per esempio, il contrasto negli anni ’20 tra Stalin e l’opposizione di sinistra, capeggiata da Trotsky, Grigory Zinoviev, Lev Kamenev e Grigory Solkolnikov (tutti di etnia ebraica), aveva forti connotazioni di un conflitto di gruppo ebreo-gentile: “L’ovvia condizione di ‘estranei’, che si presumeva unisse un intero blocco di candidati, era una circostanza lampante” (Vaksberg 1994, 19; si vedano anche Ginsberg 1993, 53; Lindemann 1997, 452; Pinkus 1988, 85-86; Rapoport 1990, 38; Rothman & Lichter 1982, 94). Per tutti i partecipanti, il background ebraico o gentile dei loro avversari era molto saliente, e infatti Sidney Hook (1949, 464) fa notare che gli stalinisti non ebrei si servivano di argomenti antisemitici contro i trotzkisti. Vaksberg cita Vyacheslav Molotov (ministro degli affari esteri e il secondo più importante leader sovietico), il quale asserisce che Stalin aveva scartato Kamenev perché voleva un non ebreo a capo del governo. Per di più, l’internazionalismo del blocco ebraico, paragonato al nazionalismo implicito nella posizione stalinista (Lindemann 1997, 450), è più coerente con gli interessi ebraici e riflette sicuramente un tema ricorrente degli atteggiamenti ebraici nelle società postilluministiche in generale. Durante questo periodo fino agli anni ’30 “per il Cremlino e la Lubyanka [sede della polizia segreta russa] non era la religione ma il sangue a determinare l’essere ebrei” (Vaksberg 1994, 64). Infatti, la polizia segreta
53
faceva uso di outsider etnici (p. es. ebrei in Ucraina, tradizionalmente antisemitica) come agenti poiché erano meno solidali nei confronti dei nativi (Lindemann 1997, 443) – una politica perfettamente sensata in termini evoluzionistici.
L’essere di etnia ebraica era pertanto importante non solo per i gentili ma anche, soggettivamente, per gli ebrei. Quando intendeva indagare su un agente ebreo, la polizia segreta reclutava una “fanciulla ebrea di etnia pura” per stabilire una relazione intima con l’indagato – presumendo implicitamente che il rapporto intraetnico avrebbe portato a un’operazione più fruttuosa (Vaksberg 1994, 44n). In modo analogo, si è registrata una marcata tendenza da parte degli ebrei a venerare altri ebrei quali Trotsky e Rosa Luxemburg piuttosto che gentili di sinistra, come avveniva in Polonia (Shatz 1991, 62, 89), sebbene alcuni studiosi nutrano seri dubbi sull’identificazione ebraica di questi due rivoluzionari. Tra l’altro, Hook (1949, 465) rileva la percezione all’interno della sinistra che l’attrazione degli intellettuali ebrei verso Trotsky avesse una base etnica. A detta di un simpatizzante, “Non è un caso che tre quarti dei leader trotzkisti siano ebrei.”
Numerosi elementi, pertanto, indicano che, in linea di massima, i bolscevichi ebrei conservavano almeno in parte una residua identità ebraica. In alcuni casi è ben possibile che questa identità ebraica fosse “reattiva” (ovvero risultante dalla percezione altrui). Per esempio, è possibile che Rosa Luxemburg avesse un’identità ebraica reattiva, poiché era percepita come ebrea nonostante “fosse la più aspra critica del proprio popolo, abbassandosi talvolta a insultare spietatamente gli altri ebrei” (Shepherd 1933, 118). Ciononostante, la sua unica relazione sessuale fu con un ebreo, e continuò a mantenere i legami con la propria famiglia. Lindemann (1997, 178) osserva che il conflitto tra la sinistra rivoluzionaria di Luxemburg e i riformatori socialdemocratici in Germania risentiva del conflitto etnico ebreo-gentile, considerando l’alta percentuale e la prominenza degli ebrei tra i primi. Giunti alla prima guerra mondiale, “le sempre più esigue amicizie della Luxemburg all’interno del partito erano diventate sempre più ebraiche, mentre il suo disprezzo per i leader del partito (prevalentemente non ebrei) si faceva sempre più manifesto e caustico. Le sue allusioni alla dirigenza erano spesso costellate di frasi caratteristicamente ebraiche: i leader del partito erano gli ‘shabbesgoyim della borghesia’. Agli occhi di molti tedeschi di destra, Luxemburg era diventata la più odiata tra tutti i rivoluzionari, la personificazione dello straniero ebreo distruttivo” (p. 402). Considerati questi fatti, la possibilità che Luxemburg fosse in realtà una cripto-ebrea o che fosse in preda all’autoinganno riguardo alla sua identità ebraica – fenomeno, quest’ultimo, piuttosto frequente tra i radicali ebrei (si veda sotto) – sembra almeno altrettanto probabile quanto la supposizione che non si identificasse affatto come ebrea.
In termini della teoria dell’identità sociale, l’antisemitismo renderebbe difficile l’adozione dell’identità della cultura circostante. Le pratiche separatiste ebraiche tradizionali unite alla concorrenza economica tendono a sfociare nell’antisemitismo, ma l’antisemitismo a sua volta rende l’assimilazione ebraica più difficile perché
54
diventa più difficile per gli ebrei accettare un’identità non ebraica. Nella Polonia del periodo interbellico, pertanto, l’assimilazione culturale ebraica subì un incremento notevole; nel 1939 la metà degli studenti ebrei delle superiori considerava il polacco la propria madrelingua. Tuttavia, la permanenza della cultura ebraica tradizionale tra una percentuale significativa di ebrei e il correlato antisemitismo rappresentavano una barriera che impediva agli ebrei di adottare un’identificazione polacca (Schatz 1991, 34-35).
Dal punto di vista dei gentili, tuttavia, le reazioni antisemitiche nei confronti di individui quali Luxemburg e altri ebrei esteriormente assimilati possono essere interpretate come derivanti da un tentativo di prevenire l’inganno attraverso un’eccessiva esagerazione della misura in cui le persone di etnia ebraica si identifichino come ebrei e cerchino coscientemente di promuovere interessi specificamente ebraici (si veda SAID, cap.1). Simili percezioni degli ebrei laici e degli ebrei convertiti al cristianesimo sono una caratteristica ricorrente dell’antisemitismo nel mondo postilluministico e, in realtà, questi ebrei spesso mantenevano reti sociali e commerciali informali che portavano a matrimoni con altri ebrei battezzati e con altre famiglie ebree che non avevano cambiato la loro religione professata (si veda SAID, capp. 5, 6).75
Ritengo che non sia possibile stabilire in via definitiva l’identificazione ebraica o l’assenza di tale identificazione da parte dei bolscevichi ebrei prima della rivoluzione e nel periodo postrivoluzionario, quando gli ebrei etnici godevano di grande potere nell’Unione Sovietica. Diversi elementi sembrano suffragare la supposizione che l’identificazione ebraica interessasse una percentuale sostanziale degli ebrei etnici: (1) le persone erano classificate come ebrei in base all’appartenenza etnica a causa – almeno in parte – dell’antisemitismo residuo; ciò tenderebbe a imporre un’identità ebraica a questi individui e renderebbe più difficile assumere un’identità esclusiva come membro di un gruppo politico più grande e inclusivo. (2) Molti bolscevichi ebrei, come quelli nell’Evsektsiya e nel JAC, cercavano accanitamente di stabilire una subcultura ebraica laica. (3) Pochissimi ebrei di sinistra immaginavano una società postrivoluzionaria senza la continuazione del giudaismo come gruppo; infatti, l’ideologia predominante tra gli ebrei di sinistra sosteneva che la società postrivoluzionaria avrebbe posto fine all’antisemitismo poiché avrebbe posto fine al conflitto di classe e al peculiare profilo occupazionale ebraico. (4) Il comportamento dei comunisti americani dimostra che l’identità ebraica e il predominio degli interessi ebraici su quelli comunisti erano diffusi tra gli individui che erano comunisti etnicamente ebrei (si veda qui di seguito). (5) L’esistenza del criptismo ebraico in altri tempi e luoghi si associa alla possibilità che l’autoinganno, la flessibilità e l’ambivalenza identificatorie siano componenti importanti del giudaismo come strategia evolutiva di gruppo (si veda SAID, cap. 8).
Quest’ultima possibilità è particolarmente interessante e verrà elaborata qui di seguito. La migliore dimostrazione che un individuo abbia realmente cessato di avere un’identità ebraica è quella di optare per una scelta politica percepita dallo stesso come chiaramente non vantaggiosa per
55
gli ebrei come gruppo. In assenza di un evidente conflitto con gli interessi ebraici, resta probabile che le scelte politiche diverse tra gli ebrei etnici non siano altro che tattiche differenti per come meglio perseguire obiettivi ebraici. Nel caso dei membri ebrei del Partito comunista americano (CPUSA) esaminato qui di seguito, la prova più convincente che i membri ebrei etnici continuassero ad avere un’identità ebraica è che in generale il loro sostegno al CPUSA aumentava e diminuiva a seconda che le politiche sovietiche fossero percepite o meno come una violazione di specifici interessi ebraici come il sostegno a favore di Israele o l’opposizione alla Germania nazista.
L’identificazione ebraica è un argomento complesso nell’ambito del quale le dichiarazioni superficiali possono trarre in inganno. In realtà, è possibile che gli ebrei non siano effettivamente consapevoli di quanto sia forte la loro identificazione con il giudaismo. Silberman (1985, 184), per esempio, fa notare che nel periodo della guerra arabo-israeliana molti ebrei potevano immedesimarsi nella dichiarazione del rabbino Abraham Joshua Heschel “Non sapevo quanto fossi ebreo” (in Silberman 1985, 184; corsivo nel testo). Silberman osserva: “Questa è la riposta data non da un nuovo proselito del giudaismo o da un fedele occasionale, bensì dall’uomo considerato da molti, me incluso, il più grande leader spirituale ebreo dei nostri tempi.” Tanti altri arrivarono alla stessa sorprendente scoperta su se stessi: Arthur Hertzberg (1979, 210) scrisse: “L’immediata reazione della comunità ebraica americana alla crisi fu molto più intensa e diffusa di quanto si potesse immaginare. Molti ebrei non avrebbero mai creduto che un grave pericolo per Israele potesse dominare i loro pensieri e le loro emozioni ad esclusione di tutto il resto.”
Si consideri anche il caso di Polina Zhemchuzhina, moglie di Vyacheslav Mikhailovich Molotov (premier dell’URSS negli anni ’30) e rivoluzionaria di spicco che aderì al Partito comunista nel 1918. (Tra le varie sue conquiste, divenne membro del Comitato centrale del Partito.) Quando Golda Meir, in occasione della sua visita nell’Unione Sovietica nel 1948, domandò a Zhemchuzhina come mai parlasse così bene lo yiddish, ella rispose più volte “Ich bin a Yiddishe tochter” (Sono una donna ebrea) (Rubenstein 1996, 262). “Si congedò [dalla delegazione israeliana] con le lacrime agli occhi, dicendo ‘Spero che vi vada tutto bene lì e così andrà bene a tutti gli ebrei’” (Rubenstein 1996, 262). Vaksberg (1994, 192) la descrive come “una stalinista di ferro”, ma il suo fanatismo non le impediva di essere una “buona figlia ebrea”.
Si consideri inoltre il caso di Ilya Ehrenburg, noto giornalista sovietico e propagandista antifascista per l’Unione Sovietica, la vita del quale è raccontata in un libro il cui titolo, Tangled Loyalties [Lealtà aggrovigliate, N.d.T] (Rubenstein 1996), illustra le complessità dell’identità ebraica nell’Unione Sovietica. Ehrenburg era un fedele stalinista che sosteneva la linea sovietica sul sionismo e si rifiutava di condannare le misure sovietiche contro gli ebrei (Rubenstein 1996). Ciò malgrado, Ehrenburg aveva opinioni sioniste, manteneva pratiche associative ebraiche, credeva nell’unicità del popolo ebraico e nutriva una profonda preoccupazione per l’antisemitismo e l’Olocausto. Ehrenburg era un organizzatore del JAC, che promuoveva il risveglio culturale ebraico
56
e maggiori contatti con gli ebrei all’estero. Un suo amico scrittore lo descriveva “innanzitutto un ebreo… Ehrenburg aveva respinto le sue origini con tutto il suo essere, travestendosi da occidentale, fumando tabacco olandese e pianificando i suoi viaggi presso la Cook… Ma non aveva cancellato l’ebreo” (p. 204). “Ehrenburg non negava mai le sue origini ebraiche e verso la fine della sua vita ripeteva spesso l’indomita convinzione che si sarebbe considerato ebreo ‘fino a quando non sarà rimasto sulla Terra un solo antisemita’” (Rubenstein 1996, 13). In un famoso articolo, citò un’affermazione secondo cui “il sangue esiste in due forme: il sangue che scorre dentro le vene e il sangue che scorre fuori delle vene… Perché dico ‘Noi ebrei’? Per via del sangue” (p. 259). Infatti è possibile che la sua intensa fedeltà al regime stalinista e il suo silenzio sulle brutalità sovietiche inclusa l’uccisione di milioni di cittadini negli anni ’30 fossero motivati essenzialmente dalla sua idea che l’Unione Sovietica costituisse un baluardo contro il fascismo (pp. 143-145). “Nessuna trasgressione suscitava la sua ira quanto l’antisemitismo” (p. 313).
La forte identità ebraica residua di una nota bolscevica si palesa anche nel seguente commento sulla reazione degli ebrei etnici alla nascita di Israele:
Sembrava che tutti gli ebrei, a prescindere dall’età, dalla professione o dalla condizione sociale, si sentissero responsabili del piccolo stato lontano diventato simbolo del risveglio nazionale. Anche gli ebrei sovietici, in apparenza assimilati in modo irrevocabile, erano ora sotto l’incantesimo del miracolo mediorientale. Yekaterina Davidovna (Golda Gorbman) era una bolscevica fanatica, un’internazionalista nonché moglie del maresciallo Kliment Voroshilov, e nella sua gioventù era stata scomunicata come miscredente; ma adesso lasciava a bocca aperta i parenti dicendo: “Finalmente ora anche noi abbiamo la nostra patria.” (Kostyrchenko 1995, 102)
Il punto è che anche l’identità ebraica di un ebreo altamente assimilato, e perfino di uno che l’ha soggettivamente respinta, può riemergere in momenti di crisi del gruppo o quando l’identificazione ebraica entra in conflitto con qualsiasi altra identità che un ebreo possa avere, inclusa l’identificazione come radicale politico. In linea con la teoria dell’identità sociale, Elazar (1980) fa notare che nei momenti in cui si percepisce una minaccia per il giudaismo, l’identificazione di gruppo aumenta notevolmente perfino tra gli ebrei aventi un’identità ebraica “molto trascurabile”, come durante la guerra di Yom Kippur. Di conseguenza, le affermazioni sull’identificazione ebraica che non tengono conto delle percepite minacce per il giudaismo possono seriamente sottovalutare l’entità dell’impegno ebraico. Le dichiarazioni superficiali di mancanza di un’identità ebraica possono essere molto fuorvianti.76 E, come vedremo in seguito, ci sono prove valide del diffuso autoinganno sull’identità ebraica tra i radicali ebrei.
57
Per di più esistono prove convincenti che, sia nell’epoca zarista sia in quella postrivoluzionaria, i bolscevichi ebrei percepivano le loro attività come pienamente congruenti con gli interessi ebraici. La rivoluzione pose fine al governo zarista, ufficialmente antisemitico, e sebbene l’antisemitismo popolare persistesse nel periodo postrivoluzionario, esso fu ufficialmente bandito dal governo. Gli ebrei erano altamente sovrarappresentati nelle posizioni di potere economico e politico, come pure di influenza culturale, almeno fino agli anni ’40. Lo stesso governo tentava anche di cancellare qualsiasi traccia del cristianesimo come forza sociale unificatrice nell’Unione Sovietica e simultaneamente creava una subcultura ebraica laica in modo che il giudaismo non perdesse la sua continuità di gruppo o i suoi meccanismi unificatori come la lingua yiddish.
C’è da dubitare, perciò, che i bolscevichi sovietici ebraici fossero mai stati costretti a scegliere tra un’identità ebraica e una bolscevica, almeno nel periodo postrivoluzionario e negli anni ’30. Data la congruenza di quanto potrebbe essere definito “auto-interesse identificatorio,” è assai plausibile che dei singoli bolscevichi ebrei negassero o ignorassero la propria identità ebraica – forse facilitati da meccanismi di autoinganno – mantenendo allo stesso tempo un’identità ebraica che sarebbe riemersa soltanto nel caso di netto conflitto tra gli interessi ebraici e le politiche comuniste.
COMUNISMO E IDENTIFICAZIONE EBRAICA IN POLONIA
L’opera di Schatz (1991) sul gruppo di comunisti ebrei saliti al potere in Polonia nel secondo dopoguerra (definiti da Schatz “la Generazione”) è importante perché fa luce sui processi identificatori di un’intera generazione di ebrei comunisti nell’Europa dell’Est. A differenza della situazione nell’Unione Sovietica, dove la fazione prevalentemente ebraica guidata da Trotsky fu sconfitta, qui si possono tracciare le attività e le identificazioni di un’élite comunista ebraica che effettivamente conquistò il potere politico e riuscì a detenerlo per un periodo di tempo significativo.
La stragrande maggioranza di questo gruppo era stata socializzata in famiglie ebraiche molto tradizionali
la cui vita interiore, abitudini e folclore, tradizioni religiose, tempo libero, contatti tra le generazioni, e modi di socializzare erano essenzialmente pervasi, nonostante alcune variazioni, da valori e norme di comportamento ebraici tradizionali… I fondamenti del patrimonio culturale erano stati tramandati loro attraverso
58
l’istruzione e la pratica religiosa formale, la celebrazione delle festività, i racconti e le canzoni, le storie raccontate dai genitori e nonni, attraverso l’ascolto delle discussioni tra gli anziani… Ne risultava un profondo nucleo di identità, valori, norme e atteggiamenti con cui entravano nel turbolento periodo della loro gioventù e della maturità. Questo nucleo si sarebbe poi trasformato nei processi di acculturazione, secolarizzazione e radicalizzazione, talvolta fino ad arrivare a un rifiuto esplicito. Ciò nonostante, è attraverso questo strato profondo che sarebbero state filtrate tutte le successive percezioni. (Schatz 1991, 37-38; mia l’enfasi)
Si noti l’implicita entrata in gioco di processi di autoinganno: i membri de “la generazione” negavano gli effetti di quella pervasiva esperienza di socializzazione che ha poi condizionato tutte le loro percezioni successive, cosicché in termini molto reali, non si rendevano conto di quanto fossero ebrei. La maggior parte di questi individui parlava yiddish nella vita quotidiana e aveva una scarsa padronanza del polacco anche dopo l’iscrizione al partito (p. 54). Socializzavano esclusivamente con altri ebrei conosciuti nel mondo ebraico del lavoro, nella comunità, e nelle organizzazioni sociali e politiche ebraiche. Una volta diventati comunisti, uscivano e si sposavano solo tra loro, e gli eventi sociali si svolgevano in lingua yiddish (p. 116). Come nel caso di tutti i movimenti intellettuali e politici ebraici esaminati in questo volume, i loro mentori e coloro che li influenzarono maggiormente erano altri ebrei etnici, inclusi in modo particolare Luxemburg e Trotsky (pp. 62, 89), e quando ricordavano i propri eroi personali, questi ultimi erano prevalentemente ebrei le cui imprese assumevano proporzioni quasi mitiche (p. 112).
Prima di unirsi al movimento comunista, gli ebrei non rinnegavano la loro identità ebraica, e molti “facevano tesoro della cultura ebraica… [e] sognavano una società in cui gli ebrei sarebbero stati al pari degli altri come ebrei” (p. 48). Infatti, era piuttosto normale nutrire una forte identità ebraica accompagnata dal marxismo nonché da svariate combinazioni di sionismo e bundismo. Inoltre, il richiamo esercitato dal comunismo sugli ebrei polacchi era notevolmente facilitato dalla consapevolezza che gli ebrei avevano raggiunto alte posizioni di potere e influenza nell’Unione Sovietica e che il governo sovietico aveva creato un sistema di istruzione e cultura ebraiche (p. 60). Sia nell’Unione Sovietica che in Polonia, il comunismo era visto come opposto all’antisemitismo. In netto contrasto, il governo polacco degli anni ’30 aveva istituito politiche con cui gli ebrei venivano esclusi dall’impiego statale, la loro rappresentanza nelle università e nelle professioni era soggetta a quote, e le attività commerciali e gli artigiani ebrei erano soggetti a boicottaggi sponsorizzati dallo Stato (Hagen 1996). Chiaramente, gli ebrei percepivano il comunismo come positivo per ebrei: era un movimento che non minacciava la continuità di gruppo ebraica,
59
e offriva la speranza di potere e influenza per gli ebrei e la fine dell’antisemitismo di sponsorizzazione statale.
A un estremo dello spettro dell’identificazione ebraica si trovavano i comunisti che iniziavano la loro carriera nel Bund o nelle organizzazioni ebraiche, parlavano yiddish e lavoravano esclusivamente all’interno di un milieu ebraico. L’identità ebraica e quella comunista erano entrambe sincere, prive di qualsiasi ambivalenza o percepito conflitto tra le due fonti di identità. All’altro estremo dello spettro dell’identificazione ebraica, alcuni comunisti ebrei forse avrebbero voluto fondare uno stato de-etnicizzato senza continuità ebraica di gruppo, ma le prove a riguardo sono ben poco convincenti. Nel periodo prebellico, perfino gli ebrei più “de-etnicizzati” si assimilavano solo esteriormente, vestendosi da gentili, assumendo nomi simil-gentili (il che suggerisce inganno) e imparando le loro lingue. Tentavano di reclutare gentili nel movimento, eppure loro non si assimilavano alla cultura polacca né tentavano di farlo; conservavano gli “atteggiamenti sprezzanti e altezzosi” tradizionalmente ebraici verso quanto, da marxisti, consideravano una cultura contadina polacca “retrograda” (p. 119). Perfino i comunisti ebrei più assimilati che lavoravano nelle aree urbane a contatto con non ebrei erano turbati dal Patto di non aggressione tedesco-sovietico, e si sentirono sollevati quando finalmente scoppiò la guerra tedesco-sovietica (p. 121) – chiaro segno che l’identità personale ebraica rimaneva appena sotto la superficie. Il Partito comunista di Polonia (KPP) inoltre aveva sempre una tendenza a promuovere gli interessi specificamente ebraici anziché una cieca lealtà all’Unione Sovietica. Infatti, Schatz (p. 102) afferma che Stalin sciolse il KPP nel 1938 a causa della presenza di trotzkisti all’interno del partito e perché la dirigenza sovietica prevedeva che il KPP si sarebbe opposto all’alleanza con la Germania nazista.
In SAID (cap. 8) si è osservato che dall’illuminismo in poi l’ambivalenza identificatoria è stata una caratteristica ricorrente del giudaismo. È interessante che gli attivisti polacchi ebrei mostrassero una notevole ambivalenza identificatoria derivante in ultima analisi dalla contraddizione tra “il credere in qualche sorta di esistenza collettiva ebraica e, al tempo stesso, un rifiuto di una tale comunione etnica, in quanto ritenuta incompatibile con le divisioni di classe e dannosa alla lotta politica complessiva; gli sforzi per conservare uno specifico tipo di cultura ebraica e, al tempo stesso, considerare ciò una mera forma etnica del messaggio comunista, strumentale nell’integrare gli ebrei nella comunità socialista polacca; il mantenimento di istituzioni ebraiche distinte e al tempo stesso il desiderio di eliminare la separatezza ebraica di per sé” (p. 234). Più avanti sarà evidente che gli ebrei, inclusi quelli comunisti ai più alti livelli del governo, andavano avanti come gruppo identificabile e coeso. Tuttavia, sebbene essi stessi non sembrassero rendersi conto della natura collettiva ebraica della loro esperienza (p. 240), ciò era percepibile dagli altri – un chiaro esempio di autoinganno evidente anche nel caso dei progressisti americani ebrei, come osservato qui di seguito.
60
Questi comunisti ebrei erano anch’essi impegnati in elaborate razionalizzazioni e autoinganni sul ruolo del movimento comunista in Polonia, pertanto l’assenza di prove di una manifesta identità etnica ebraica non può essere interpretata come chiara prova della mancanza di un’identità ebraica. “Anomalie cognitive ed emotive – pensieri ed emozioni non liberi, mutilati e distorti – diventarono il prezzo per aver conservato inalterate le loro idee… L’adattamento delle proprie esperienze alle proprie credenze veniva conseguito tramite meccanismi di interpretazione, soppressione, giustificazione o motivazione” (p. 191). “Per quanto sapessero applicare abilmente il loro pensiero critico a penetranti analisi del sistema sociopolitico da essi respinto, erano altrettanto bloccati quando si trattava di applicare le stesse regole di analisi critica al sistema da essi considerato il futuro dell’umanità intera” (p. 192).
Questo insieme di razionalizzazioni autoingannatrici, come pure le numerose prove di un’identità ebraica, si evincono dai commenti di Jacub Berman, uno dei leader più prominenti del dopoguerra. (Tutti e tre i leader comunisti che dominarono la Polonia tra il 1948 e il 1956, ovvero Berman, Boleslaw Bierut e Hilary Minc, erano ebrei.) In merito alle epurazioni e all’uccisione di migliaia di comunisti, inclusi molti ebrei, nell’Unione Sovietica durante anni ’30, Berman commenta:
Cercavo come meglio potevo di spiegare ciò che stava accadendo; di chiarire il retroscena, le situazioni piene di conflitto e contraddizioni interne in cui Stalin probabilmente si era trovato e che lo avevano spinto ad agire come fece; di esagerare gli errori dell’opposizione, i quali assunsero proporzioni grottesche nelle successive accuse nei loro confronti e furono ulteriormente ingranditi dalla propaganda sovietica. Al tempo ci voleva grande resistenza e dedizione alla causa per accettare ciò che stava accadendo malgrado tutte le distorsioni, le ferite e i tormenti. (In Toranska 1987, 207)
Per quanto riguarda la sua identità ebraica, quando gli fu chiesto quali fossero i suoi progetti dopo la guerra, Berman rispose:
Non avevo nessun progetto in particolare. Ma ero consapevole del fatto che, in quanto ebreo, non avrei dovuto né potuto ricoprire massime cariche. D’altronde non mi dispiaceva non essere in prima fila: non perché sono particolarmente umile di natura, ma perché non è affatto vero che per esercitare un vero potere occorre porsi in una posizione di prominenza. Per me, l’importante era esercitare la mia influenza, lasciare la mia impronta sulla complicata formazione del governo
61
che si stava creando, ma senza espormi. Naturalmente ciò richiedeva una certa destrezza. (In Toranska 1987, 237)
Chiaramente Berman si identifica come ebreo ed è ben consapevole del fatto di essere percepito dagli altri come tale, e per questa ragione sente di dover assumere ingannevolmente un profilo pubblico più basso. Berman fa inoltre notare il fatto di essere stato oggetto di sospetto in quanto ebreo durante la campagna contro i “cosmopoliti” iniziata alla fine degli anni ’40. Suo fratello, attivista nel Comitato centrale degli ebrei polacchi (organizzazione mirata a creare una cultura ebraica laica nella Polonia comunista), emigrò in Israele nel 1950 per evitare le conseguenze delle politiche antisemitiche di ispirazione sovietica in Polonia. Berman precisa che non seguì il fratello in Israele sebbene questi glielo avesse vivamente consigliato: “Naturalmente, mi interessava ciò che succedeva in Israele, specialmente perché conoscevo piuttosto bene la gente da quelle parti” (in Toranska 1987, 322). Ovviamente, Berman era visto dal fratello non come un non ebreo, ma piuttosto come un ebreo che avrebbe dovuto emigrare a causa dell’antisemitismo incipiente. Gli stretti legami di famiglia e amicizia tra un ufficiale al vertice del governo comunista polacco e un attivista nell’organizzazione dedicata alla promozione della cultura ebraica laica in Polonia evidenziano ulteriormente che non veniva percepita alcuna incompatibilità nell’identificarsi come ebrei e come comunisti, nemmeno tra i comunisti polacchi ebrei più assimilati dell’epoca.
Mentre i membri ebrei vedevano il KPP come favorevole agli interessi ebraici, il partito era visto dai polacchi gentili come “filosovietico, antipatriottico ed etnicamente ‘non realmente polacco’” (Schatz 1991, 82). Questa percepita mancanza di patriottismo era alla base dell’ostilità pubblica verso il KPP (Schatz 1991, 91).
Da un lato, per gran parte della sua esistenza il KPP era stato ai ferri corti non solo con lo Stato polacco ma con l’intera nazione, inclusi i partiti dell’opposizione legale della sinistra. Dall’altro, agli occhi della stragrande maggioranza dei polacchi, il KPP era una sovversiva agenzia straniera di Mosca, intenzionata a distruggere l’indipendenza della Polonia, conquistata a fatica, e a integrare la Polonia nell’Unione Sovietica. Bollato come “agenzia sovietica” o “comune ebraica”, esso era considerato un complotto pericoloso e fondamentalmente anti-polacco volto a minare la sovranità nazionale e a restaurare, sotto nuove vesti, la dominazione russa. (Coutouvidis & Reynolds 1986, 115)
Il KPP appoggiò l’Unione Sovietica nella guerra polacco-sovietica del 1919-1920 e nell’invasione sovietica del 1939. Durante la seconda guerra mondiale, inoltre, accettò il confine con l’URSS e si mostrò relativamente indifferente verso il massacro sovietico di prigionieri polacchi,
62
mentre il governo polacco in esilio a Londra aveva opinioni nazionaliste a riguardo. L’esercito sovietico e i suoi alleati polacchi, “spinti dal freddo calcolo politico, dalle necessità militari, o da entrambi”, lasciarono che la rivolta dell’Esercito nazionale polacco, fedele al governo non comunista in esilio, venisse sconfitta dai tedeschi, causando 200 000 morti e spazzando via così “il fior fiore dell’élite attivista non comunista e anticomunista” (Schatz 1991, 188). Appena finita la guerra, i sovietici arrestarono anche i leader della resistenza non comunista sopravvissuti.
Per di più, così come accadeva nel caso del CPUSA, la dirigenza ebraica e il coinvolgimento ebraico nel comunismo polacco erano in realtà ben più forti di quanto apparissero in superficie: venivano reclutati polacchi etnici e promossi ad alte cariche per minimizzare l’impressione che il KPP fosse un movimento ebraico (Schatz 1991, 97). Questo calcolato tentativo di sminuire la presenza ebraica del movimento comunista era presente anche nello ZPP. (Lo ZPP si riferisce all’Unione dei patrioti polacchi – nome orwelliano di un’organizzazione di facciata comunista, creata dall’Unione Sovietica per occupare la Polonia dopo la guerra.) A parte i membri de “la generazione” sulla cui lealtà politica si poteva contare e che formavano il nucleo dirigenziale del gruppo, gli ebrei erano spesso dissuasi dall’unirsi al movimento per paura che quest’ultimo apparisse troppo ebraico. Tuttavia, gli ebrei che fisionomicamente potevano spacciarsi per polacchi venivano autorizzati a iscriversi ed erano incoraggiati a dichiararsi polacchi etnici e ad assumere nomi tipicamente polacchi. “Non tutti erano invitati [a ricorrere all’inganno], e ad alcuni venivano risparmiate tali proposte perché nel loro caso non si sarebbe potuto far nulla: avevano un aspetto fin troppo ebraico” (Schatz 1991, 185).
Salito al potere al termine della guerra, questo gruppo favoriva gli interessi politici, economici e culturali sovietici in Polonia, e al tempo stesso perseguiva interessi specificamente ebraici, inclusa la distruzione dell’opposizione politica nazionalista, il cui aperto antisemitismo derivava in parte dal fatto che gli ebrei erano percepiti come sostenitori della dominazione sovietica.77 L’epurazione del gruppo di Wladyslaw Gomulka subito dopo la guerra portò alla promozione degli ebrei e al divieto assoluto dell’antisemitismo. Per di più, il contrasto generale tra il governo comunista polacco prevalentemente ebreo appoggiato dai sovietici e l’opposizione clandestina, nazionalista e antisemitica contribuiva ad alimentare la fedeltà della stragrande maggioranza della popolazione ebraica verso il governo comunista, mentre la stragrande maggioranza dei polacchi non ebrei appoggiava i partiti antisovietici (Schatz 1991, 204-205). Tutto ciò portò a un diffuso antisemitismo: nell’estate del 1947, erano già stati uccisi circa 1 500 ebrei in incidenti avvenuti in 155 località. Nelle parole del cardinale Hlond, espresse nel 1946 riguardo a un incidente in cui furono uccisi 41 ebrei, il pogrom era “dovuto agli ebrei che oggi occupano i gradi più alti nel governo della Polonia e che cercano di
63
introdurre una struttura governativa non voluta dalla maggioranza dei polacchi” (in Schatz 1991, 107).
Il governo comunista dominato dagli ebrei cercava attivamente di rianimare e perpetuare la vita ebraica in Polonia (Schatz 1991, 208) cosicché, come nel caso dell’Unione Sovietica, non ci aspettava che il giudaismo sarebbe svanito sotto un regime comunista. Gli attivisti ebrei avevano una “visione etnopolitica” secondo cui la cultura ebraica laica sarebbe andata avanti in Polonia con la collaborazione e l’approvazione del governo (Schatz 1991, 230). Mentre il governo lottava attivamente contro il potere politico e culturale della chiesa cattolica, la vita collettiva ebraica prosperava nel periodo postbellico. Si fondarono scuole di lingua yiddish ed ebraica, nonché un’ampia gamma di organizzazioni culturali e di assistenza sociale per gli ebrei. Una percentuale significativa della popolazione ebraica lavorava presso le cooperative economiche ebraiche.
Inoltre, il governo dominato dagli ebrei considerava la popolazione ebraica, tra cui molti non erano mai stati comunisti, come “una riserva degna di fiducia e arruolabile negli sforzi per ricostruire il paese. Benché non fossero vecchi compagni ‘collaudati’, non erano radicati nelle reti della società anticomunista, erano estranei alle sue tradizioni storiche, non avevano legami con la chiesa cattolica ed erano odiati da chi odiava il regime.78 Erano perciò affidabili e utilizzabili per ricoprire gli incarichi necessari ” (Schatz 1991, 212-213).
L’etnicità ebraica era particolarmente importante nel reclutamento per il servizio di sicurezza interna: “la generazione” di ebrei comunisti sapeva che il proprio potere derivava interamente dall’Unione Sovietica e che sarebbe dovuto ricorrere alla coercizione per controllare una società non comunista essenzialmente ostile (p. 262). I più importanti membri del servizio di sicurezza erano reclutati tra ebrei che erano comunisti da prima ancora che si instaurasse il governo comunista polacco, ma a questi si univano altri ebrei simpatizzanti del governo e alienati dalla società più ampia. Ciò a sua volta rafforzava l’immagine popolare degli ebrei come servitori degli interessi stranieri e nemici dei polacchi etnici (Schatz 1991, 225).
I membri ebrei della forza di sicurezza interna spesso sembravano essere motivati dalla rabbia personale e dal desiderio di vendetta legati alla loro identità ebraica:
Le loro famiglie erano rimaste uccise e l’opposizione clandestina anticomunista era essenzialmente, nella loro percezione, una continuazione della stessa tradizione antisemitica e anticomunista. Odiavano chi aveva collaborato con i nazisti e chi si opponeva al nuovo ordine con quasi la stessa intensità e,
64
essendo comunisti, ovvero essendo comunisti ed ebrei, sapevano di essere odiati con almeno pari intensità. Ai loro occhi si trattava essenzialmente del medesimo nemico. Bisognava punire le vecchie malefatte e prevenirne delle nuove, ed era necessaria una lotta impietosa prima di poter creare un mondo migliore. (Schatz 1991, 226)
Come nel caso dell’Ungheria del secondo dopoguerra (si veda qui di seguito), la Polonia si polarizzava tra una classe dirigente e amministrativa prevalentemente ebraica, appoggiata dal resto della comunità ebraica e dal potere militare sovietico, e la stragrande maggioranza della popolazione autoctona gentile. La situazione era esattamente analoga ai molti esempi delle società tradizionali in cui gli ebrei costituivano uno strato intermedio tra un’élite regnante straniera, nella fattispecie i sovietici, e la popolazione autoctona gentile (si veda PTSDA, cap. 5). Tuttavia, questo ruolo di intermediario trasformò coloro che erano stati fino ad allora degli outsider in un gruppo di élite in Polonia, e gli ex campioni della giustizia sociale facevano di tutto per difendere le loro prerogative personali, abbondante razionalizzazione e autoinganno compresi (p. 261). Infatti, quando nel 1954 divennero noti i racconti di un disertore sullo stile di vita lussuoso dell’élite (p. es., Boleslaw Bierut possedeva quattro ville e ne aveva a disposizione altre cinque [Toranska 1987, 28]), sulla loro corruzione, nonché sul loro ruolo di agenti sovietici, i ranghi più bassi del partito rimasero sconvolti (p. 266). È evidente che il senso di superiorità morale e le motivazioni altruistiche di questo gruppo rientravano interamente nei loro autoinganni.
Sebbene si cercasse di dare un volto polacco a quello che in realtà era un governo dominato dagli ebrei, questi tentativi erano vanificati dalla mancanza di polacchi affidabili in grado di ricoprire incarichi nel partito comunista, nell’amministrazione statale, nelle forze militari e nelle forze dell’ordine interne. Negli avanzamenti di carriera, erano privilegiati gli ebrei che avevano reciso i legami formali con la comunità ebraica, o che avevano assunto nomi tipicamente polacchi, o che potevano sembrare polacchi per fisionomia o mancanza di un accento ebraico (p. 214).
Qualunque fossero le soggettive identità personali degli individui reclutati per queste posizioni statali, chi li reclutava lo faceva chiaramente considerando l’estrazione etnica dell’individuo come indicatore di affidabilità, e di conseguenza la situazione era simile ai tanti esempi nelle società tradizionali in cui gli ebrei e i cripto-ebrei formavano reti economiche e politiche di correligiosi: “Oltre a un gruppo di politici influenti, troppo piccolo per essere definito una categoria, c’erano i soldati; gli apparatčik e gli amministratori; gli intellettuali e gli ideologi; i poliziotti; i diplomatici; e infine, gli attivisti nel settore ebraico. C’era anche la massa della gente comune – funzionari, artigiani e operai – il cui comune denominatore era una visione ideologica condivisa, una storia pregressa, e aspirazioni etniche essenzialmente simili” (p. 226).
65
È significativo che man mano che la dominazione ebraica diminuiva gradualmente nella seconda metà degli anni ’50, molti di questi individui cominciavano a lavorare nelle cooperative economiche ebraiche, e gli ebrei estromessi dal servizio di sicurezza interno ricevevano assistenza da organizzazioni finanziate in ultima analisi dagli ebrei americani. Possono esserci ben pochi dubbi sulla loro ininterrotta identità ebraica e sulla continuazione del separatismo economico e culturale ebraico. Infatti, dopo il crollo del regime comunista in Polonia, “numerosi ebrei, tra cui figli e nipoti di ex-comunisti, uscirono allo scoperto” (Anti-Semitism Worldwide 1994, 115), adottando apertamente un’identità ebraica e rafforzando l’idea che molti comunisti ebrei fossero in realtà cripto-ebrei.
Quando, in seguito al cambiamento nella politica sovietica nei confronti di Israele, il movimento antisionista-antisemita nell’Unione Sovietica penetrò anche in Polonia alla fine degli anni ’40, si ebbe un’altra crisi di identità scaturita dall’idea che l’antisemitismo e il comunismo fossero tra loro incompatibili. Una delle reazioni era costituita dal ricorso alla “auto-abnegazione etnica” con dichiarazioni che negavano l’esistenza di un’identità ebraica; un’altra era quella di raccomandare agli ebrei di non esporsi troppo. A causa della fortissima identificazione con il sistema diffusa tra gli ebrei, la tendenza generale era quella di razionalizzare anche la propria persecuzione durante il periodo in cui gli ebrei venivano gradualmente estromessi da posizioni importanti: “Anche quando i metodi diventavano inaspettatamente dolorosi e duri, quando diventava palese l’obiettivo di ricorrere alla forza per ottenere un’ammissione di reati non commessi e per incastrare altre persone, e quando emergeva la percezione di essere trattati ingiustamente con metodi che contraddicevano l’etica comunista, le fondamentali convinzioni ideologiche rimanevano immutate. Trionfò, perciò, la santa follia, perfino nelle celle del carcere” (p. 260). Infine, un importante elemento nella campagna antiebraica degli anni ’60 era l’asserzione che gli ebrei comunisti della Generazione si opponevano alla politica mediorientale dell’Unione Sovietica che favoriva gli arabi.
Come per i gruppi ebraici nel corso della storia (si veda PTSDA, cap. 3), le epurazioni antiebraiche non portarono all’abbandono della lealtà di gruppo anche quando ne seguivano persecuzioni ingiuste. Invece, ne conseguì un aumentato impegno, una “disciplina ideologica incrollabile, e un’obbedienza che rasentava l’autoinganno… Consideravano il partito la personificazione collettiva delle forze progressiste della storia e, ritenendosi suoi servitori, esprimevano un tipo particolare di dogmatismo teleologico-deduttivo, arroganza rivoluzionaria e ambiguità morale” (pp. 260-261). Infatti, ci sono elementi per credere che questa coesione di gruppo diventasse più accentuata man mano che le sorti della generazione volgevano al peggio (p. 301). Man mano che la loro posizione veniva gradualmente erosa da un nascente nazionalismo polacco antisemita, diventavano sempre più consapevoli di costituire un gruppo. Dopo la loro sconfitta finale, persero rapidamente qualsiasi traccia di identità polacca avessero e assumevano senza indugio un’aperta identità ebraica, particolarmente in Israele, destinazione della maggior parte degli ebrei polacchi.
66
Arrivarono a vedere il loro precedente antisionismo come un errore e ora diventavano forti sostenitori di Israele (p. 314).
In conclusione, l’opera di Shatz dimostra che ‘la generazione’ di comunisti ebrei e i loro sostenitori di etnia ebraica devono essere considerati come un gruppo ebraico storico. I fatti riscontrati indicano che questo gruppo perseguiva interessi specificamente ebraici, compreso l’interesse a garantire la continuità di gruppo ebraica e al tempo stesso a distruggere istituzioni quali la Chiesa cattolica e altre manifestazioni di nazionalismo polacco che promuovevano la coesione sociale tra polacchi. Il governo comunista, inoltre, lottava contro l’antisemitismo e tutelava gli interessi politici ed economici ebraici. Sebbene il grado di identità ebraica soggettiva all’interno di questo gruppo fosse certamente variabile, gli elementi riscontrati indicano livelli di identità ebraica sommersi e autoingannatori perfino tra i più assimilati del gruppo. L’intero episodio illustra la complessità dell’identificazione ebraica ed esemplifica l’importanza dell’autoinganno e della razionalizzazione quali aspetti fondamentali del giudaismo come strategia evolutiva di gruppo (si veda SAID, capp. 7, 8). Si assisteva a un massiccio ricorso all’autoinganno e alla razionalizzazione sul ruolo svolto dal governo dominati dagli ebrei e dai suoi sostenitori ebrei nell’eliminazione delle élite nazionaliste gentili, sul suo ruolo nell’opporsi alla cultura nazionale polacca e alla Chiesa cattolica man mano che si costruiva una cultura ebraica laica, sul suo ruolo di agente nella dominazione sovietica della Polonia, e sul suo successo alla guida dell’economia polacca, che veniva sfruttata per soddisfare interessi sovietici al costo di ristrettezze e sacrifici per il resto del popolo.
RADICALISMO E IDENTIFICAZIONE EBRAICA NEGLI STATI UNITI E IN INGHILTERRA
Dagli inizi del movimento nel tardo XIX secolo, un forte senso di identificazione ebraica contraddistingueva anche i radicali ebrei americani (p.es., l’Union of Hebrew Trades [Sindacato dei mestieri ebraici, N.d.T.] e la Jewish Socialist Federation [Federazione socialista operaia, N.d.T.]; si vedano Levin 1977; Liebman 1979). Nello studio di Sorin (1985) sui radicali ebrei immigrati negli Uniti Stati nel primo XX secolo, solo il 7 percento era avverso a qualsiasi forma di separatismo ebraico. Oltre il 70 percento “era intriso di positiva coscienza ebraica. La grande maggioranza era fortemente invischiata in un groviglio di istituzioni, associazioni e formazioni sociali ebraiche che si sovrapponevano le une alle altre” (p. 119). Per di più, dei 95 radicali, “al massimo” 26 rientravano nelle categorie “ostile, ambivalente, o assimilazionista” di Soren, ma “in alcuni, se non tutti i casi, queste erano persone che si sforzavano, spesso in maniera creativa, di formare nuove identità” (p. 115)
67
Un tema importante di questo capitolo è che un gran numero dei radicali ebrei dichiaratamente “sradicati” manteneva percezioni autoingannatrici riguardo alla propria mancanza di identificazione ebraica. La tendenza generale è illustrata dal seguente commento su una ben nota radicale ebrea americana:
Le pagine della Mother Earth, rivista di cui Emma Goldman era la redattrice dal 1906 al 1917, sono piene di storie yiddish, racconti dal Talmud e traduzioni delle poesie di Morris Rosenfeld. Per di più, il suo impegno verso l’anarchismo non le impediva di parlare e scrivere, sovente e apertamente, in merito agli oneri particolari che gli ebrei dovevano affrontare in un mondo in cui l’antisemitismo era un nemico vivente. A quanto pare, la fede di Emma Goldman nell’anarchismo, con enfasi sull’universalismo, non derivava né dipendeva dall’abbandono dell’identità ebraica. (Sorin 1985, 8; corsivo nel testo)
Il radicalismo ebraico del XX secolo era una subcultura specificamente ebraica, o una “controcultura”, per usare il termine di Arthur Liebman (1979, 37). La sinistra ebraica americana non si si è mai separata dalla più ampia comunità ebraica, e anzi, la partecipazione degli ebrei nel movimento fluttuava in base agli eventuali conflitti tra questi movimenti e gli interessi specificamente ebraici.79
Fondamentalmente, la vecchia sinistra ebraica, compresi i sindacati, la stampa di sinistra e le confraternite di sinistra (spesso legate a una sinagoga [Liebman 1979, 284]), faceva parte della comunità ebraica più ampia, e quando la classe operaia ebraica entrò in declino, l’importanza delle credenze politiche radicali diminuiva in concomitanza con una crescente rilevanza dell’identità e delle questioni specificamente ebraiche.
Questa tendenza dei membri ebrei delle organizzazioni di sinistra a occuparsi specificamente di questioni ebraiche aumentò dopo il 1930, essenzialmente per via delle ricorrenti divergenze tra gli interessi specificamente ebraici e le cause universaliste di sinistra all’epoca. Questo fenomeno si verificava nell’intera gamma delle organizzazioni di sinistra, incluse organizzazioni quali il partito comunista e quello socialista, tra i cui iscritti figuravano anche gentili (Liebman 1979, 267 segg.).
Il separatismo nei movimenti di sinistra era agevolato da un aspetto molto tradizionale del separatismo ebraico – l’uso di una lingua ingroup. Lo yiddish divenne infine molto apprezzato per il suo effetto unificatore sul movimento operaio ebraico e per la capacità di forgiare legami con la comunità ebraica più ampia (Levin 1977, 210; Liebman 1979, 259-260). “I landsmanshaften [club sociali ebraici], la stampa e il teatro yiddish, i caffè socialisti dell’East Side, le società letterarie e fereyns [associazioni, N.d.T.], che costituivano una parte così caratteristica della cultura socialista ebraica, creavano un milieu inequivocabilmente ebraico che né il negozio, né il sindacato, né il partito socialista potevano sperare di replicare.
68
Perfino il nemico di classe – il datore di lavoro ebreo – parlava yiddish” (Levin 1977, 210).
Infatti, il programma di istruzione socialista del Workman’s Circle [Circolo operaio, N.d.T.] (la più grande confraternita operaia agli inizi del XX secolo) andò in fallimento in un primo momento (prima del 1916) a causa della mancanza di contenuto yiddish ed ebraico: “Perfino i genitori ebrei radicali volevano che i propri figli imparassero lo yiddish e conoscessero qualcosa del loro popolo” (Liebman 1979, 292). Queste scuole cominciarono a prosperare quando introdussero un curriculum ebraico con un’enfasi sull’identità storica ebraica. Perdurarono negli anni ’40 come scuole ebraiche con un’ideologia socialista che enfatizzava l’idea che l’impegno per la giustizia sociale fosse la chiave per la sopravvivenza ebraica nel mondo moderno. Chiaramente, il socialismo e la politica progressista erano diventati una forma di giudaismo laico. L’organizzazione era stata trasformata nel corso della sua storia da “una confraternita operaia radicale con membri ebrei in una confraternita ebraica dai sentimenti progressisti e dal passato socialista” (Liebman 1979, 295).
Analogamente, la subcultura ebraica di orientamento comunista, incluse organizzazioni quale l’International Workers Order [Ordine operaio internazionale, N.d.T.] (IWO), comprendeva sezioni di lingua yiddish. Una di queste sezioni, la Jewish Peoples Fraternal Order (JPFO) [Confraternita dei popoli ebrei, N.d.T.], era un’associazione affiliata dell’American Jewish Congress (AJCongress) ed era segnalata dal Procuratore generale degli Stati Uniti come organizzazione sovversiva. La JPFO contava 50 000 iscritti ed era il “baluardo” finanziario e organizzativo del CPUSA nel secondo dopoguerra; inoltre, contribuiva in modo determinante al finanziamento del Daily Worker e del Morning Freiheit (Svonkin 1997, 166). In linea con l’enfasi di allora circa la compatibilità del comunismo-radicalismo con l’identità ebraica, essa finanziava programmi di educazione infantile che promulgavano un forte legame tra l’identità ebraica e le cause radicali. Le scuole yiddish e i campi estivi dell’IWO, che continuarono fino agli anni ’60, mettevano in primo piano la cultura ebraica, reinterpretando perfino il marxismo non come teoria di lotta di classe ma piuttosto come teoria di lotta per la libertà degli ebrei oppressi. Sebbene alla fine l’AJCongress abbia tagliato i ponti con la JPFO all’epoca della guerra fredda e proclamato il comunismo una minaccia, era “a dir poco, una partecipante riluttante e poco entusiasta” (Svonkin 1977, 132) allo sforzo ebraico per creare un’immagine pubblica di anticomunismo – un atteggiamento conforme alle simpatie di molti dei suoi membri, prevalentemente immigrati dell’Europa dell’Est di seconda e terza generazione.
David Horowitz (1997, 42) descrive il mondo dei suoi genitori, che si erano iscritti a una “shul” gestita dal CPUSA dove si dava un’interpretazione politica alle festività ebraiche. Dal punto di vista psicologico, era come se questi individui si trovassero nella Polonia del XVIII secolo:
69
Ciò che fecero i miei genitori iscrivendosi al partito comunista e trasferendosi a Sunnyside era un ritornare al ghetto. C’era lo stesso linguaggio privato condiviso, lo stesso universo ermeticamente sigillato, la stessa duplice postura che mostrava un volto al mondo esterno e un altro alla tribù. Sopratutto, c’era la stessa convinzione di essere bollati per la persecuzione e di essere specialmente predestinati, il senso di superiorità morale verso i goyim fuori, più potenti e numerosi. E c’era la stessa paura di espulsione per pensieri eretici, paura che legava gli eletti alla fede.
Un forte senso dell’identità storica ebraica era caratteristico della stampa yiddish di sinistra. In una lettera al radicale Jewish Daily Forward, un lettore si lamentava che i suoi genitori non religiosi fossero dispiaciuti perché egli voleva sposare una non ebrea. “Egli scrisse al Forward nella presunzione di trovarvi empatia, solo per scoprire che i direttori socialisti e liberali del giornale insistettero… che fosse imperativo che egli sposasse un’ebrea e che continuasse a identificarsi con la comunità ebraica… coloro che leggevano il Forward sapevano che la determinazione degli ebrei a rimanere ebrei era fuori dubbio e discussione” (Hertzberg 1989, 211-212). Il Forward era il periodico ebraico più diffuso al mondo fino agli anni ’30 e manteneva stretti legami con il partito socialista.
Werner Cohn (1958, 621) descrive il milieu generale della comunità ebraica immigrata dal 1886 al 1920 come “un grande circolo di discussione”:
Nel 1886 la comunità ebraica a New York era diventata cospicua per il suo sostegno al candidato del terzo partito (United Labor Party [Partito unito del lavoro, N.d.T.]), Henry George, teorico dell’Imposta unica. Da allora in poi, i quartieri ebraici a New York e altrove sarebbero diventati famosi per le loro abitudini radicali di voto. Il Lower East Side scelse ripetutamente Meyer London come deputato, l’unico socialista di New York a essere eletto al Congresso. Inoltre, molti socialisti di quartieri ebraici furono eletti all’assemblea legislativa ad Albany. Nella campagna del 1917 per l’elezione del sindaco di New York City, la candidatura socialista e pacifista di Morris Hillquit era appoggiata dai più importanti organi di rappresentanza del Lower East Side ebraico: l’United Hebrew Trades [Unione ebraica del lavoro, N.d.T.], l’International Ladies Garment Workers’ Union [Sindacato per le lavoratrici dell’abbigliamento, N.d.T.], e soprattutto, il popolarissimo yiddish Daily Forward. Si tratta dello stesso periodo in cui gli ultra-radicali – come Alexander Berkman ed Emma Goldman – erano colossi della comunità ebraica, e quando
70
quasi tutti i colossi ebrei – tra cui Abraham Cahan, Morris Hillquit, e il giovane Morris R. Cohen – erano radicali. Perfino Samuel Gompers, nei suoi discorsi davanti a un pubblico ebraico, giudicava necessario l’uso di frasi radicali.
In più, The Freiheit, organo ufficioso del partito comunista tra gli anni ’20 e ’50, “si collocava al centro delle istituzioni proletarie e della subcultura yiddish… [le quali] offrivano identità, significato, amicizia e comprensione” (Liebman 1979, 349-350). Il giornale perse molto del sostegno della comunità ebraica nel 1929 quando abbracciò la posizione del partito comunista contro il sionismo, e negli anni ’50 fu costretto essenzialmente a scegliere tra soddisfare la sua anima ebraica o il suo status di organo comunista. Avendo scelto la prima opzione, già alla fine degli anni ’60 si trovava in opposizione alla linea del CPUSA sulla restituzione dei territori occupati da Israele.
La relazione tra gli ebrei e il CPUSA è particolarmente interessante dal momento che il partito abbracciava spesso posizioni antiebraiche, specialmente alla luce dei suoi stretti rapporti con l’Unione Sovietica. A partire dalla fine degli anni ’20 gli ebrei giocavano un ruolo di primissimo piano nel CPUSA (Klehr 1978, 37 segg.). La semplice valutazione delle percentuali di leader ebrei, tuttavia, non è un’indicazione adeguata della portata dell’influenza ebraica, dato che non tiene conto né delle caratteristiche personali dei radicali ebrei come gruppo colto, ambizioso e talentuoso (si vedano pp. 5, 95-96), né profusi sforzi per reclutare gentili come “facciata” al fine di nascondere la portata della dominazione ebraica (Klehr 1978, 40; Rothman & Lichter 1982, 99). Lyons (1982, 81) cita un comunista gentile secondo cui molti gentili della classe operaia credevano di essere stati reclutati per “diversificare la composizione etnica del partito.” Questo testimone racconta la sua esperienza come rappresentante gentile a una conferenza della gioventù di sponsorizzazione comunista:
Diventava sempre più evidente alla maggior parte dei partecipanti che praticamente tutti gli oratori erano ebrei di New York. Oratori dai marcati accenti newyorkesi si presentavano come “il delegato del Lower East Side” o “il compagno di Brownsville.” Infine la dirigenza nazionale ordinò un’interruzione per discutere di ciò che stava diventando imbarazzante. Com’era possibile che un’organizzazione che si ostentava nazionale fosse talmente dominata da ebrei newyorkesi? Alla fine, decisero di intervenire e di rimediare alla situazione chiedendo al caucus di New York di dare a “chi veniva da fuori città [New York, N.d.T.]” l’opportunità di parlare. Il convegno si tenne nel Wisconsin.
71
Klehr (1978, 40) stima che dal 1921 al 1961 gli ebrei costituissero il 33,5 percento dei membri del Comitato centrale, e la rappresentanza di ebrei superasse spesso il 40 percento (Klehr 1978, 46). Gli ebrei erano l’unico gruppo etnico autoctono dal quale il partito poteva attingere per reclutare membri. Glazer (1969, 129) afferma che fino agli anni ’50 almeno la metà dei 50 000 iscritti al CPUSA era costituita da ebrei e che il tasso di ricambio era molto alto; pertanto, forse un numero dieci volte superiore di individui erano coinvolti nel partito e c’era “un numero altrettanto elevato se non superiore di socialisti di qualche tipo.” Negli anni ’20, Buhle (1980, 89) osserva che “la maggior parte di quanti erano favorevoli al partito e al Freiheit semplicemente non si iscriveva – non più di qualche migliaio su un seguito cento volte superiore.”
Ethel e Julius Rosenberg, condannati per spionaggio a favore dell’Unione Sovietica, incarnano il forte senso di identificazione ebraica tra molti ebrei di sinistra. Svonkin (1997, 158) fa notare che si consideravano martiri ebrei. Così come tanti altri ebrei di sinistra, percepivano un forte legame tra il giudaismo e le loro simpatie comuniste. La loro corrispondenza in prigione, a detta di un critico, era intrisa di “una continua manifestazione di ebraismo e di ebraicità,” incluso il commento: “fra qualche giorno arriverà la Pasqua ebraica, celebrazione della ricerca di libertà del nostro popolo. Questa eredità culturale ha un significato addizionale per noi che siamo incarcerati, lontani l’uno dall’altro e dai nostri cari, dai moderni faraoni” (pp. 158-159). Imbarazzata dalle autopercezioni dei Rosenberg come martiri ebrei, l’Anti-Defamation League [ADL] interpretò le dichiarazioni di Julius Rosenberg sul suo essere ebreo come un tentativo di ottenere “ogni possibile briciolo di vantaggio dalla fede da egli ripudiata” [Svonkin 1997, 159] – un altro esempio dei tanti tentativi revisionistici, alcuni dei quali esaminati in questo capitolo, di rendere incompatibile l’identificazione ebraica con il radicalismo politico e nascondere pertanto un importante capitolo della storia ebraica.)
Come nel caso dell’Unione Sovietica nei primi tempi, il CPUSA aveva diverse sezioni per diversi gruppi etnici, inclusa una federazione ebraica di lingua yiddish.80 Quando queste furono abolite nel 1925 al fine di formare un partito che piacesse agli americani nati nel Paese (che tendevano ad avere un ridotto livello di coscienza etnica), ci fu un esodo di massa di ebrei dal partito, e molti di quanti vi rimanevano continuavano a prendere parte a un’ufficiosa subcultura yiddish nel partito.
Negli anni che seguirono, il sostegno ebraico cresceva e calava a seconda dell’appoggio del partito a questioni specificamente ebraiche. Durante gli anni ’30 il CPUSA cambiò posizione e fece di tutto per interessarsi a specifici interessi ebraici, inclusi un’enfasi primaria sull’antisemitismo, il sostegno a favore del sionismo e alla fine di Israele, e la promozione dell’importanza di mantenere le tradizioni culturali ebraiche. Come nella Polonia di questo periodo, “Il movimento radicale americano
72
lodava la crescita della vita ebraica nell’Unione Sovietica… L’Unione Sovietica era la prova vivente che sotto il socialismo la questione ebraica poteva essere risolta” (Kann 1981, 152-153). Il comunismo pertanto era percepito come “favorevole agli ebrei”. Nonostante i problemi passeggeri causati dal Patto tedesco-sovietico di non aggressione del 1939, il risultato fu la fine dell’isolamento del CPUSA dalla comunità ebraica durante la seconda guerra mondiale e nei primi anni del dopoguerra.
Curiosamente, gli ebrei rimasti nel partito durante il periodo del Patto di non aggressione dovevano affrontare un difficile conflitto tra lealtà divise, segno che l’identità ebraica continuava ad essere importante per questi individui. Il Patto di non aggressione provocò non poca razionalizzazione da parte dei membri ebrei del CPUSA, spesso con un tentativo di interpretare le azioni dell’Unione Sovietica come effettivamente favorevoli agli interessi ebraici – una chiara indicazione che questi individui non avevano rinnegato la loro identità ebraica.81 Altri rimanevano iscritti ma si opponevano silenziosamente alla linea del partito per via delle proprie lealtà ebraiche. Il fatto che il Patto di non aggressione stava rovinando il loro rapporto con la più ampia comunità ebraica era per loro causa di grande preoccupazione.
Al tempo della fondazione di Israele nel 1948, parte dell’attrattiva del CPUSA per gli ebrei era dovuta al suo sostegno a Israele in un periodo in cui Truman si mostrava tentennante sulla questione. Nel 1946 il CPUSA adottò perfino una risoluzione che promuoveva la continuazione del popolo ebraico come entità etnica all’interno delle società socialiste. Arthur Liebman descrive l’euforia dei membri del CPUSA per la congruenza tra gli interessi ebraici e l’iscrizione al partito. Si esprimevano sentimenti di comunanza con la più ampia comunità ebraica e si riscontrava un accentuato senso di ebraicità derivato dalle interazioni con altri ebrei all’interno del CPUSA: durante il periodo postbellico “ci si aspettava e si incoraggiava che gli ebrei comunisti si comportassero da ebrei, si relazionassero con ebrei e guardassero il popolo ebraico e la cultura ebraica in una luce positiva. Al tempo stesso, gli ebrei non comunisti, salvo alcune notevoli eccezioni [nella sinistra ebraica non comunista]… accettarono le loro credenziali ebraiche e decisero di collaborare con loro in un contesto esclusivamente ebraico” (Liebman 1979, 514). Come si è verificato tante volte nella storia ebraica, questa impennata di identità ebraica era facilitata dalla persecuzione degli ebrei, nella fattispecie l’Olocausto.
Questo periodo di facile compatibilità degli interessi ebraici con quelli del CPUSA svanì dopo il 1948, soprattutto a causa della mutata posizione sovietica riguardo a Israele e delle rivelazioni di antisemitismo di stampo statale nell’Unione Sovietica e nell’Europa dell’Est. Di conseguenza, molti ebrei abbandonarono il partito. Ancora una volta, chi rimase nel CPUSA tendeva a razionalizzare l’antisemitismo sovietico in una maniera che consentiva di mantenere la propria identificazione ebraica. Alcuni consideravano le persecuzioni come un’aberrazione e il risultato di una patologia individuale anziché una colpa del sistema sovietico. Oppure si biasimava l’Occidente come indirettamente responsabile. Per di più, sembra che i motivi per rimanere nel CPUSA
73
solitamente comportassero un desiderio di restare nell’autonoma subcultura comunista yiddish. Liebman (1979, 522) descrive un individuo che infine diede le dimissioni quando le prove dell’antisemitismo sovietico diventarono schiaccianti: “Nel 1958, dopo più di 25 anni nel partito comunista, questo leader diede le dimissioni e sviluppò una forte identità ebraica che comprendeva una feroce lealtà verso Israele.” Alternativamente, i membri ebrei del CPUSA semplicemente si astenevano dall’adottare la linea del partito sovietico, come avvenne per la questione dell’appoggio a Israele durante le guerre del 1967 e 1973. Alla fine, ci fu una scissione quasi totale tra gli ebrei e il CPUSA.
La descrizione di Lyons (1982, 180) di un club ebreo-comunista a Philadelphia rivela l’ambivalenza e l’autoinganno che emergevano nei casi di conflitto tra gli interessi ebraici e le simpatie comuniste:
Il club… doveva far fronte alla crescente tensione sull’ebraicità, soprattutto per quanto riguardava Israele. A metà degli anni sessanta scoppiò un contrasto sulla decisione del club di criticare il trattamento sovietico degli ebrei. Alcuni membri ortodossi filosovietici diedero le dimissioni; altri si trovavano in disaccordo, ma restarono. Nel frattempo il club continuava a trasformarsi, diventando sempre meno marxista e sempre più sionista. Durante la guerra del 1967 nel Medio Oriente, a detta di Ben Green, uno dei leader del club, “diventammo dogmatici, per una settimana.” Non consentirono nessuna discussione sull’opportunità di appoggiare Israele, si limitarono invece a raccogliere fondi per dimostrare il loro pieno sostegno. Cionondimeno, alcuni membri del club ribadiscono che il club non è sionista e che quello a Israele è un “appoggio condizionato”.
Come nel caso della Polonia, è del tutto giustificato presumere che i comunisti ebrei americani ritenessero l’URSS generalmente disposta a soddisfare gli interessi ebraici almeno fino al tardo secondo dopoguerra. A partire dagli anni ’20 il CPUSA godeva del sostegno finanziario dell’Unione Sovietica, seguiva fedelmente le sue posizioni, e conduceva un’efficace campagna di spionaggio contro gli Stati Uniti per conto dell’Unione Sovietica, incluso il furto di segreti atomici (Klehr, Haynes & Firsov 1995).82 Negli anni ’30 gli ebrei “costituivano una sostanziale maggioranza dei membri noti del movimento clandestino sovietico negli Stati Uniti” e quasi la metà degli individui incriminati ai sensi della Smith Act of 1947 [legge Smith del 1947, N.d.T.] (Rothman & Lichter 1982, 100).
Sebbene non tutti i funzionari del partito saranno stati a conoscenza dei dettagli del rapporto speciale con l’Unione Sovietica, il ‘lavoro speciale’ [cioè lo spionaggio] era parte integrante della missione comunista negli Stati Uniti, e questo era risaputo e discusso apertamente nell’ufficio politico del CPUSA… Erano
74
questi comunisti comuni, le cui vite dimostrano che alcuni dei membri ordinari erano disposti a servire l’URSS facendo spionaggio contro il loro proprio paese. Altri comunisti americani avrebbero fatto altrettanto se lo avessero chiesto a loro. Il CPUSA osannava l’URSS come la terra promessa. Nella propaganda comunista la sopravvivenza dell’Unione Sovietica come unica stella luminosa dell’umanità era un costante ritornello, come nella poesia comunista americana del 1934 che descrive l’Unione Sovietica come “un paradiso… portato sulla Terra in Russia.” (Klehr et al. 1995, 324)
Klehr et al. (1995, 325) ipotizzano che il CPUSA abbia inciso in modo significativo sulla storia americana. Senza giustificare gli eccessi del movimento anticomunista, fanno notare che “non si può scindere la peculiare e singolare efficacia del movimento anticomunista americano dalla lealtà del CPUSA all’Unione Sovietica; era proprio l’idea che i comunisti americani fossero sleali a rendere la questione comunista tanto potente e talvolta velenosa.”
I comunisti ingannavano e mentivano ai New Dealer con i quali si erano alleati. Quei progressisti che avevano creduto alle smentite accusavano quindi di calunnia gli anticomunisti che denunciavano l’attività comunista nascosta. Furiosi per le smentite di ciò che sapevano veritiero, gli anticomunisti allora sospettavano che quanti avevano negato la presenza comunista fossero anch’essi disonesti. La doppiezza dei comunisti avvelenò le normali relazioni politiche e contribuì all’asprezza della reazione anticomunista nei tardi anni ’40 e negli anni ’50. (Klehr et al. 1995, 106)
La difesa progressista del comunismo durante la guerra fredda solleva inoltre delle questioni pertinenti a questo volume. Nicholas von Hoffman (1996) osserva il ruolo dei difensori progressisti del comunismo durante questo periodo, come per esempio i direttori del settimanale The New Republic e lo storico di Harvard Richard Hofstadter (1965), i quali attribuirono la preoccupazione contemporanea per l’infiltrazione comunista del governo statunitense allo “stile paranoico della politica americana.” (Rothman e Lichter [1982, 105] includono The New Republic in un gruppo di pubblicazioni progressiste e radicali con un’ampia presenza di scrittori ed editori ebrei.) Secondo la versione ufficiale progressista, i comunisti americani erano sui generis e non legati all’Unione Sovietica, perciò non c’era alcuna minaccia comunista domestica. Durante questo periodo i progressisti si ammantavano della superiorità morale e intellettuale. I sostenitori di McCarthy erano considerati dei primitivi intellettuali e culturali: “Nel continuo Kulturkampf che divideva la società, le élite di Hollywood, di Cambridge [Massachusetts, N.d.T.] e
75
dei think tank progressisti nutrivano poca simpatia per gli uomini con le gambe arcuate, i cappellini American Legion [associazione di mutua assistenza per i veterani delle forze armate americane, N.d.T.] e le mogli grasse, e il loro blaterare su Yalta e sulla foresta di Katyn. Cattolici e pacchiani, intenti a contemplare la loro collezione di fenicotteri di plastica rosa dalla finestra panoramica, i piccolo-borghesi e la loro angoscia per la politica estera erano troppo infra dignitatem per essere presi sul serio” (von Hoffman 1996, C2).
Tuttavia, oltre ad avvelenare l’atmosfera della politica domestica, lo spionaggio comunista si ripercuoteva anche sulla politica estera:
È difficile esagerare l’importanza dello spionaggio atomico sovietico nel plasmare la storia della guerra fredda. La seconda guerra mondiale era finita con gli americani fiduciosi che la bomba atomica assicurasse loro il monopolio sulla più formidabile delle armi, monopolio la cui durata prevista era da dieci a venti anni. La detonazione sovietica di una bomba nucleare nel 1949 distrusse questo senso di sicurezza fisica. L’America aveva combattuto due guerre mondiali senza subire pesanti perdite di civili o grave distruzione. Adesso doveva affrontare un nemico il cui capo era uno spietato dittatore capace di annientare qualsiasi città americana con una sola bomba.
Se il monopolio nucleare americano fosse durato più a lungo, Stalin forse non avrebbe permesso ai comunisti della Corea del Nord di scatenare la guerra di Corea, o forse i comunisti cinesi avrebbero esitato a intervenire nella guerra. Se il monopolio nucleare americano fosse durato fino alla morte di Stalin, il freno sull’aggressività sovietica avrebbe forse temperato gli anni più pericolosi della guerra fredda. (Klehr et al. 1995, 106)
La “controcultura” ebraica continuava a sostenere una subcultura radicale specificamente ebraica durante gli anni ’50 – molto tempo dopo che la stragrande maggioranza degli ebrei aveva cessato di appartenere alla classe operaia (Liebman 1979, 206, 289 segg.). Le istituzioni e le famiglie ebraiche che costituivano la vecchia sinistra si trasformarono poi nella nuova sinistra (Liebman 1979, 536 pagg.). L’impulso originario del movimento della protesta studentesca degli anni ’60 “cominciò quasi necessariamente con i rampolli dell’intellighenzia relativamente benestante, progressista-sinistroide e sproporzionatamente ebraica – la fonte maggiore, tra la popolazione, di quanti erano ideologicamente disposti a simpatizzare con l’azione radicale studentesca” (Lipset 1971, 83; si veda anche Glazer 1969). Flacks (1967, 64) rilevò che il 45 percento degli studenti che avevano partecipato a una protesta alla University of Chicago era composto da ebrei, ma il suo campione originario venne “‘aggiustato’ al fine di ottenere maggiore equilibrio” (Rothman & Lichter 1982, 82). Gli ebrei costituivano l’80 percento degli studenti firmatari di una petizione per chiudere il ROTC [Reserve Officers’ Training Corps, Corpo di addestramento per ufficiali della Riserva, N.d.T.] a Harvard e il 30-50 percento degli Students for a Democratic Society [Studenti per una società democratica, N.d.T.] (SDS), la principale organizzazione di studenti radicali.
76
Adelson (1972) constatò che il 90 percento del suo campione di studenti radicali della University of Michigan era composto da ebrei, e pare probabile che la percentuale di partecipazione fosse simile in altre università quali Wisconsin e Minnesota.83 Braungart (1979) constatò che il 43 percento degli iscritti alla SDS nel suo campione di dieci università aveva almeno un genitore ebreo e un altro 20 percento non aveva nessuna affiliazione religiosa. È probabile che questi ultimi fossero prevalentemente ebrei: Rothman e Lichter (1982, 82) constatarono che la “stragrande maggioranza” degli studenti radicali che professavano di avere genitori atei erano di estrazione ebraica.
Inoltre, i più noti leader delle proteste universitarie tendevano a essere ebrei (Sachar 1992, 804). Abbie Hoffman, Jerry Rubin e Rennie Davis acquistarono fama nazionale come membri del gruppo “Chicago Seven”, condannato per avere oltrepassato il confine statale con l’intento di istigare una rivolta al congresso annuale dei democratici del 1968. Cuddihy (1974, 804) fa notare il carattere apertamente etnico della trama secondaria del processo, particolarmente i battibecchi tra l’imputata Abbie Hoffman e il giudice Julius Hoffman, di cui la prima rappresentava i figli della generazione di immigrati dell’Europa dell’Est tendenti al radicalismo politico, e l’ultimo rappresentava l’establishment ebreo-tedesco più vecchio e maggiormente assimilato. Durante il processo, Abbie Hoffman derise il giudice Hoffman in yiddish come “Shande fur de Goyim” (una vergogna davanti ai goyim) – tradotto da Abbie Hoffman come “Lacchè dell’élite del potere WASP.” Chiaramente Hoffman e Rubin (che avevano trascorso del tempo in un kibbutz in Israele) nutrivano una forte identificazione ebraica e antipatia nei confronti dell’establishment bianco protestante. Cuddihy (974, 191-192) inoltre attribuisce le origini del movimento Yippie alle attività del giornalista clandestino Paul Krassner (direttore del The Realist, periodico “audace, scatologico, curiosamente apolitico” di “satira irreverente e reportage sgarbato”) e la sensibilità controculturale del cabarettista Lenny Bruce.
Come gruppo, gli studenti radicali provenivano da famiglie relativamente benestanti, mentre era più probabile che gli studenti conservatori provenissero da famiglie meno agiate (Gottfried 1993, 53).84 Il movimento fu pertanto concepito e guidato da un’élite, ma non mirava a favorire gli interessi della piccola borghesia sindacalizzata. Infatti, la nuova sinistra considerava la classe operaia come “grassa, compiaciuta, e conservatrice, e i suoi sindacati la rispecchiavano” (Glazer 1969, 123).
In aggiunta, sebbene tra i radicali ebrei della nuova sinistra esistessero lievi forme di antisemitismo ebraico e di ribellione contro l’ipocrisia dei genitori, lo schema predominante era quello di una continuità dell’ideologia genitoriale (Flacks 1967; Glazer 1969, 12; Lipset 1988, 393; Rothman & Lichter 1982, 82). (In modo analogo, durante l’epoca di Weimar i radicali della Scuola di Francoforte rinnegarono i valori commerciali dei loro genitori ma non disconobbero personalmente le proprie famiglie. Infatti, in linea di massima, le famiglie fornivano loro sostegno morale e finanziario nelle attività radicali [Cuddihy 1974, 154].) Molti di questi “bambini dal pannolino rosso” provenivano
77
da “famiglie che, intorno al tavolo della prima colazione, giorno dopo giorno, a Scarsdale, Newton, Great Neck e Beverly Hills, discutevano di quanto orribile, corrotta, immorale, poco democratica e razzista fosse la società americana. Molti genitori ebrei abitano nei quartieri esclusivamente bianchi, vanno a Miami Beach l’inverno, sono iscritti a costosi country club, organizzano bar mitzvah da migliaia di dollari – e nel contempo abbracciano un’ideologia progressista” (Lipset 1988, 393). Come sopra indicato, Glazer (1969) stima che circa un milione di ebrei fosse iscritto al CPUSA o che fosse socialista prima del 1950. Ne consegue che tra gli ebrei c’era “una fonte sostanziosa di genitori odierni per i quali avere figli radicali non è né scandaloso né strano, e anzi potrebbe essere considerato un modo per soddisfare i migliori impulsi dei genitori” (Glazer 1969, 129).
Per di più, “l’establishment ebraico americano non prese mai davvero le distanze da questi giovani ebrei” (Hertzberg 1989, 369). Infatti, organizzazioni dell’establishment ebraico quali l’AJCongress, l’Unione of American Hebrew Congregations [Unione delle congregazioni ebraiche americane, N.d.T.] (un gruppo laico riformista) e il Synagogue Council of America [Consiglio delle sinagoghe di America, N.d.T.] (Winston 1978), erano tra i primi noti oppositori alla guerra in Vietnam. È possibile che gli atteggiamenti pacifisti delle organizzazioni ebraiche ufficiali abbiano suscitato dell’antisemitismo. Il presidente Lyndon Johnson è stato descritto come “sconvolto per la mancanza di sostegno alla guerra in Vietnam da parte della comunità ebraica americana in un momento in cui egli prende nuovi provvedimenti per aiutare Israele” (in Winston 1978, 198), e l’ADL adottò precauzioni contro una reazione anti-ebraica che prevedeva si sarebbe verificata a causa del fatto che gli ebrei tendevano a essere falchi per le questioni militari riguardanti Israele e colombe per le questioni militari riguardanti il Vietnam (Winston 1978).
Come nella vecchia sinistra, molti della nuova sinistra ebraica si identificavano fortemente come ebrei (Liebman 1979, 536 segg.). Durante un’importante occupazione a Berkeley (Rothman & Lichter 1982, 81) si celebrò la Chanukkah e si cantò l’“Hatikvah” (l’inno nazionale israeliano). La nuova sinistra perdeva iscritti ebrei ogniqualvolta appoggiava posizioni incompatibili con interessi specificamente ebraici (particolarmente riguardanti Israele) e attirava iscritti quando le sue posizioni coincidevano con questi interessi (Liebman 1979, 527 segg.). Spesso i leader passavano tempo nei kibbutzim in Israele, e c’è motivo di credere che quelli della nuova sinistra cercassero consapevolmente di minimizzare i segni più evidenti dell’identità ebraica e di minimizzare il dibattito su questioni che avrebbero creato divisioni tra iscritti ebrei e non ebrei, in modo particolare Israele. Alla fine l’incompatibilità degli interessi ebraici con la nuova sinistra portò all’abbandono del partito da parte della maggioranza degli ebrei, molti dei quali si trasferivano in Israele per unirsi ai kibbutzim, partecipavano alle tradizionali celebrazioni religiose ebraiche, o si interessavano a organizzazioni di sinistra dall’identità specificamente ebraica. Dopo la guerra di Sei Giorni nel 1967, la questione più importante per la nuova sinistra ebraica diventò Israele, ma il movimento operava anche a favore degli ebrei sovietici e rivendicava programmi di studi ebraici nelle università (Shapiro 1992, 225). Come affermò l’attivista della SDS Jay Rosenberg, “D’ora in poi non parteciperò ad alcun movimento
78
che non accetti e sostenga la lotta del mio popolo. Se devo scegliere tra la causa ebraica e un SDS ‘progressista’ anti-israeliano, sceglierò la causa ebraica. Se saranno alzate le barricate, combatterò da ebreo” (in Sachar 1992, 808).
Gli ebrei inoltre costituivano una componente determinante nel far accettare la nuova sinistra al pubblico. Gli ebrei erano sovrarappresentati tra i radicali e i loro sostenitori nei media, nelle università e nella più ampia comunità intellettuale, come pure gli scienziati sociali ebrei di sinistra, erano determinanti a svolgere ricerche che presentassero il radicalismo studentesco in una luce positiva (Rothman & Lichter 1982, 104). Tuttavia, nella loro recente rassegna della letteratura sulla nuova sinistra, Rothman e Lichter (1996, ix, xiii) osservano una continua tendenza a tralasciare il ruolo degli ebrei nel movimento e che, laddove menzionato, il ruolo ebraico è attribuito all’idealismo ebraico o ad altre caratteristiche giudicate positive. Cuddihy (1974, 194n) fa notare che i media tralasciarono completamente la conflittualità interna ebraica verificatasi nel processo dei Chicago Seven. Egli descrive inoltre diverse valutazioni del processo, redatte da ebrei nei media (New York Times, New York Post, Village Voice), le quali scusavano il comportamento degli imputati e lodavano il loro avvocato ebreo radicale, William Kunstler.
Infine, anche in Inghilterra si è registrato un simile flusso e riflusso dell’attrazione che il comunismo esercitava sugli ebrei a seconda della sua convergenza con interessi specificamente ebraici. Durante gli anni ’30 il partito comunista era gradito agli ebrei in parte perché era l’unico movimento politico violentemente antifascista. Non sussisteva contraddizione tra l’essere iscritti al partito comunista e l’avere una forte identità etnica ebraica: “La simpatia per il comunismo tra gli ebrei di quella generazione aveva alcune delle qualità dell’identificazione di gruppo, un mezzo, forse, per l’autoaffermazione etnica” (Alderman 1992, 317-318). Nel secondo dopoguerra, quasi tutti i candidati comunisti vincitori provenivano da distretti elettorali ebraici. Ciò detto, il sostegno ebraico al comunismo subì un calo dopo le rivelazioni dell’antisemitismo di Stalin, e molti ebrei lasciarono il partito comunista dopo la crisi mediorientale del 1967 quando l’URSS tagliò le relazioni diplomatiche con Israele (Alderman 1983, 162).
Bisogna necessariamente concludere che l’identità ebraica era generalmente percepita come altamente compatibile con la politica radicale. Quando la politica radicale entrava in contrasto con interessi specificamente ebraici, gli ebrei cessavano di fare i radicali, sebbene fossero frequenti i casi di ambivalenza e razionalizzazione.
PROCESSI DI IDENTITÀ SOCIALE, PERCEPITI INTERESSI DI GRUPPO EBRAICI
E RADICALISMO EBRAICO
Una prospettiva del radicalismo ebraico pone enfasi sulla base morale del giudaismo. Questo è un altro esempio del tentativo di presentare il giudaismo come un movimento universalista,
79
moralmente superiore – il tema della “luce delle nazioni”, apparso ripetutamente come aspetto dell’autoidentità ebraica dai tempi antichi e particolarmente dall’Illuminismo (SAID, cap. 7). Da qui l’ipotesi di Fuchs (1956, 190-191), secondo cui il coinvolgimento nelle cause progressiste deriverebbe dalla singolare natura morale del giudaismo nell’inculcare la carità verso i poveri e i bisognosi. Il coinvolgimento in queste cause viene semplicemente visto come un ampliamento delle tradizionali pratiche religiose ebraiche. In modo analogo, Hertzberg (1985, 22) parla di “eco di una sensibilità morale unica, una disponibilità ad agire a discapito dell’interesse economico quando la causa sembra giusta.”
Come fatto notare in PTSDA (capp. 5,6), sembra ben probabile che il tradizionale interessamento ebraico nei confronti dei poveri e dei bisognosi fosse circoscritto ai gruppi ebraici, e infatti gli ebrei hanno spesso servito le oppressive élite dirigenti nelle società tradizionali e nell’Europa dell’Est del secondo dopoguerra.85 Ginsberg (1993, 140) descrive queste motivazioni umanistiche come “un po’ illusori,” e osserva che in altri contesti (specialmente nell’Unione Sovietica postrivoluzionaria) gli ebrei hanno organizzato “spietate agenzie di coercizione e di terrore,” incluso in modo particolare un coinvolgimento molto rilevante nella polizia segreta dal periodo postrivoluzionario fino agli anni ’30 inoltrati (si vedano anche Baron 1975, 170; Lincoln 1989; Rapoport 1990, 30-31). Similmente, si è visto che gli ebrei erano molto prominenti nelle forze di sicurezza interne in Polonia (si veda Schatz 1991, 223-228) e in Ungheria (Rothman & Lichter 1982, 89).
Pipes (1993, 112) ipotizza che sebbene sia “innegabile” che gli ebrei fossero sovrarappresentati nel partito bolscevico e nel primo governo sovietico nonché in attività comuniste rivoluzionarie in Ungheria, Germania e Austria tra il 1918 e il 1923, gli ebrei erano sovrarappresentati anche in diversi altri campi, compresi il commercio, l’arte, la letteratura e le scienze. Di conseguenza, Pipes sostiene che la loro sproporzionata rappresentanza nei movimenti politici comunisti non dovrebbe costituire un problema. Pipes accosta questo argomento all’asserzione che i bolscevichi ebrei non si identificavano come ebrei – un ragionamento a dir poco discutibile, come si è visto.
Tuttavia, pur presupponendo che questi comunisti etnicamente ebrei non si identificassero come ebrei, un tale ragionamento non spiega perché questi ebrei “de-etnicizzati” (nonché imprenditori, artisti, scrittori e scienziati ebrei) fossero sovrarappresentati nei movimenti di sinistra e sottorappresentati nei movimenti politici nazionalisti, populisti o di altro genere di destra.86 Anche se i movimenti nazionalisti sono antisemitici, come è spesso il caso, l’antisemitismo dovrebbe essere irrilevante se questi individui fossero davvero completamente de-etnicizzati come afferma Pipes. La prominenza ebraica in professioni che richiedono una spiccata intelligenza non offre nessuna chiave per comprendere il loro ruolo di rilievo nei movimenti comunisti e in altri movimenti di sinistra e la loro relativa sottorappresentazione nei movimenti nazionalisti.
80
La teoria dell’identità sociale offre tutta un’altra prospettiva sul radicalismo ebraico. Essa pone enfasi sul fatto che i percepiti interessi di gruppo ebraici sono fondamentali per il comportamento politico ebraico, e che questi percepiti interessi di gruppo sono condizionati in modo significativo da processi di identità sociale. Se la politica radicale crea davvero un forte senso di identificazione con un ingroup ebraico, allora il coinvolgimento ebraico in questi movimenti sarebbe associato a concezioni molto negative ed esagerate della più ampia società gentile, e particolarmente degli elementi più potenti di quella società, in quanto outgroup. Conformemente a questa aspettativa, Liebman (1979, 26) usa il termine “controcultura” per descrivere la sinistra americana ebraica perché “il conflitto o l’antagonismo verso la società è una caratteristica fondamentale di questa subcultura e … molti dei suoi valori e schemi culturali sono una contraddizione di quelli esistenti nella società circostante.” Per esempio, la nuova sinistra era coinvolta in modo determinante nella critica sociale radicale, nell’ambito della quale tutti gli elementi che contribuivano al coeso tessuto sociale dell’America di metà secolo erano considerati oppressivi e da alterare radicalmente.
Qui l’enfasi sui processi di identità sociale è compatibile con il radicalismo ebraico al servizio di determinati interessi di gruppo ebraici. L’antisemitismo e gli interessi economici ebraici erano indubbiamente importanti fattori motivanti per l’attivismo ebraico di sinistra nella Russia zarista. I leader ebrei nelle società occidentali, molti dei quali erano capitalisti benestanti, riconoscevano con orgoglio la sovrarappresentanza ebraica nel movimento rivoluzionario russo; fornivano inoltre sostegno finanziario e politico per questi movimenti, cercando per esempio di condizionare la politica estera statunitense (Szajkowski 1967). Rappresentativa di questo atteggiamento è la dichiarazione del finanziere Jacob Schiff: “l’accusa che tra coloro che cercano di sovvertire l’autorità del governo in Russia ci sia un numero considerevole di ebrei sarà forse fondata. Infatti, ci sarebbe da stupirsi se alcuni di coloro afflitti così atrocemente dalla persecuzione e dalle leggi straordinarie non si fossero alla fine rivoltati contro i loro impietosi oppressori” (in Szajkowski 1967, 10).
Infatti, a rischio di essere eccessivamente riduttivi, si potrebbe notare che l’antisemitismo in combinazione con l’esplosione demografica ebraica nell’Europa dell’Est erano di cruciale importanza nel generare lo straordinario numero di radicali ebrei disincantati e, perciò, la successiva influenza del radicalismo ebraico in Europa e il suo espandersi fino agli Stati Uniti. Durante il XIX secolo, il tasso di crescita naturale delle popolazioni ebraiche nell’Europa dell’Est era il più alto di tutte le altre popolazioni in Europa, con una crescita naturale di 120 000 all’anno intorno al 1880 e una crescita complessiva all’interno dell’impero russo da uno a sei milioni nel corso del XIX secolo (Alderman 1992, 112; Frankel 1981, 103; Lindemann 1991, 28-29, 133-135). Malgrado l’emigrazione di circa 2 milioni di ebrei negli Stati Uniti e altrove, molti ebrei dell’Europa dell’Est risultavano impoveriti almeno in parte a causa delle politiche zariste antiebraiche che ostacolavano l’ascesa sociale degli ebrei.
81
Di conseguenza, un numero non indifferente di ebrei era attratto da soluzioni politiche radicali che potessero trasformare le basi economiche e politiche della società e che fossero consistenti con la continuità del giudaismo. All’interno delle comunità ebraiche russe, l’accettazione di ideologie politiche radicali coesisteva spesso con forme messianiche del sionismo nonché con un forte impegno verso il nazionalismo ebraico e il separatismo religioso e culturale, e molti individui nutrivano svariate combinazioni di queste idee, combinazioni spesso in rapido cambiamento (si veda Frankel 1981).
Il fanatismo religioso e le aspettative messianiche sono stati una tipica reazione ebraica alle persecuzioni antisemitiche nel corso della storia (p. es. Scholem 1971; PTSDA, cap. 3). Infatti, è legittimo immaginare che le forme messianiche del radicalismo politico siano forme laiche di questa reazione ebraica alla persecuzione, differenti dalle forme tradizionali solo per il fatto che promettono un futuro utopistico anche ai gentili. Il quadro generale rievoca la situazione nel tardo Impero Ottomano, dove dalla metà del XVIII secolo fino all’intervento delle potenze europee nel XX secolo prevaleva “un quadro inequivocabile di povertà opprimente, ignoranza e insicurezza” (Lewis 1984, 164) nel contesto di alti livelli di antisemitismo che impedivano l’ascesa sociale degli ebrei. Questi fenomeni erano accompagnati dalla prevalenza di misticismo e da uno stile genitoriale orientato all’alta fertilità e al basso investimento tra gli ebrei. Alla fine, la comunità diventava troppo povera per provvedere all’istruzione della maggior parte dei figli, con la conseguenza che la maggioranza era analfabeta e sceglieva lavori che richiedevano una limitata intelligenza e formazione.
Tuttavia, quando si offrirono loro opportunità di ascesa sociale, la strategia riproduttiva si trasformò rapidamente in una strategia orientata alla bassa fertilità e all’alto investimento. Nella Germania del XIX secolo, per esempio, gli ebrei furono il primo gruppo a imbarcarsi nella transizione demografica e fare meno figli per avvalersi delle opportunità di mobilità sociale ascendente (p. es. Goldstein 1981; Knode 1974). Allo stesso tempo, gli ebrei poveri dell’Europa dell’Est, senza alcuna speranza di ascesa sociale, si sposavano prima dei loro pari nell’Europa occidentale, i quali rinviavano il matrimonio per essere meglio preparati finanziariamente (Efron 1994, 77). E la rinascita degli ebrei ottomani nel XIX secolo, scaturente dalla protezione e dal patrocinio degli ebrei dell’Europa occidentale, portò con sé il fiorire di una cultura molto letterata, incluse scuole laiche basate su modelli occidentali (si veda Shaw 1991, 143 segg., 175-176). Analogamente, quando gli ebrei oppressi dell’Europa dell’Est emigrarono negli Stati Uniti, svilupparono una cultura orientata all’alto investimento e alla bassa fertilità al fine di approfittare delle opportunità di mobilità ascendente. La tesi è che l’orientamento generale della risposta ebraica di fronte alla mancanza di opportunità di mobilità ascendente e all’antisemitismo sia quello di adottare, facoltativamente, uno stile di riproduzione a basso investimento e ad alta fertilità unito – sul piano ideologico – a diverse forme di messianismo, inclusa, nell’epoca moderna, l’ideologia politica radicale.
82
Alla fine, questa esplosione demografica in un contesto di povertà e restrizioni imposte a livello politico agli ebrei fu responsabile degli effetti generalmente destabilizzanti del radicalismo ebraico sulla Russia fino alla rivoluzione. Queste condizioni ebbero anche ripercussioni in Germania, dove gli atteggiamenti negativi verso gli immigrati Ostjuden contribuivano all’antisemitismo dell’epoca (Aschheim 1982). Negli Stati Uniti, il nocciolo di questo capitolo è che le idee politiche radicali di un gran numero di immigrati ebrei e dei loro discendenti erano caratterizzate da un alto grado di inerzia, nel senso che le idee politiche radicali perduravano anche nell’assenza di condizioni economiche e politiche oppressive. Nello studio di Sorin (1985, 46) sugli attivisti radicali ebrei immigrati in America, più della metà era stata coinvolta nella politica radicale in Europa prima di emigrare, e per coloro che immigrarono dopo il 1900, la percentuale saliva al 69 percento. Glazer (1961, 21) fa notare che dalle biografie di quasi tutti i leader radicali risulta che vennero a contatto con le idee politiche radicali per la prima volta in Europa. La persistenza di queste idee influenzò la generale sensibilità politica della comunità ebraica ed ebbe un effetto destabilizzante sulla società americana, che va dalla paranoia dell’era di McCarthy al trionfo della rivoluzione controculturale degli anni ’60.
L’immigrazione degli ebrei dell’Europa dell’Est in Inghilterra dopo il 1880 ebbe un effetto analogamente trasformativo sugli atteggiamenti politici della comunità ebraica britannica nella direzione del socialismo, del sindacalismo e del sionismo, spesso uniti all’ortodossia religiosa e alla devozione verso uno stile di vita fortemente separatista (Alderman 1983, 47 segg.). “Ben più significativa dei pochi socialisti ebrei in cerca di pubblicità che, sia in Russia che in Inghilterra, organizzavano picnic di tramezzini al prosciutto durante il digiuno di Yom Kippur, il Giorno della Redenzione, era la massa di ebrei della classe operaia che non sentiva alcun conflitto interno quando andava in sinagoga tre volte al giorno per le funzioni religiose e poi usava la stessa sede per discutere principi socialisti e organizzare scioperi industriali” (Alderman 1983, 54).87 Come negli Stati Uniti, gli ebrei immigrati dall’Europa dell’Est subissarono demograficamente la comunità ebraica preesistente, e la vecchia comunità reagì con trepidazione a questo influsso a causa del possibile aumento dell’antisemitismo. E come negli Stati Uniti, ci furono tentativi da parte della comunità ebraica radicata di falsare la prevalenza delle idee politiche radicali tra gli immigrati (Alderman 1983, 60; SAID, cap. 8).
Ciononostante, gli interessi economici non costituiscono tutta la storia. Mentre l’origine del diffuso radicalismo politico tra gli ebrei può essere caratterizzato come una tipica reazione ebraica alle avversità politiche ed economiche dell’Europa dell’Est del tardo Ottocento, l’ideologia politica radicale si dissociò dalle solite variabili demografiche poco dopo l’arrivo negli Stati Uniti, ed è questo fenomeno che richiede un altro tipo di spiegazione. Per lo più, gli ebrei americani avevano motivi meno sostanziali rispetto ad altri gruppi etnici di desiderare
83
il rovesciamento del capitalismo dal momento che tendevano a essere relativamente privilegiati in termini economici. Da alcuni sondaggi degli anni ’60 e ’70 emerge che gli ebrei della classe media erano più radicali di quelli della classe operaia – una tendenza contraria rispetto agli studenti radicali non ebrei (Rothman & Lichter 1982, 117, 219;88 Levey 1996, 37589). Sebbene gli ebrei tendessero a votare in misura preponderante per i democratici (Liebman 1973, 136-137), rispetto agli appartenenti ad altre religioni erano meno propensi a credere che votare per un candidato democratico potesse favorire i loro interessi economici.
La divergenza tra interessi economici e ideologia politica risale almeno agli anni ’20 (Liebman 1979, 290 segg.). Infatti, durante l’intero periodo dal 1921 al 1961, era più probabile che i membri ebrei del comitato centrale del CPUSA provenissero dalla classe media professionale e fossero più istruiti dei loro colleghi gentili (Klehr 1978, 42 segg.). Era anche molto più probabile che vi si fossero iscritti prima delle difficoltà economiche della Grande depressione. Inoltre, come indicato sopra, gli studenti radicali della nuova sinistra provenivano in modo sproporzionato da famiglie benestanti e altamente istruite (si veda anche Liebman 1973, 210).
Perfino i capitalisti ebrei affermati tendevano ad abbracciare opinioni politiche a sinistra rispetto ai loro omologhi gentili. Per esempio, i capitalisti ebreo-tedeschi del XIX secolo “tendevano ad adottare posizioni nettamente ‘a sinistra’ rispetto ai loro omologhi gentili e pertanto a isolarsi da essi” (Mosse 1989, 225). Sebbene come gruppo tendessero a porsi in una posizione a destra rispetto alla popolazione ebraica nel complesso, alcuni erano sostenitori del Partito socialdemocratico e del suo programma socialista. Tra le ragioni plausibili suggerite da Mosse per questo stato delle cose vi è il fatto che l’antisemitismo tendeva a essere associato alla destra tedesca. In linea con la teoria dell’identità sociale, i capitalisti ebrei non si identificavano con i gruppi che li percepivano negativamente e si identificavano invece con i gruppi in opposizione a un outgroup considerato ostile. In questo caso sembrano essere di primaria importanza i processi di identità sociale e la loro influenza sulla percezione degli interessi etnici (di gruppo) piuttosto che l’autointeresse economico.
Il legame tra ebrei e atteggiamenti politici progressisti è pertanto indipendente dalle solite associazioni demografiche. In un passo che dimostra che l’estraniamento culturale ed etnico ebraico prevale sugli interessi economici nella spiegazione del comportamento politico ebraico, Silberman (1985, 347-348) commenta [riflette] sull’attrazione degli ebrei verso “il Partito democratico… con la sua tradizionale ospitalità verso gruppi etnici non WASP…. Un celebre economista che era fortemente in disaccordo con le politiche economiche di Mondale [Walter Mondale, candidato alle presidenziali] votò per lui malgrado tutto. ‘Ho seguito le convention in televisione,’ egli spiegò, ‘e i repubblicani non sembravano il tipo di gente che piace a me.’ La stessa reazione portò molti ebrei a votare per Carter nel 1980 nonostante la loro antipatia per lui; ‘Preferirei vivere in un paese governato dalle facce che ho visto alla convention democratica
84
piuttosto che da quelle che ho visto alla convention repubblicana,’ mi confidò un noto scrittore.”
Si suppone che, in generale, la motivazione politica ebraica sia condizionata da questioni non economiche legate a percepiti interessi di gruppo ebraici, a loro volta influenzati dai processi di identità sociale. Similmente, nel campo molto politicizzato degli atteggiamenti culturali, Silberman (1985, 350) fa notare che “gli ebrei americani hanno a cuore la tolleranza culturale per via della loro idea – saldamente radicata nella storia – che gli ebrei sono al sicuro solo in una società che accetti un’ampia varietà di atteggiamenti e comportamenti, nonché una diversità di gruppi religiosi ed etnici. È questa credenza, per esempio, e non l’accettazione dell’omosessualità, a indurre la stragrande maggioranza degli ebrei americani a sostenere i ‘diritti gay’ e ad adottare una posizione progressista sulla maggior parte delle questioni cosiddette ‘sociali.’” Un percepito interesse di gruppo ebraico per il pluralismo culturale prevale sugli atteggiamenti personali negativi verso il comportamento in questione.
Il commento di Silberman secondo cui gli atteggiamenti ebraici sono “saldamente radicati nella storia” è particolarmente significativo: una costante tendenza per gli ebrei è quella di essere perseguitati come gruppo minoritario all’interno di una società culturalmente o etnicamente omogenea. La motivazione molto logica degli ebrei americani a favore del pluralismo politico, religioso e culturale sarà sottolineata nel capitolo 7, che tratta del coinvolgimento ebraico nella formazione della politica di immigrazione statunitense. Il punto qui è che il percepito interesse di gruppo ebraico nel creare una società pluralistica è di gran lunga più importante del semplice autointeresse economico nel determinare il comportamento politico ebraico. Allo stesso modo, Earl Raab (1996, 44) spiega il comportamento politico ebraico in termini di questioni di sicurezza, legate in parte al ricordare il Partito repubblicano come associato al fondamentalismo cristiano e con una storia “risolutamente nativista e anti-immigrati.” Questa tendenza ad appoggiare il Partito democratico costituisce perciò un aspetto del conflitto etnico tra ebrei e altri settori della popolazione caucasica di origine europea negli Stati Uniti, e non una questione economica. In realtà, le questioni economiche sembrano del tutto irrilevanti, dal momento che il sostegno per il Partito democratico da parte degli ebrei non cambia in base allo status sociale (Raab 1996, 45).
Ciononostante, è stato riscontrato che il recente comportamento elettorale ebraico distingue sempre più nettamente il tradizionale progressivismo economico da questioni legate al pluralismo culturale, all’immigrazione e alla separazione tra Stato e Chiesa. Recenti sondaggi e dati sulle abitudini elettorali ebraiche indicano che gli ebrei continuano a vedere nell’ala destra del Partito repubblicano “una minaccia al cosmopolitismo americano” in quanto percepita come fautrice di una cultura omogenea cristiana e contraria all’immigrazione (Beinart 1997, 25). Tuttavia, gli elettori ebrei erano più favorevoli alle politiche fiscali conservatrici e meno favorevoli ai tentativi statali di ridistribuzione della ricchezza rispetto sia agli afro-americani sia agli altri americani bianchi. Il recente comportamento politico ebraico è pertanto auto-interessato sia in termini economici che nella sua opposizione
85
agli interessi degli americani bianchi tesi a creare una società etnicamente e culturalmente omogenea.
Oltre al perseguimento di specifici interessi di gruppo, tuttavia, i processi di identità sociale sembrano apportare un contributo indipendente ai fini della comprensione del comportamento politico ebraico. I processi di identità sociale sembrano necessari per spiegare perché il movimento operaio ebraico fosse molto più radicale del resto del movimento operaio americano. In un passo che rivela il profondo senso di identità ebraica e di separatismo dei radicali ebrei nonché l’assoluta antipatia nei confronti dell’intero ordine sociale gentile, Levin (1977, 213) fa notare che “le loro idee socialiste… aprirono un divario tra loro e altri lavorati americani disinteressati a cambiamenti radicali nell’ordine sociale. Sebbene alcuni sindacati ebraici si iscrissero all’AFL [Federazione americana del lavoro: N.d.T.], non fu mai congeniale per loro dato che l’AFL non desiderava una trasformazione radicale della società, né aveva una visione internazionalista.” Abbiamo inoltre notato che, non appena raggiunti sostanzialmente i propri obiettivi sociali con il successo del movimento sindacale, la nuova sinistra abbandonò completamente gli obiettivi e gli interessi della piccola borghesia.
Ancora una volta ci sono forti indicazioni che le critiche sociali e i sentimenti di estraniamento culturale tra gli ebrei abbiano profonde radici psicologiche che vanno al di là di particolari interessi economici o politici. Come indicato nel capitolo 1, un’importante componente psicologica sembra essere legata a un’antipatia molto profonda nei confronti dell’ordine sociale dominato dai gentili, il quale viene considerato antisemitico – il desiderio di “maligna vendetta” che, a detta di Disraeli, rendeva molti ebrei “pieni di odio e così ostili nei confronti dell’umanità.” Si ricordi la descrizione di Lipset (1988, 393) delle molte famiglie ebraiche “che, intorno al tavolo della prima colazione, giorno dopo giorno, a Scarsdale, Newton, Great Neck e Beverly Hills, discutevano di quanto orribile, corrotta, immorale, poco democratica e razzista fosse la società americana.” Queste famiglie chiaramente si considerano separate dalla più ampia cultura statunitense; inoltre vedono le forze conservatrici come tese a preservare questa cultura maligna. Come nel caso del giudaismo tradizionale nei confronti della società gentile, la cultura tradizionale degli Stati Uniti – e in particolare la base politica del conservatorismo culturale che è stata storicamente associata all’antisemitismo – è percepita come manifestazione di un outgroup valutato in termini negativi.
Questa antipatia verso la società dominata dai gentili era spesso accompagnata da un forte desiderio di vendicare i mali del vecchio ordine sociale. Per molti ebrei della nuova sinistra “la rivoluzione promette di vendicare le sofferenze e di riparare i torti inflitti agli ebrei per così tanto tempo con il permesso o l’incoraggiamento, o perfino per ordine delle autorità nella società prerivoluzionarie” (Cohen 1980, 208). Dalle interviste ad alcuni radicali ebrei della nuova sinistra emerge che molti covavano fantasie distruttive in cui la rivoluzione avrebbe portato a “l’umiliazione, l’esproprio, l’incarcerazione o l’esecuzione degli oppressori” (Cohen 1980, 208) insieme alla fede nella loro onnipotenza e nella loro
86
capacità di creare un ordine sociale non oppressivo – risultati che ricordano il ruolo motivante di vendetta per l’antisemitismo tra le forze di sicurezza di dominazione ebraica nella Polonia comunista di cui si è trattato sopra. Questi riscontri sono inoltre pienamente compatibili con la mia esperienza tra gli attivisti ebrei della nuova sinistra alla University of Wisconsin negli anni ’60 (si veda la nota 13).
Secondo la prospettiva dell’identità sociale, le attribuzioni negative generalizzate nei confronti dell’outgroup sarebbero accompagnate da attribuzioni positive nei confronti dell’ingroup ebraico. Sia i comunisti ebrei in Polonia sia i radicali ebrei della nuova sinistra nutrivano un forte sentimento di superiorità culturale, conforme alle tradizionali convinzioni ebraiche della superiorità del proprio ingroup (Cohen 1980, 212; Schatz 1991, 119). Le auto-concettualizzazioni degli ebrei in merito ai propri sforzi per creare una cultura antagonista negli Stati Uniti tendevano a porre l’accento sull’ebreo come perenne vittima dell’antisemitismo gentile, o sull’ebreo come eroe morale, ma “in entrambi i casi la rappresentazione è l’opposto di quella dell’antisemita. Gli ebrei non hanno difetti. Le loro motivazioni sono pure, il loro idealismo è sincero” (Rothman & Lichter 1982, 112). Gli studi su radicali ebrei condotti da scienziati sociali ebrei tendevano ad attribuire arbitrariamente il radicalismo ebraico a una “libera scelta di una minoranza dotata” (Rothman & Lichter 1982, 118) laddove le spiegazioni economiche risultavano inadeguate – un ulteriore esempio in cui lo status di gruppo ebraico sembra condizionare le ricerche di scienza sociale in modo tale da servire gli interessi di gruppo ebraici.
In aggiunta, un’ideologia utopica universalista quale il marxismo rappresenta un veicolo ideale per i tentativi degli ebrei di sviluppare un’identità positiva di sé come marxisti pur conservando la loro identità di sé come ebrei e la loro valutazione negativa delle strutture di potere gentili. Innanzitutto, la natura utopica dell’ideologia radicale contrapposta agli esistenti sistemi sociali dominati dai gentili (inevitabilmente lontani dalla perfezione) facilita lo sviluppo di un’identità positiva dell’ingroup. L’ideologia radicale facilita pertanto un’identità di gruppo positiva e un senso di rettitudine morale per via della sua promozione di principi etici universalisti. Gli psicologi hanno riscontrato che un senso di rettitudine morale è un importante elemento dell’autostima (p. es. Harter 1983), e si ipotizza che l’autostima sia un fattore motivante nei processi di identità sociale (SAID, cap.1).
Come valeva anche per la psicoanalisi, i movimenti politici di sinistra assumevano toni messianici e redentori che contribuivano all’orgoglio e alla lealtà dell’ingroup. I membri del Bund ebraico russo e la loro progenie negli Stati Uniti avevano un intenso orgoglio personale e una forte convinzione di far “parte di un’avanguardia morale e politica mirata al grande cambiamento storico. Avevano una missione che ispirava loro e chi credeva in loro” (Liebman 1979, 133).
Questo senso di orgoglio ingroup e fervore messianico è indubbiamente un elemento cruciale del giudaismo in tutte le epoche storiche. Come fa notare Schatz (1991, 105) nella sua descrizione dei rivoluzionari ebrei clandestini nella Polonia interbellica, “Il movimento faceva… parte di una lotta mondiale,
87
internazionale per nient’altro che la fondamentale trasformazione delle basi stesse della società umana. L’effetto congiunto di questa situazione era un senso particolare di solitudine rivoluzionaria e di missione, un’intensa coesione, un senso di fratellanza, e una disponibilità a sacrificarsi sull’altare della lotta.” Ciò che distingueva i comunisti ebrei dagli altri comunisti era non solo il loro desiderio di un mondo postrivoluzionario senza antisemitismo, ma anche la loro “singolare intensità [emotiva] radicata in aspirazioni messianiche” (Schatz 1991, 140). Come disse uno degli interpellati, “Io credevo in Stalin e nel partito come mio padre credeva nel Messia” (in Schatz 1991, 140).
Rispecchiando la struttura sociale ebraica tradizionale, questi gruppi ebraici radicali erano gerarchici e fortemente autoritari, e svilupparono il proprio linguaggio privato (Schatz 1991, 109-112). Così come nel giudaismo tradizionale, la continua formazione e autodidattica erano viste come elementi importanti del movimento: “Studiare era un punto di onore e un obbligo” (p. 117). Le discussioni replicavano i tradizionali metodi di studio della Torah: la memorizzazione di lunghi passi di testo unita all’analisi e all’interpretazione svolte in un ambiente di intensa concorrenza intellettuale alquanto simile al tradizionale pilpul. A detta di un novizio di queste discussioni, “Ci comportavamo da yeshiva bukhers [studenti] e loro [le guide intellettuali più esperte] da rabbini” (p. 139).
Come previsto dalla teoria dell’identità sociale, c’era anche un alto livello di valutazione ingroup-outgroup, caratterizzata da uno spiccato senso di rettitudine morale all’interno dell’ingroup unito a un’implacabile ostilità e a un rifiuto nei confronti dell’outgroup. Nel secondo dopoguerra, per esempio, i comunisti ebreo-polacchi vedevano il nuovo piano economico “in termini propriamente mistici. [Era] un programma infallibile, concepito scientificamente, che avrebbe totalmente ristrutturato i rapporti della società e preparato il Paese al socialismo” (Schatz 1991, 249). Le difficoltà economiche che colpirono la popolazione non fecero altro che rinviare le loro speranze al futuro, e al tempo stesso la popolazione sviluppò “un atteggiamento intransigente verso quanti erano restii a sopportare gli stenti del presente e un’implacabile ostilità verso coloro che venivano percepiti come nemici. L’ardente volontà di creare un’armonia e una felicità generale era pertanto accompagnata dalla sfiducia e dalla diffidenza verso i suoi obiettivi e da un odio nei confronti dei suoi oppositori – reali, potenziali o immaginati che fossero” (p. 250).
Evidentemente, essere rivoluzionari comunisti implicava una forte lealtà verso un gruppo coeso e autoritario che stimava i successi intellettuali e mostrava un’intensa antipatia verso i nemici e gli outgroup, esibendo allo stesso tempo sentimenti molto positivi verso un ingroup ritenuto moralmente e intellettualmente superiore. Questi gruppi operavano come delle minoranze assediate che vedevano la società circostante come ostile e minacciosa. Essere membri di un tale gruppo richiedeva un enorme sacrificio personale e perfino dell’altruismo.
88
Tutti questi attributi sono riscontrabili come caratteristiche distintive dei gruppi ebraici più tradizionali.
Ulteriori prove dell’importanza dei processi di identità sociale si riscontrano nell’ipotesi di Charles Liebman (1973, 153 segg.), il quale sostiene che l’ideologia universalista di sinistra permette agli ebrei di sovvertire le tradizionali categorizzazioni sociali in cui essi sono percepiti in termini negativi. L’adozione di tali ideologie da parte degli ebrei rappresenta un tentativo di superare sentimenti ebraici di alienazione “dalle radici e dalle tradizioni della società [gentile]” (p. 153). “L’ebreo continua la sua ricerca di un’etica o di un ethos non solo universale o capace di universalità, ma che serva da avanguardia contro le tradizioni più antiche della società, una ricerca la cui intensità è aumentata e rafforzata dal trattamento dell’ebreo da parte del gentile” (Liebman 1973, 157). Tali tentativi di sovvertire le categorizzazioni sociali negative imposte da un outgroup costituiscono un aspetto fondamentale della teoria dell’identità sociale (Hogg & Abrams 1988; si veda SAID, cap. 1).
L’ideologia universalista funziona pertanto come una forma laica del giudaismo. Le forme settarie del giudaismo vengono scartate come “una strategia di sopravvivenza” (Liebman 1973, 157) a causa della loro tendenza a generare l’antisemitismo, della mancanza di attrattiva intellettuale nel mondo postilluministico e dell’inabilità di attrarre i gentili e pertanto di trasformare il mondo sociale gentile in modo tale da promuovere gli interessi di gruppo ebraici. In effetti, mentre l’ideologia universalista è formalmente congruente con gli ideali dell’illuminismo, il mantenimento del tradizionale separatismo ebraico e i modelli associativi tra i fautori dell’ideologia indicano un elemento di inganno o di autoinganno:
Gli ebrei preferiscono unirsi ad altri ebrei per promuovere iniziative apparentemente non ebraiche (che contribuiscono a far sì che gli ebrei siano accettati), per poi far finta che l’intera questione non abbia nulla a che vedere con l’essere ebrei. Ma questo tipo di attività è più prevalente tra gli ebrei maggiormente estraniati dalle proprie tradizioni e pertanto più ansiosi di trovare un valore che sostenga l’accettazione degli ebrei senza distruggere apertamente i vincoli di gruppo ebraici (Liebman 1973, 159)
L’ideologia universalista pertanto permette agli ebrei di evitare l’alienazione o l’estraniamento dalla società gentile lasciando però che si mantenga una forte identità ebraica. Le istituzioni che promuovono i legami tra i gentili (quali il nazionalismo e le tradizionali associazioni religiose gentili) vengono contestate e sovvertite, mentre viene mantenuta l’integrità strutturale del separatismo ebraico. Un filo costante della teorizzazione radicale da Marx in poi è stato il timore che il nazionalismo avrebbe potuto servire da collante sociale dando luogo a un compromesso tra le classi sociali e a un ordine sociale molto unificato, basato
89
su rapporti gerarchici ma armoniosi tra le esistenti classi sociali. Questa è l’unica forma di organizzazione sociale gentile ad alta coesione in netta contraddizione con il giudaismo in quanto strategia evolutiva di gruppo (si vedano i capp. 5, 7, 8). Sia la vecchia che la nuova sinistra, come si è notato, cercavano attivamente di sovvertire la coesione della struttura sociale gentile, incluso, in modo particolare, il modus vivendi raggiunto tra impresa e lavoro negli anni ’60. E si è già notato che il governo comunista polacco dominato dagli ebrei contrastava attivamente il nazionalismo polacco, nonché il potere politico e culturale della chiesa cattolica, la più importante forza di coesione sociale nella società polacca tradizionale.
Infine, come sottolineato da Rothman and Lichter (1982, 119), il marxismo è particolarmente allettante come base di un’ideologia mirata a sovvertire le categorizzazioni sociali dell’outgroup gentile, perché all’interno di una tale ideologia la categorizzazione ebreo-gentile diventa meno rilevante, mentre la coesione di gruppo e il separatismo ebraici permangono comunque: “Attraverso l’adozione di varianti dell’ideologia marxista, gli ebrei negano la realtà delle differenze culturali o religiose tra ebrei e cristiani. Queste differenze diventano ‘epifenomeniche’ rispetto alla più fondamentale opposizione tra lavoratori e capitalisti. Ne consegue che ebrei e non ebrei, in fondo, sarebbero effettivamente fratelli. Anche quando non adottavano una posizione marxista, molti ebrei prediligevano posizioni ambientali radicali che avevano uno scopo simile” (p. 119).90
Un tale strategia ha perfettamente senso dal punto di vista della teoria dell’identità sociale: nelle ricerche sul contatto intergruppo, un dato ricorrente è che rendere meno salienti le categorie sociali che definiscono i gruppi ridurrebbe la differenziazione intergruppo e faciliterebbe le interazioni sociali positive tra i membri di gruppi diversi (Brewer & Miller 1984; Doise & Sinclair 1973; Miller, Brewer & Edwards 1985). Al limite, l’accettazione di un’ideologia universalista da parte dei gentili li porterebbe a non percepire affatto gli ebrei come appartenenti a un’altra categoria sociale, mentre gli ebrei potrebbero comunque mantenere una forte identità personale.
Nell’insieme, queste caratteristiche del radicalismo ebraico costituiscono un’analisi molto convincente del ruolo dei processi di identità sociali in questo fenomeno. Quest’ultimo meccanismo è di particolare interesse come analisi sia della tendenza alla sovrarappresentanza politica ebraica nelle cause radicali sia della tendenza ebraica ad adottare ideologie ambientali radicali, una caratteristica comune degli scienziati sociali ebrei segnalata nel capitolo 2. L’analisi sottintende che gli ebrei coinvolti in questi movimenti intellettuali ricorrano a un subdolo processo di inganno dei gentili (e, possibilmente, all’autoinganno), e che i movimenti funzionino essenzialmente come forma di criptogiudaismo.
Nel linguaggio della teoria dell’identità sociale, si crea un’ideologia nella quale l’importanza della categorizzazione sociale di ebreo-gentile viene sminuita e
90
non sussistono connotazioni negative circa l’appartenenza al gruppo ebraico. L’importanza dell’appartenenza al gruppo etnico viene minimizzata come categoria sociale e, data la sua scarsa importanza, l’autointeresse etnico tra gentili viene giudicato come fondamentalmente fuorviato poiché non riconosce la preminenza del conflitto di classe tra gentili. Gli ebrei possono restare ebrei perché essere ebreo non ha più importanza. Nel contempo, le tradizionali istituzioni di coesione sociale all’interno della società gentile vengono sovvertite e la stessa società gentile è vista come permeata da conflitti di interesse tra le classi sociali piuttosto che caratterizzata da affinità di interessi e sentimenti di solidarietà sociale tra le diversi classi sociali. Rothman e Lichter (p. 119 segg.) avvalorano la loro tesi facendo notare che l’adozione di ideologie universaliste è una tecnica comune tra gruppi minoritari in tutto il mondo. Nonostante l’apparenza di universalismo, questi movimenti non sono assolutamente assimilazionisti, e infatti Rothman e Lichter vedono l’assimilazione, definita come totale assorbimento e perdita di identità di gruppo minoritario, come un’alternativa all’adozione di movimenti politici universalisti. È possibile che le ideologie universaliste siano cortine di fumo che in realtà facilitano l’ininterrotta esistenza di strategie di gruppo, promuovendo al tempo stesso la negazione della loro importanza sia da parte degli outgroup che degli ingroup. Il giudaismo come strategia di gruppo coeso e a base etnica riesce a sopravvivere, ma in forma criptica o semicriptica.
A corroborazione di questa prospettiva, Levin (1977, 105) afferma che “L’analisi di Marx [del giudaismo come casta] offriva ai pensatori socialisti una facile scappatoia – per ignorare o minimizzare il problema ebraico.” In Polonia, il partito comunista dominato dagli ebrei deplorò la partecipazione di operai e contadini ai pogrom negli anni ’30 perché questi individui non agivano in base ai propri interessi di classe (Schatz 1991, 99), un’interpretazione secondo cui i conflitti etnici sarebbero causati dal capitalismo e sarebbero scomparsi dopo la rivoluzione comunista. Una delle ragioni del limitato antisemitismo esistente all’interno del movimento socialdemocratico nella Germania del tardo XIX secolo è che tutti i fenomeni sociali potevano essere spiegati dalla teoria marxista; i socialdemocratici “non avevano bisogno dell’antisemitismo, altra teoria onnicomprensiva, per spiegare gli avvenimenti della loro vita” (Dawidowicz 1975, 42). I socialdemocratici (e Marx) non analizzavano mai il giudaismo come nazione o come gruppo etnico ma piuttosto come comunità religiosa ed economica (Pulzer 1964, 269).
Pertanto, in teoria, l’antisemitismo e altri conflitti etnici sarebbero scomparsi con l’avvento della società socialista. È possibile che in alcuni casi una tale interpretazione sia effettivamente servita a ridurre l’antisemitismo. Levy (1975, 190) suggerisce che, tra l’elettorato operaio gentile dei socialdemocratici tedeschi, l’antisemitismo era minimizzato dalle attività dei leader del partito e dagli strateghi socialisti, i quali inquadravano i problemi politici ed economici di questo gruppo in termini di conflitto di classe piuttosto che di conflitto ebreo-gentile e si opponevano attivamente a qualsiasi collaborazione con i partiti antisemitici.
91
Trotsky e altri ebrei del Partito socialdemocratico operaio russo si ritenevano rappresentanti del proletariato ebraico nell’ambito del più ampio movimento socialista (si veda nota 4), ma erano contrari al programma separatista e nazionalista del Bund ebraico russo. Arthur Liebman (1979, 122-123) sostiene che questi socialisti assimilazionisti concettualizzavano coscientemente una società postrivoluzionaria in cui il giudaismo esisterebbe, ma con una ridotta rilevanza sociale: “Per loro, la soluzione definitiva del problema ebraico sarebbe una società socialista internazionalista che non prestasse attenzione alle distinzioni tra ebrei e non ebrei. Per affrettare la creazione di una tale società, si rendeva necessario, secondo questi socialisti assimilazionisti, che gli ebrei considerassero irrilevanti le distinzioni tra loro e i non ebrei.”
Analogamente, dopo la rivoluzione, “Avendo abbandonato le proprie origini e identità, eppure senza trovare, o condividere, o essere pienamente ammessi a partecipare alla vita russa (fatta eccezione per il mondo del partito), i bolscevichi ebrei trovarono la loro casa ideologica nell’universalismo rivoluzionario. Sognavano una società senza stato e classi, sostenuta dalla fede e dottrina marxiste, che trascendesse le particolarità e i fardelli dell’esistenza ebraica” (Levin 1988, 49). Questi individui, insieme a molti ex-bundisti fortemente nazionalisti, finirono per amministrare programmi legati alla vita ebraica nazionale nell’Unione Sovietica. A quanto pare, sebbene respingessero il separatismo radicale ebraico sia dei bundisti che dei sionisti, si aspettavano la continuità della vita nazionale ebraica laica nell’Unione Sovietica (p. es. Levin 1988, 52).
Questa credenza nell’invisibilità del giudaismo in una società socialista si riscontra anche tra i radicali ebrei americani. I socialisti ebrei americani degli anni 1890, per esempio, immaginavano una società in cui la razza non avrebbe avuto alcun ruolo (Rogoff 1930, 115), uno scenario, a quanto pare, in cui gli ebrei e i non ebrei sarebbero rimasti nelle rispettive sfere separate in un movimento operaio basato sul ceto sociale. A ogni modo, non si raggiunse neanche questo grado di assimilazione; questi organizzatori lavoravano in un milieu completamente ebraico e mantenevano forti legami con la comunità ebraica. “Le loro azioni continuavano a essere in contraddizione con la loro ideologia. Più si impegnavano nel compito di organizzare i lavoratori ebrei, più stridenti diventavano nella loro insistenza sull’universalismo socialista” (Liebman 1979, 256-257).
Il divario tra retorica e realtà suggerisce fortemente l’importanza dell’inganno e dell’autoinganno in questo fenomeno. Infatti, questi organizzatori socialisti non abbandonarono mai la loro retorica universalista, ma si opposero attivamente all’integrazione dei loro sindacati nel più ampio movimento operaio americano persino quando, a seguito del calo dell’uso dello yiddish tra i loro membri, non avevano più scuse per non averlo fatto. Nei sindacati, facevano politica etnica per mantenere al potere il loro gruppo etnico (Liebman 1979, 270 segg.), azioni chiaramente in contraddizione con la retorica socialista. Alla fine, l’attaccamento di molti di questi individui al socialismo si indebolì
92
e fu rimpiazzato da un forte senso di etnicità e di appartenenza al popolo ebraico (Liebman 1979, 270).
Ne conseguì che la patina di universalismo serviva a coprire il continuo separatismo degli intellettuali e organizzatori politici radicali ebrei:
[Gli intellettuali gentili] non sono neanche accettati del tutto nella compagnia umanista laica dei loro amici ebrei di un tempo. Gli ebrei continuano a insistere in modi indiretti e spesso inspiegabili sulla loro unicità. L’universalismo ebraico nelle relazioni tra ebrei e non ebrei ha qualcosa di falso… Assistiamo tuttora all’anomalia di ebrei laici e atei che scrivono i propri libri di preghiera. Assistiamo a riformatori politici ebrei che troncano i rapporti con i loro partiti locali favoreggianti uno stile di politica etnico e promuovono obiettivi politici apparentemente universali – mentre organizzano i propri club politici che sono talmente ebraici in termini di stile e modi da far sentire a disagio i non ebrei. (Liebman 1973, 158)
L’universalismo può pertanto essere visto come meccanismo per la continuità ebraica attraverso il criptismo o il semi-criptismo. Il radicale ebreo risulta invisibile al gentile come ebreo, evitando pertanto l’antisemitismo, mentre conserva, nascosta, la sua identità ebraica. Lyons (1982, 73) osserva che “la maggior parte dei comunisti ebrei porta la propria ebraicità con molta disinvoltura, ma la sente profondamente. Per la maggior parte, non è un’ebraicità religiosa né istituzionale; ciò malgrado, ha le sue radici in una subcultura di identità, stile, linguaggio, e rete sociale…. In realtà, questa ebraicità di seconda generazione era antietnica, eppure costituiva la punta massima dell’etnicità. L’imperatore si credeva coperto da vesti trans-etniche e americane, ma i gentili vedevano le sfumature e i dettagli della sua nuda etnicità.”
Queste riflessioni indicano un elemento di criptismo – una disgiunzione autoingannatrice tra persona pubblica e privata – “un duplice atteggiarsi, mostrando un volto al mondo esterno e un altro alla tribù” (Horowitz 1997, 42). Ma questa attitudine comporta dei costi. Come fa notare Albert Memmi (1966, 236), “L’ebreo di sinistra paga questa protezione con la sua modestia e anonimità, la sua apparente indifferenza per tutto ciò che riguarda il suo popolo… Come il povero accolto in una famiglia borghese, si pretende da lui che abbia almeno il buon gusto di rendersi invisibile.” A causa della natura della propria ideologia, gli ebrei di sinistra si vedevano costretti a de-enfatizzare questioni specificamente ebraiche quali l’Olocausto e Israele, nonostante le loro forti identificazioni come ebrei (Wisse 1987). È proprio questa caratteristica dei movimenti ebraici di sinistra che risulta più odiosa agli ebrei etnicamenti impegnati (si veda, p. es., Wisse 1987).
93
L’identificazione etnica era spesso inconscia, il che suggerisce autoinganno. Nel suo campione di comunisti ebrei americani, Lyons fa notare che,
i dati riscontrati sono pervasi da prove dell’importanza dell’etnicità in generale e dell’ebraicità in particolare. Molti comunisti, per esempio, dichiarano che non avrebbero mai sposato una persona che non fosse di sinistra. Quando si interpellarono gli ebrei in merito a se avrebbero mai sposato una persona non ebrea, molti titubarono, sorpresi dalla domanda, e si trovarono in difficoltà a rispondere. Pensandoci, molti conclusero che avevano sempre dato per scontato il matrimonio con una persona ebrea. L’alternativa non era mai stata presa in considerazione, in particolare tra gli uomini ebrei.
Inoltre, ci furono consapevoli tentativi di inganno volti a rendere invisibile il coinvolgimento ebraico nei movimenti politici radicali, dando una sembianza americana a ciò che in realtà era un movimento prevalentemente ebraico (Liebman 1979, 527 segg.). Sia il Partito socialista sia il CPUSA facevano di tutto per mettere in mostra i leader gentili, e il CPUSA incoraggiava attivamente i suoi membri ebrei ad assumere nomi che potessero sembrare gentili. (Si assistette allo stesso fenomeno in Polonia [si veda sopra] e nell’Unione Sovietica [si veda p. 97].) Nonostante gli ebrei costituissero più della metà degli iscritti sia del Partito socialista sia del CPUSA in alcuni periodi, né l’uno né l’altro aveva mai presentato un ebreo come candidato presidenziale e nessun ebreo ricoprì l’incarico più alto nel CPUSA dopo il 1929. Si reclutavano gentili da luoghi remoti per ricoprire posizioni di alto rilievo nelle organizzazioni socialiste dominate dagli ebrei a New York. Non di rado la dominazione ebraica di queste organizzazioni portava i gentili a dimettersi quando si rendevano conto che il loro era un ruolo di facciata in un’organizzazione essenzialmente ebraica.
Liebman (1979, 561) fa notare che i radicali della nuova sinistra spesso facevano di tutto per ignorare completamente le questioni ebraiche. La nuova sinistra de-enfatizzava l’etnicità e la religione nella sua ideologia, mentre enfatizzava le categorie sociali e questioni politiche quali la guerra del Vietnam e la discriminazione contro i neri – questioni che creavano divisioni tra i bianchi gentili ma erano irrilevanti per l’identità ebraica; per di più, queste questioni non minacciavano gli interessi borghesi ebraici, specialmente il sionismo. L’identità ebraica, benché evidente per i partecipanti, era nascosta dal pubblico. E come si è notato sopra, quando la nuova sinistra cominciò ad adottare posizioni incompatibili con gli interessi ebraici, gli ebrei tendevano a recidere i propri legami con il movimento.
In una straordinaria illustrazione della percepita invisibilità delle dinamiche di gruppo relative al coinvolgimento ebraico nei movimenti politici radicali, Liebman (1979, 167) descrive gli attivisti studenti come completamente ignari del fatto che le loro azioni avrebbero potuto scatenare l’antisemitismo, data la sovrarappresentanza degli ebrei tra gli attivisti. (Liebman dimostra che altri ebrei infatti erano preoccupati che
94
le loro azioni provocassero l’antisemitismo.) Dal loro punto di vista, era un esercizio ben riuscito di criptismo: immaginavano che la loro ebraicità fosse completamente invisibile al mondo esterno, mentre essa continuava a mantenere per loro una significativa importanza soggettiva. Su un piano teorico, questo è un caso emblematico di autoinganno, considerato – in SAID (cap. 8) – come un’essenziale caratteristica dell’ideologia religiosa ebraica e delle reazioni all’antisemitismo.
A ogni modo, sembra che l’inganno sia generalmente fallito, se non per quanto riguarda la nuova sinistra, almeno per la vecchia sinistra. Tra gli intellettuali ebrei e quelli non ebrei nelle organizzazioni della vecchia sinistra radicale, i rapporti erano generalmente tutt’altro che buoni (C. Liebman 1973, 158-159). Alcuni intellettuali gentili erano attratti dal movimento proprio perché dominato dagli ebrei, ma più tipicamente il milieu essenzialmente ebraico si presentava come una barriera (Liebman 1979, 530 segg.). L’impegno ebraico di questi radicali, il loro desiderio di rimanere in un milieu ebraico e i loro atteggiamenti negativi verso la cultura cristiana gentile impedivano loro un efficace reclutamento tra la classe operaia gentile. Come scrisse il padre comunista di David Horowitz in un viaggio attraverso il Colorado negli anni ’30, “Ho la sensazione… di trovarmi in un paese straniero. E ho l’impressione che, salvo arriviamo a conoscere talmente bene la gente di questo paese da non sentirci così, non approderemo a nulla. Temo che la maggior parte di noi non sia veramente ‘patriottica,’ ovvero, profondamente attaccata al paese e alla gente.” Similmente, l’ex-comunista Sidney Hook (1987, 188) osservò che “era come se non avessero radici nella, o conoscenza della società americana che volevano trasformare.” Una situazione analoga si verificò in Polonia, dove perfino gli sforzi dei comunisti ebrei più de-etnicizzati erano osteggiati dai tradizionali atteggiamenti ebraici di superiorità ed estraniamento nei confronti della cultura polacca tradizionale (Schatz 1991, 119).
Una volta iscrittisi al partito, molti non ebrei erano ripugnati dall’ambiente molto intellettuale e lo lasciarono. Come previsto in base alla teoria dell’identità sociale e all’ipotesi che il radicalismo fosse in fondo una forma laica di giudaismo, ci sono indicazioni di un’atmosfera anti-gentile all’interno di queste organizzazioni: “Era anche presente tra gli intellettuali e i progressisti ebrei una combinazione di ostilità e superiorità verso i gentili” (Liebman 1979, 534). C’era anche un divario etnico tra lavoratori ebrei e neri del Partito comunista, dovuto, perlomeno in parte, a “un atteggiamento missionario e paternalistico” degli organizzatori ebrei (Lyons 1982, 80).
Gli incontri tra neri ed ebrei sembravano sempre caratterizzati dagli ebrei che tendevano la mano ai neri, “aiutandoli”, “insegnando loro”, “guidandoli”. Molti intellettuali neri posero fine alla breve relazione con il Partito comunista, amareggiati non solo dai comunisti ma anche dagli ebrei che, a loro avviso, li avevano trattati in modo condiscendente. “Come si può pretendere che il nero medio della scuola pubblica
95
comprenda le esigenze del sistema capitalista in relazione sia all’ebreo sia che al gentile in America… visto che entrambi i gruppi si comportano in modo curiosamente simile ad ariani hitleriani… quando si tratta di gente di colore?” si domandò Langston Hughes, amareggiato dopo un contrasto con dei comunisti ebrei. (Kaufman 1997, 110)
Questo senso di superiorità condiscendente dei radicali ebrei coinvolti nel movimento dei diritti civili è stato identificato come una fonte dell’attuale inasprimento dell’antisemitismo tra gli afroamericani.
CONCLUSIONE
È utile cercare di capire l’ultima sorte del giudaismo nelle situazioni in cui la società finì per essere organizzata secondo un’ideologia universalista politicamente radicale. Nell’Unione Sovietica, singoli ebrei “svolgevano un ruolo importante e talvolta determinate nella direzione dei tre principali partiti socialisti,” compresi i bolscevichi (Pinkus 1988, 42; si vedano anche Rothman & Lichter 1982; Shapiro 1961). Gli ebrei “dominavano” il primo Politburo (Rapoport 1990, 30). (Lenin stesso aveva un nonno materno ebreo [Volkogonov 1995] e avrebbe dichiarato che “un russo intelligente è quasi sempre un ebreo o qualcuno con sangue ebreo nelle vene” [in Pipes 1990, 352].) Gli ebrei costituivano una percentuale maggiore in altri partiti rivoluzionari russi rispetto a quella nel partito bolscevico (Lindemann 1997, 425 segg.). Infatti, ci sono indicazioni di uno scisma ebreo-gentile tra i bolscevichi e i menscevichi, maggiormente internazionalisti e nelle cui file militava una percentuale di ebrei molto più alta. (Si ricordi anche l’internazionalismo dei bolscevichi ebrei; si veda sopra.) Ciò nonostante, gli ebrei figuravano preminentemente tra i leader bolscevichi e nel movimento bolscevico – “citare il numero assoluto degli ebrei, o la loro percentuale del totale, significa non riconoscere certi fattori decisivi seppure intangibili: l’assertività e le capacità verbali spesso sbalorditive dei bolscevichi ebrei, la loro energia e la loro forza di convinzione” (p. 429). I bolscevichi ebrei erano inoltre più istruiti dei bolscevichi non ebrei e più inclini a essere poliglotti. (Come si è osservato nel capitolo 1, i radicali americani ebrei erano molto intelligenti, diligenti, impegnati e socialmente ambiziosi – caratteristiche che contribuivano indubbiamente al successo delle loro organizzazioni.) Dei i sette leader più importanti, quattro erano ebrei etnici (senza contare Lenin, il quale – come nota Lindemann – era un quarto ebreo e perciò sufficientemente ebreo da essere ritenuto sospetto nella Germania nazista; Lenin era considerato da molti un ebreo), come pure circa un terzo dei primi cinquanta leader.
96
Inoltre, Lindemann fa notare che diversi dei più importanti gentili nel movimento bolscevico potrebbero essere classificati come “giudaizzati non ebrei” – “un termine che, liberato dalle sue connotazioni sgradevoli, potrebbe essere usato per enfatizzare un punto spesso trascurato: anche in Russia c’erano dei non ebrei, bolscevichi o meno, che rispettavano gli ebrei, li lodavano abbondantemente, li imitavano, avevano a cuore il loro benessere, e instauravano con loro amicizie o relazioni romantiche” (p. 433). Lenin, per esempio, “lodava apertamente e ripetutamente il ruolo degli ebrei nel movimento rivoluzionario; era uno dei più inflessibili e lineari del partito nelle sue denunce dei pogrom e dell’antisemitismo in generale. Dopo la rivoluzione, ricusò la sua precedente opposizione al nazionalismo ebraico, accettando che sotto il regime sovietico la nazionalità ebraica fosse legittima. Sul letto di morte, Lenin parlò caldamente del menscevico ebreo Julius Martov, per il quale nutriva sempre un particolare affetto personale nonostante le loro forti divergenze ideologiche.”
Alludendo all’importante opera di Paul Johnson (1988), Lindemann segnala il ruolo “fondamentale” di Trotsky nella progettazione e nella conduzione dell’insorgenza bolscevica e il suo ruolo di “brillante dirigente militare” nella creazione dell’Esercito Rosso come forza militare (p. 448). Inoltre, molti tratti della sua personalità sono stereotipicamente ebraici:
Se si accetta che l’antisemitismo sia stato motivato fortemente dall’ansia e dalla paura, distinte dal disprezzo, allora la misura in cui Trotsky diventò fonte di preoccupazione tra gli antisemiti è significativa. Anche qui, le parole di Johnson sono suggestive: questi scrive del “potere demoniaco” – lo stesso termine, il che è rivelatore, usato ripetutamente da altri in relazione all’oratoria di Zinoviev o alla spietatezza di Uritsky.91 La sconfinata sicurezza in sé di Trotsky, la sua famigerata prepotenza, e il suo senso di superiorità erano altri tratti spesso associati agli ebrei. Su Trotsky e altri bolscevichi c’erano sì delle fantasie, ma c’erano pure delle realtà su cui crescevano le fantasie. (p. 448)
Vaksberg (1994) offre una presentazione particolarmente interessante. Egli fa notare, per esempio, che in un fotomontaggio dei leader bolscevichi realizzato nel 1920, 22 su 61 erano ebrei, “e l’immagine non includeva Kaganovich, Pyatniksky, Goloschchekin, e tanti altri che facevano parte della cerchia dirigente e la cui presenza su quella pagina dell’album avrebbe incrementato ulteriormente la percentuale degli ebrei” (p. 20). Oltre all’enorme sovrarappresentanza degli ebrei a questi livelli, tra i leader non ebrei (p. 49) c’era “una pletora di mogli ebree”, il che deve aver intensificato l’atmosfera ebraica dei più alti gradi del governo, dato che tutti, Stalin in particolare, sembravano
97
piuttosto attenti all’etnicità. (Lo stesso Stalin fece di tutto per scoraggiare il matrimonio di sua figlia con un ebreo e disapprovava altri matrimoni ebreo-gentili [Vaksberg 1994, 139].) Da parte loro, gli antisemiti accusavano gli ebrei di aver “impiantato quelli della propria categoria come mogli e mariti di personalità ufficiali e influenti” (in Kostyrchenko 1995, 272; corsivo nel testo). Questo punto corrisponde bene con la descrizione dei gentili bolscevichi come “non ebrei giudaizzati” offerta da Lindemann.
Tra i gentili russi era diffusa la percezione che “mentre tutti gli altri erano usciti in perdita dalla Rivoluzione, gli ebrei, e solo loro, se ne erano giovati” (Pipes 1993, 101), come indicato, per esempio, dalle misure ufficiali da parte del governo sovietico contro l’antisemitismo. Come nel caso della Polonia del secondo dopoguerra, gli ebrei erano considerati sostenitori affidabili del regime per via dell’enorme cambiamento del loro status apportato dalla rivoluzione (Vaksberg 1994, 60). Di conseguenza, l’immediato periodo postrivoluzionario era caratterizzato da un intenso antisemitismo, inclusi i numerosi pogrom condotti dall’Esercito bianco. Tuttavia, Stalin “decise di distruggere il ‘mito’ del ruolo decisivo degli ebrei nella progettazione, organizzazione e realizzazione della rivoluzione” e di sottolineare il ruolo dei russi (Vaksberg 1994, 82). Così come gli apologisti ebrei contemporanei, Stalin aveva interesse a minimizzare il ruolo degli ebrei nella rivoluzione, ma per motivi diversi.
Gli ebrei erano fortemente sovrarappresentati tra l’élite politica e culturale nell’Unione Sovietica durante gli anni ’20 (Ginsberg 1993, 53; Horowitz 1993, 83; Pipes 1993, 112) e, difatti, fino agli anni ’50 inoltrati, epoca delle epurazioni degli ebrei dall’élite economica e culturale (Kostyrchenko 1995).92 Io interpreto la tesi di Vaksberg (1994) su Stalin come un’insinuazione che Stalin fosse un antisemita sin dagli esordi, ma che, a causa della forte presenza di ebrei ai vertici del governo e in molti altri campi della società sovietica, come pure per la necessità di lusingare i governi occidentali, i suoi sforzi per eliminare gli ebrei dagli alti ranghi del governo procedevano solo lentamente, e si vide costretto a ricorrere pesantemente all’inganno. Perciò Stalin univa aperte dichiarazioni di filosemitismo ai provvedimenti contro gli ebrei, e spesso includeva qualche non ebreo per mascherare l’intento antiebraico. Per esempio, poco prima di una serie di processi in cui 11 dei 16 imputati erano ebrei, si svolse il processo ampiamente pubblicizzato di due non ebrei accusati di antisemitismo (p. 77). Nei processi degli ebrei, non si accennò all’etnicità ebraica e, con una sola eccezione, si rivolsero agli imputati usando unicamente i loro pseudonimi di partito (che non suonavano ebraici) anziché i loro nomi ebraici. Stalin continuava a elargire onori e premi agli artisti ebrei negli anni ’30, perfino nel mentre che rimuoveva i più alti leader politici ebrei, sostituendoli con dei gentili (si veda anche Rubenstein 1996, 272).
La campagna per rimuovere gli ebrei dagli incarichi amministrativi nell’establishment culturale risale addirittura al 1942, sempre accompagnata da premi e onori conferiti a
98
prestigiosi scienziati e artisti ebrei al fine di schivare accuse di antisemitismo. Il pieno antisemitismo promosso dallo Stato emerse nel secondo dopoguerra, con tanto di limitazioni numeriche delle ammissioni universitarie degli ebrei ben più severe di quelle esistenti ai tempi dello zar. Tuttavia, non si trattava solo dell’antisemitismo personale di Stalin; piuttosto, l’antisemitismo era motivato da preoccupazioni molto tradizionali inerenti agli ebrei, legate alla dominazione economica e culturale e alla lealtà. Kostyrchenko (1995) fa notare che i russi che cercavano di soppiantare gli ebrei nell’élite sovietica costituivano una delle maggiori fonti di pressione su Stalin. Si assistette a epurazioni di élite sproporzionatamente ebraiche nel giornalismo, nelle arti, nelle facoltà accademiche di storia, pedagogia, filosofia, scienze economiche, medicina e psichiatria, e negli istituti di ricerca scientifica in ogni campo delle scienze naturali. Ci furono anche delle epurazioni diffuse di ebrei ai più alti livelli di gestione e di ingegneria in ogni settore dell’economia. Gli intellettuali ebrei erano rappresentati come “cosmopoliti senza radici”, non solidali con la cultura nazionale russa, ed erano considerati sleali a causa del loro aperto entusiasmo per Israele e dei loro stretti rapporti con gli ebrei americani.
Gli ebrei erano anche molto sovrarappresentati come leader negli altri governi comunisti nell’Europa orientale nonché nei movimenti rivoluzionari comunisti in Germania e in Austria tra il 1918 e il 1923. Nel breve corso dell’amministrazione comunista in Ungheria nel 1919, il 95 percento delle figure più importanti nel governo di Bela Kun era costituito da ebrei (Pipes 1993, 112). Questo governo aveva vigorosamente eliminato i controrivoluzionari prevalentemente gentili, e la lotta che ne seguì portò all’esecuzione della maggior parte della dirigenza ebraica del governo comunista – una lotta con chiare connotazioni antisemitiche. Inoltre, gli agenti ebrei al servizio dell’Unione Sovietica figuravano in modo prominente nei partiti comunisti occidentali: “Anche tra le varie fazioni, spesso in violenta rivalità, dei nascenti partiti comunisti dell’Occidente, la questione degli ‘ebrei stranieri, agli ordini di Mosca’ diventava una questione scottante. Continuava a essere per lo più un tabù tra le file socialiste riferirsi agli agenti di Mosca come ebrei, ma l’implicazione era spesso che tali ebrei stranieri stessero distruggendo il socialismo occidentale” (Lindemann 1997, 435-436).
Gli ebrei pertanto riuscirono a conquistare posizioni di prominenza in queste società nella prime fasi, ma alla lunga, l’antisemitismo nell’Unione Sovietica e in altre società comuniste dell’Europa dell’Est diventò un fenomeno ben noto e un’importante causa politica tra gli ebrei americani (Sachar 1992; Woocher 1986). Come si è visto, Stalin ridusse gradualmente il potere degli ebrei nell’Unione Sovietica, e l’antisemitismo fu un fattore importante nel declino degli ebrei che ricoprivano posizioni di dirigenza nei governi comunisti dell’Europa dell’Est.
I casi dell’Ungheria e della Polonia sono particolarmente interessanti. Dato il ruolo dei comunisti ebrei nella Polonia postbellica, non sorprende che si sia sviluppato un movimento antisemitico che infine cacciò dal potere ‘la Generazione’ (si veda
99
Schatz 1991, 264 segg.). Dopo il discorso di destalinizzazione di Nikita Khrushchev del 1956, il partito si divise in una fazione ebraica e una antiebraica, con quest’ultima che denunciava l’eccessivo numero di ebrei ai vertici. A detta di un leader della fazione antiebraica, la preponderanza degli ebrei “fa sì che la gente odii gli ebrei e diffidi del partito. Gli ebrei alienano la gente dal partito e dall’Unione Sovietica: sono stati offesi i sentimenti nazionali, ed è dovere del partito adeguarsi alle richieste affinché i polacchi, e non gli ebrei, occupino le posizioni più importanti in Polonia” (in Schatz 1991, 268). Lo stesso Khrushchev appoggiò una nuova linea politica con il suo commento “Avete già troppi Abramovich” (in Schatz 1991, 272). Anche questa prima fase delle epurazioni ebraiche era accompagnata da incidenti antisemitici tra il pubblico generale, nonché da appelli affinché i comunisti ebrei che avevano cambiato nome per rendersi meno visibili nel partito si rivelassero. In seguito a questi cambiamenti oltre la metà degli ebrei polacchi scelse di emigrare in Israele tra il 1956 e il 1959.
Si assistette a un drammatico incremento dell’antisemitismo verso la fine degli anni ’60. Gli ebrei subirono un lento declassamento di status e i comunisti ebrei furono incolpati delle disgrazie della Polonia. I protocolli dei savi di Sion circolavano ampiamente tra gli attivisti del partito, studenti, e membri dell’esercito. Le forze di sicurezza, precedentemente dominate dagli ebrei e volte a sopprimere il nazionalismo polacco, erano ora dominate dai polacchi che vedevano gli ebrei “come un gruppo da sottoporre a stretta e costante vigilanza” (p. 290). Gli ebrei vennero rimossi dalle cariche importanti nel governo, nelle forze armate, e nei media. Si tenevano dossier dettagliati sugli ebrei, inclusi i cripto-ebrei che avevano cambiato nome e adottato identità esterne non ebraiche. Così come avevano fatto gli ebrei in precedenza, il gruppo antiebraico creò delle reti per promuovere la propria gente nel governo e nei media. Ora gli ebrei divennero dissidenti e disertori mentre prima avevano dominato le forze statali dell’ortodossia.
Nel 1968 arrivò il “terremoto” con una campagna antisemitica a seguito delle espressioni di giubilo tra gli ebrei per la vittoria di Israele nella Guerra dei sei giorni. Israele prevalse nonostante il sostegno sovietico degli arabi, e il presidente Gomulka condannò la “quinta colonna” ebraica del paese. Il paese fu spazzato da un’ondata di epurazioni degli ebrei e la vita ebraica laica (p. es., le riviste yiddish e le scuole e i campi estivi ebraici) fu essenzialmente smembrata. Questo odio verso gli ebrei era chiaramente una conseguenza del ruolo ricoperto dagli ebrei nella Polonia postbellica. Come descritto da un intellettuale, i problemi della Polonia derivavano essenzialmente dal conflitto etnico tra i polacchi e gli ebrei in cui gli ebrei erano appoggiati dai russi. I problemi erano dovuti a “l’arrivo nel nostro paese… di certi politici vestiti in uniformi da ufficiale, i quali poi pretendevano che solo loro – i Zambrowski, i Radkiewicz, i Berman – avessero il diritto al comando, al monopolio sul decidere cosa fosse vantaggioso per la nazione polacca.” La soluzione sarebbe arrivata ad avvenuta rettifica dell’“anormale composizione etnica” della società (in Schatz 1991, 306, 307).
100
Gli ebrei rimasti, “sia come collettività sia come individui… erano bersagliati, diffamati, ostracizzati, umiliati, minacciati e intimiditi con impressionante intensità e… malignità (p. 308). La maggior parte abbandonò la Polonia per Israele e fu costretta a rinunciare alla cittadinanza polacca. Lasciò dietro di sé solo poche migliaia di ebrei, per lo più anziani.
Il caso dell’Ungheria è completamente analogo a quello della Polonia sia nelle origini del trionfo degli ebrei comunisti sia nella loro sconfitta subita alla fine per mano di un movimento antisemita. Nonostante sia stato dimostrato che Stalin era antisemita, egli insediò dei comunisti ebrei come leader della sua impresa volta a dominare l’Ungheria dopo la seconda guerra mondiale. Il governo era “completamente dominato” dagli ebrei (Rothman & Lichter 1982, 89) – una percezione diffusa tra il popolo ungherese (si veda Irving 1981, 47 segg.). “Gli spiritosi di Budapest spiegavano la presenza di un singolo gentile tra i leader del partito sostenendo che ci voleva un ‘goy’ per accendere le luci il sabato” (Rothman & Lichter 1982, 89). Il Partito comunista ungherese, appoggiato dall’Esercito rosso, torturava, imprigionava e giustiziava i leader politici dell’opposizione e altri dissidenti e sfruttava l’economia ungherese a vantaggio dell’Unione Sovietica. Crearono pertanto una situazione analoga a quella della Polonia: gli ebrei furono insediati dai loro padroni russi come ideale strato intermedio tra un’élite regnante straniera sfruttatrice e una popolazione autoctona sottomessa. Gli ebrei erano visti come gli artefici della rivoluzione comunista che ne avevano beneficiato di più. Gli ebrei costituivano quasi tutta l’élite del partito, ricoprivano le più alte posizioni nelle forze dell’ordine e dominavano i ruoli dirigenziali in tutta l’economia. Non solo i funzionari comunisti e i dirigenti economici ebrei erano economicamente dominanti, sembrava anche che abbiano goduto di un accesso pressoché illimitato alle donne gentili che lavoravano per loro – in parte a causa della povertà in cui la stragrande maggioranza della popolazione era ridotta, e in parte per specifici programmi governativi mirati a sovvertire i costumi sessuali tradizionali, pagando, per esempio, perché le donne avessero figli illegittimi (si veda Irving 1981, 111). La dominazione della burocrazia ungherese comunista ebraica, pertanto, sembra aver avuto delle connotazioni di dominazione riproduttiva e sessuale dei gentili, in cui gli ebrei potevano godere di uno sproporzionato accesso sessuale alle donne gentili.
Come indicazione dell’abisso tra governante e governato in Ungheria, uno studente commentò: “Prendi l’Ungheria: Chi era il nemico? Per Rákosi [leader ebreo del Partito comunista ungherese] e la sua banda il nemico eravamo noi, il popolo ungherese. Credevano che gli ungheresi fossero fascisti per natura. Questo era l’atteggiamento dei comunisti ebrei, il gruppo di Mosca. Non nutrivano altro che disprezzo per il popolo” (in Irving 1981, 146). Il commento illustra un tema della questione di lealtà discussa in SAID (cap. 2): La slealtà ebraica nei confronti della gente tra cui vivevano era spesso esacerbata dall’antisemitismo, a sua volta legato ad altre fonti comuni di antisemitismo.
101
L’etnicità, inoltre, continuava a essere un fattore importante nel periodo postrivoluzionario malgrado la sua irrilevanza teorica. Quando i funzionari ebrei volevano penalizzare un agricoltore che non aveva raggiunto la sua quota, mandavano zingari a spogliare l’agricoltore della sua proprietà poiché gli altri abitanti non avrebbero partecipato alla distruzione di un consimile (Irving 1981, 132). Qui i funzionari del partito approfittavano dello stesso principio adottato da Stalin e altri governanti stranieri, ovvero l’avvalersi degli ebrei come strato sfruttatore tra se stessi e la popolazione autoctona sottomessa: le etnie straniere sono relativamente disposte a sfruttare gli altri gruppi. Non c’è da meravigliarsi pertanto che la rivolta ungherese del 1956 comprendesse elementi del pogrom antisemitico tradizionale, come indicato dagli atteggiamenti antiebraici tra i rifugiati dell’epoca. A questo riguardo, la rivolta non era dissimile a molti pogrom antisemitici verificatisi nelle società tradizionali quando il potere dell’élite governante straniera diminuì (si veda SAID, cap. 2; PTSDA, cap. 5).
Come per tutti gli esperimenti di vita, è possibile che l’ideologia universalista e la struttura politica di sinistra possano non raggiungere gli esiti voluti dai loro sostenitori ebrei.93 In base ai dati qui presentati, l’insuccesso conclusivo del radicalismo politico nel tutelare gli interessi ebraici risulta un importante fattore dell’abbandono, da parte degli ebrei, dei movimenti radicali o dei tentativi di combinare il radicalismo con un’identità ebraica aperta e un impegno verso gli interessi ebraici. A lungo termine, sembrerebbe che le ideologie di universalismo in presenza di una coesione di gruppo e di identità continuate non siano un meccanismo efficace per combattere l’antisemitismo.
Col senno di poi, la promozione ebraica di strutture sociali fortemente collettiviste quali il comunismo e il socialismo si è rivelata una strategia inefficace per il giudaismo in quanto strategia evolutiva di gruppo. Il giudaismo e il socialismo statalista e burocratico non sono ovviamente incompatibili, e si è visto che gli ebrei riuscirono a conquistare una posizione politica e culturale predominante nelle società socialiste come pure nelle società più individualiste. Tuttavia, la struttura fortemente autoritaria e collettivista di queste società consente anche un’istituzionalizzazione molto efficace dell’antisemitismo, laddove la predominanza ebraica all’interno della società – nonostante un alto grado di criptismo – arrivi a essere percepita negativamente.
Per di più, la tendenza di queste società a sviluppare una monocultura politica implica che il giudaismo possa sopravvivere solo ricorrendo al semi-criptismo. Come osserva Horowitz (1993, 86), “La vita ebraica è ridotta quando l’opposizione creativa tra sacro e laico, o tra Chiesa e Stato, è vista come costretta a sottomettersi a un insieme superiore di valori politici. Gli ebrei soffrono, il loro numero cala, e l’immigrazione diventa una soluzione di sopravvivenza quando lo Stato esige l’integrazione in una corrente maggioritaria nazionale, un universale religioso definito da una religione di Stato o quasi.” Alla lunga, l’individualismo radicale tra gentili e la frammentazione della cultura gentile offrono un ambiente più idoneo al giudaismo come
102
strategia evolutiva di gruppo, e infatti ciò rappresenta un’importante direzione dell’attuale attività intellettuale e politica ebraica (si vedano capp. 5-7).
In questo contesto, è interessante che molti intellettuali ebrei neoconservatori negli Stati Uniti di oggi abbiano respinto le ideologie stataliste e corporativiste come diretta conseguenza del riconoscimento del fatto che queste ideologie sono sfociate nell’antisemitismo corporativista di sponsorizzazione statale. Infatti, si possono ricondurre gli inizi del movimento neoconservatore ai processi di Mosca degli anni ’30 in cui molti dei vecchi bolscevichi, Trotsky incluso, vennero condannati per tradimento. Si formò di conseguenza un movimento di sinistra antistalinista, gli Intellettuali di New York, parte del quale si sarebbe gradualmente trasformata gradualmente nel neoconservatorismo (si veda cap. 6). Il movimento neoconservatore si è mostrato strenuamente anticomunista e si è opposto alle politiche delle quote etniche e dell’azione positiva negli Stati Uniti – politiche che precluderebbero chiaramente la concorrenza libera tra ebrei e gentili. Parte dell’attrattiva esercitata dal neoconservatorismo sugli ebrei si riscontra nella sua compatibilità con il sostegno a Israele in un periodo in cui i paesi del Terzo Mondo, appoggiati dalla maggioranza degli americani di sinistra, erano fortemente antisionisti (Rothman & Lichter 1982, 105). Molti intellettuali neoconservatori erano stati in precedenza ardenti sostenitori della sinistra, e la scissione tra questi ex alleati scatenò un’intensa faida intestina.
Allo stesso modo, da parte degli intellettuali converso c’era una tendenza a una prospettiva libertaria e individualista in seguito all’antisemitismo corporativista di sponsorizzazione statale e statalista durante l’epoca dell’Inquisizione. Castro (1971, 327 segg.) sottolinea la corrente libertaria, anarchica, individualista, e anti-corporativista del pensiero converso, e lo attribuisce al fatto che i converso erano oppressi da uno stato corporativista e liberticida. Questi intellettuali, oppressi dalle leggi sulla purezza del sangue e dalla stessa Inquisizione, sostenevano che “Dio non distingueva tra un cristiano e un altro” (Castro 1971, 333).
Quando un esperimento di ideologia e struttura politica fallisce, ne viene lanciato un altro. Dall’Illuminismo in poi, il giudaismo non costituisce un movimento unificato e monolitico. Il giudaismo consiste in una serie di esperimenti di vita, e dall’Illuminismo, ci sono stati vari esperimenti di vita ebraici. Chiaramente non sono mancati dissidi tra gli ebrei su come meglio raggiungere i loro obiettivi durante questo periodo, e sicuramente gli interessi dei radicali ebrei erano talvolta in conflitto con gli interessi degli ebrei benestanti (spesso i loro datori di lavoro [Levin 1977, 210]). La natura volontaria dell’associazione ebraica dall’Illuminismo in poi ha portato a un relativo sgretolamento del giudaismo, con individui ebrei attratti da diversi “esperimenti di vita ebraici.” In questo senso, il radicalismo ebraico deve essere considerato come una tra varie soluzioni al problema dello sviluppo di un giudaismo attuabile nel periodo postilluministico, insieme a sionismo, neo-ortodossia, giudaismo conservatore, giudaismo riformato, neoconservatorismo e giudaismo come religione civica. Nel seguente capitolo
103
vedremo come la psicoanalisi ha svolto un ruolo analogo tra un gran numero di intellettuali ebrei.


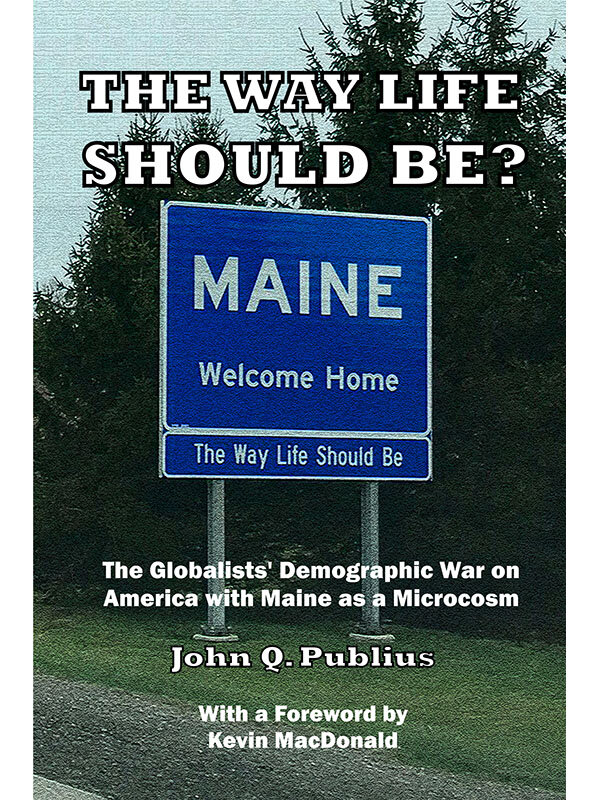
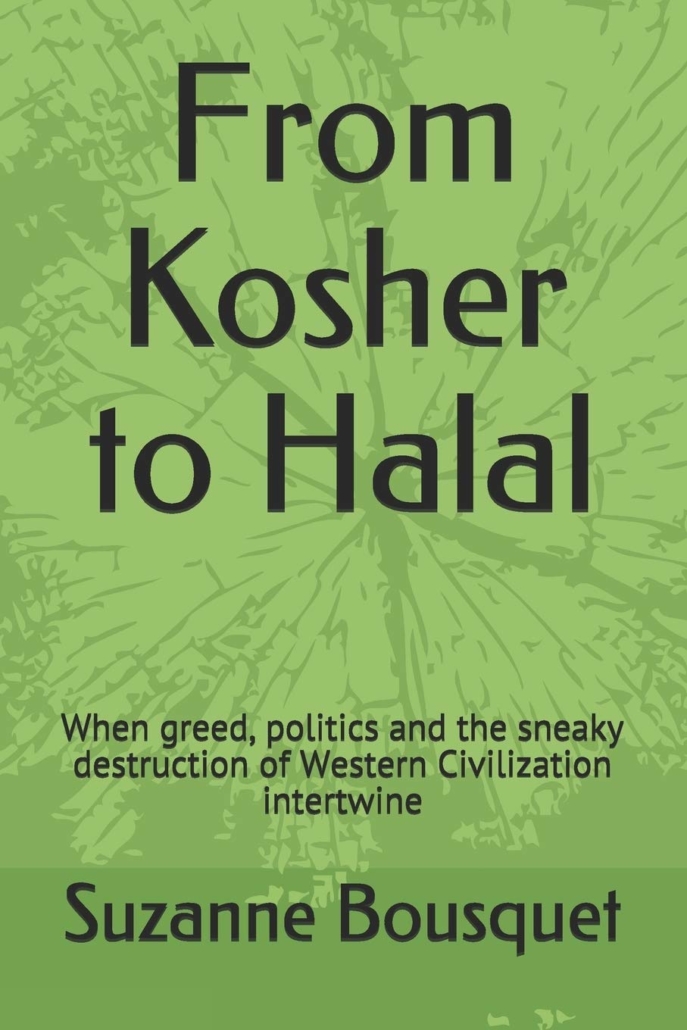



 When you want your ferret to have a better diet than the goyim
When you want your ferret to have a better diet than the goyim